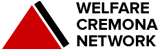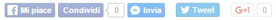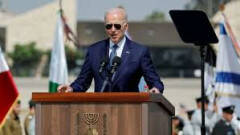La prospettiva di un ritorno dell’America a una politica estera multilateralista e al partenariato con l’Unione europea sembra trovare conferma nelle prime nomine annunciate da Joe Biden.
Il nuovo segretario di Stato, Antony Blinken, figlio di un diplomatico che ha fatto l’ambasciatore in due Paesi europei, ha trascorso una parte della sua infanzia in Francia ed è francofono. Inoltre, è stato consigliere di Barack Obama e vice di John Kerry e certamente vorrà ridare voce e responsabilità ai professionisti nel Dipartimento di Stato tanto strapazzato da Trump.
I Paesi europei possono sperare che siano finiti i tempi delle sanzioni secondarie, inflitte a chi non si allinea a misure punitive unilateralmente decise da Washington. E che l’accordo con l’Iran da loro voluto e mediato sia risuscitato – non sarà facile, visti gli umori del Congresso e l’irrigidimento di Teheran, ma la nomina di Jake Sullivan a consigliere di Biden per la Sicurezza, avendo lui contribuito a negoziare il Jcpoa, è di buon auspicio.
Ma possono sperare anche che l’attuazione delle politiche ambientali prospettate dall’Accordo di Parigi del 2016, e messa al centro dei programmi della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, non sia minata dal boicottaggio americano.
A questo proposito si deve dare per scontato che il Senato impedirà di adottare la legislazione federale necessaria, e che quindi l’Amministrazione Biden dovrà procedere mediante decreti, laddove ciò è consentito, e collaborando con gli Stati e le città a guida democratica. Ma la nomina di un politico del calibro di John Kerry, uno dei firmatari dell’Accordo di Parigi, a inviato speciale per il clima, con lo status di membro del governo, dimostra che il nuovo presidente intende operare un’inversione di rotta a 180 gradi rispetto al predecessore.
Solo idee o azioni concrete?
Il sostegno ai valori democratici e ai diritti umani fa indubbiamente parte della fisionomia della nuova Amministrazione, ma è difficile dire se ciò si tradurrà in azioni concrete. Vorrà Biden mettersi in contrasto con il turco Recep Tayyip Erdogan, o con l’indiano Narendra Modi, o ancora l’egiziano Abdel Fattah al-Sisi, o i monarchi del Golfo?
L’idea di un “summit delle Democrazie” è stato un tema della campagna elettorale ma si può essere scettici sulla sua realizzazione: che interesse può esserci a dover scegliere se escludere questi (e tanti altri) dittatori?
Molti esperti invitano a non illuderci che si vada verso una piena convergenza con gli interessi degli europei, dato che anche Biden si lascerà guidare dall’interesse nazionale americano. Ma ciò non significa che il cambiamento sarà solo di tono e non di sostanza.
Certo, ci verrà chiesta una scelta di campo nella competizione fra Stati Uniti e Cina. Secondo un articolo di Thomas Wright su The Atlantic, una politica di fermezza verso Pechino, imperniata su misure protezionistiche, investimenti mirati allo sganciamento (decoupling) dalla tecnologia cinese, l’accorciamento delle supply chain, sarebbe il modo migliore per trovare intese con i Repubblicani in Senato (o con quelli relativamente moderati) anche su altri temi, compresi i rapporti con gli alleati.
Richieste all’alleato europeo
Una maggiore indipendenza dalla tecnologia cinese, un atteggiamento meno ingenuo verso la Nuova Via della seta, o la rilocalizzazione di alcune industrie sarebbero nel nostro interesse, e non una dolorosa concessione all’alleato. Potrebbe poi esserci l’invito a una maggiore fermezza nei confronti di Mosca e critiche ai progetti infrastrutturali che aumentano la dipendenza dalla Russia in campo energetico, ma senza giungere a sanzioni contro la Germania per il completamento del Nord Stream 2. Contrasti sono prevedibili sulla digital tax, la tassazione dei giganti del web, e sulla carbon tax.
In sede Nato non verranno meno i periodici solleciti ad attuare la promessa di portare al 2% del Pil la spesa per la difesa, non diversamente da quanto avveniva ai tempi di Obama; ma se Germania e Italia rimarranno ben al di sotto di quella asticella, è poco verosimile che Washington ci imponga acquisti massicci di cacciabombardieri sotto minaccia di sanzioni.
Legittima è piuttosto l’aspettativa di un più equo burden-sharing nell’assumere responsabilità per la sicurezza dell’Occidente in regioni divenute non prioritarie per gli Stati Uniti. Anzitutto, nell’Africa sahariana e sub-sahariana, dove si gioca la principale partita contro il terrorismo di matrice islamista, e dove l’ingrato compito di reprimerlo non può essere lasciato alla sola Francia.
I motivi di ottimismo nella ricostituzione del partenariato con l’America di Biden prevalgono chiaramente sulle inevitabili divergenze. Il problema è un altro: il Partito repubblicano è ancora forte, deciso a prendersi la rivincita; e rimane dominato dal trumpismo. Se riconquisterà la Casa Bianca fra quattro anni, la nuova entente cordiale transatlantica sarà spazzata via.
Perciò nel dibattito fra la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer e il presidente francese Emmanuel Macron dovremmo dar ragione ad entrambi: a breve termine più alla prima, perché l’Europa della difesa, autosufficiente nelle tecnologie militari, la cyber-war e l’intelligence, non si costruisce in pochi mesi; pensando al medio-lungo termine più al secondo, perché non abbiamo alcuna garanzia che i futuri presidenti americani seguiranno la linea di Obama e di Biden.