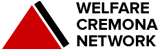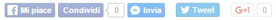LA FAVOLA A PUNTATE DEL TORRONE DI CREMONA | Agostino Melega
LA PREMESSA
Dal libro “Storia di Cremona” di Mario Monteverdi:
L’anno 1440, Filippo Maria Visconti, dopo aver
promessa la figlia Bianca Maria (foriera di
ricca e prestigiosa dote) a Francesco Sforza,
fortunato condottiero delle truppe Viscontee,
comincia a tergiversare e pare rimangiarsi la
parola data. Da buon capitano di ventura, lo
Sforza non ci pensa due volte e passa così ai
Veneziani, invadendo replicatamente il territorio
cremonese (ma senza prendere d’assalto la
città): le ostilità durano per tutto il 1440 e Filippo
Maria comincia a preoccuparsi seriamente della
cosa, tanto da far venire la figlia a Cremona
accompagnata dal Duca di Ferrara per poi
inviarla in quest’ultima città, onde intavolare
trattative con Francesco.
Le trattative evidentemente andarono bene e si conclusero con il matrimonio avvenuto fra lo sfolgorio di due grandi cortei, che accompagnarono gli sposi ad una chiesetta monastica di campagna, posta ad un paio di chilometri dalla città, curata dai monaci di San Gerolamo e dedicata ai Santi Sigismondo, Girolamo e Filippo.
Ed è lì, proprio in questo piccolo edificio sacro, che il 25 ottobre 1441 avvenne il matrimonio fra lo Sforza e Bianca Maria Visconti, nel luogo dove la pietà dei Duchi volle far sorgere, una ventina di anni più tardi, il sontuoso tempio di San Sigismondo, che divenne nel corso degli anni il supremo vanto della Scuola Pittorica cremonese del ‘500.
Si narra che i due sfavillanti cortei si fusero poi in uno solo al ritorno, passando tra due ali tripudianti di popolo. E dopo aver sostato nella chiesa di Sant’Agostino, gli sposi ducali andarono quindi a ricevere l’omaggio dei maggiorenti cittadini del Comune. Ed è fama che
insieme ai doni preziosi ed alle orazioni di
prammatica, fosse offerto agli sposi un
gigantesco dolce mandorlato plasmato
secondo la forma del Torrazzo, dolce che
quel momento prese il nome di ‘torrione’,
ovverossia di ‘torrone.
Collegata strettamente al pranzo di nozze di quella famosa unione sponsale, vi è la storia seguente del successo strepitoso del torrone di Cremona, e della fama che tale prodotto dolciario venne a conquistare poi nel campo della gastronomia nazionale ed internazionale.
Ed è proprio questa la vicenda che intendo narrare, avvolta nei suoi leggiadri contorni di favola. Ma essa, al di là degli apparenti contorni plasmati da una ipotetica mitologia, è ben incardinata in una vicenda vera e concreta, realmente avvenuta, in una dimensione d’incanto, sulla sponda lombarda che lambiva un tempo il grande fiume Po.
PRIMO QUADRO: L’INCONTRO CON FILIPPO MARIA VISCONTI
Il mio racconto inizia col rammentare la particolare situazione vissuta nell’inverno del 2021/22, quando il suono delle sirene segnalava frequentemente, alla gente di Cremona, il trasporto all’Ospedale Maggiore degli ammalati di Covid 19. Ed era proprio in quei duri frangenti l’abitudine pomeridiana, da parte dei coniugi Agostino e Rosella Melega, di portarsi a passeggiare sulla stradicciola alzaia che conduce verso la magnifica chiesa di San Sigismondo, avendo spesso all’orizzonte il profilo degli Appennini emiliani e più raramente anche quello delle Alpi.
Ebbene, su quel tratto d’asfalto lacerato, oltre ad avvertire l’ululato delle autolettighe in progressivo avvicinamento, era possibile osservare anche il passaggio degli automezzi di soccorso che sfrecciavano sulla via Giuseppina, con il loro dolente carico, diretti verso il locale nosocomio.
Ebbene, proprio in quel lungo periodo così raggelante, pregno di timori e d’affanno, era in qualche modo consolante osservare verso la campagna, da quella stessa strada vicinale, un folto gruppo di cicogne che ogni tardo pomeriggio s’involavano sulla testa dei viandanti, alzandosi da un canaletto di scolo per portarsi a raggiungere altri siti, posti però molto in alto, come ad esempio le antenne televisive che si ergono nei pressi dello stadio “Giovanni Zini”.
Proprio in quei momenti, intanto che portavamo a spasso la bella cagnolina Dezy dell’amica Ennia Ceriali Scotti, il mio pensiero era spinto a trasferirsi altrove, ossia verso una dimensione lontana nel tempo, che mi potesse stimolare ad allontanarmi da quel presente fastidioso, e per condurmi invece ad immaginare lontane vicende storiche, come quella avvenuta proprio su quello stesso viottolo golenale, in un giorno ben documentato dagli storici, ossia il 25 ottobre 1441, quando su quel medesimo selciato, era risuonato il calpestio degli zoccoli di un signorile corteo, formato da duemila ordinati armigeri a cavallo.
Ed ho così immaginato il quadro di quei fieri cavalleggieri, tutti ben schierati al galoppo, visibilmente onorati del loro compito, intanto che stavano accompagnando alle nozze, ordinati e risoluti, il loro signore di ventura, il famoso ed eccellentissimo Francesco Sforza condottiero.
Al fine d’offrire al lettore una chiave sintetica della sua figura, riferisco quanto gli storici ricordano, ossia che egli divenne nel tempo visconte di Cotignola e conte di Ariano, marchese della Marca Anconitana e gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, senza dimenticare il periodo nel quale egli esercitò pure il ruolo di capitano generale di una illustrissima lega.
E nel mentre immaginavo gli illustri fidanzati, che sarebbero divenuti di lì a poco novelli sposi, li vedevo precedere su una leggiadra carrozza, sempre in quel sorprende sogno ad occhi aperti, da uno folto schieramento di cavalieri suddivisi in due gruppi. Devo aggiungere che i due schieramenti, posti ad una certa distanza l’uno dall’altro, non mi hanno impedito di provare una piacevole impressione quando ho potuto osservare da vicino il viso della sedicenne Bianca Maria Visconti, la figlia di Filippo Maria, il turbolento signore di Milano. Nel mentre Francesco Sforza, davanti alla chiesetta, la stava attendendo, risoluto e fiero, fermo su Argo, il suo bellissimo cavallo bianco, che gli era stato ben pulito e sistemato a dovere dal capo stalliere Bisesto, chiamato così per la lunghezza anormale del suo piede destro, mentre altri davano a quel nomignolo ben altra e più intima interpretazione.
Incredibilmente potevo osservare tutto quel solenne corteo, lì davanti a me, come se io fossi al cinematografo, potendo persino accorgermi di alcuni particolari come in una sorta di primo piano filmico, come ad esempio l’attenzione che papà Filippo Visconti, anch’egli a cavallo, manteneva galoppando tenendo gli occhi ben attenti verso la propria figlia Bianca Maria seduta sulla carrozza nuziale, di lato accostata.
E mi ha impressionato veramente Filippo, che sembrava persino fosse, con quel suo burbero e serio cipiglio venato d’aristocratico distacco, addirittura lui lo sposo, e non invece Francesco, quell’arrivista armigero mercenario, al quale stava per consegnare dolentemente la figlia più cara.
Certo, gliela avrebbe data “in prestito” per poco tempo, questo era sicuro, o meglio per pochissimo tempo, perché il cinico padre aveva già architettato una rapida soluzione finale d’emergenza. Quello, che si sarebbe sancito nella chiesetta, era solo un legame da considerarsi provvisorio. Tale atteggiamento Filippo lo aveva preso in considerazione da subito, ovverossia che quel matrimonio dovesse rientrare solo in un mero e rapido disegno di pura tattica politica, rientrante in una strategia più ampia.
Personalmente sapevo dagli studi che Filippo era stato in effetti un tipo da prendersi con le molle, e credo a questo punto sia opportuno presentarlo in modo esaustivo ai lettori, essendo la sua figura destinata a svolgere un ruolo non secondario nel racconto che sto per iniziare.
Va subito precisato, allora, che al di là del tempestoso carattere, col quale tutti i santi giorni egli doveva fare i conti soprattutto con sé stesso, Filippo non era stato certo un uomo sprovvisto di vivace intelligenza. Certo, non era raro che si sfogasse rabbiosamente con i suoi notai e legulei, nonché con gli amministratori dei suoi beni, oltre che ovviamente col novero degli ufficiali del suo esercito. Insomma, va da sé che Filippo fosse, senza alcun dubbio, un uomo col quale non era certo facile fare i conti, sapendo però egli mantenere nel contempo buoni rapporti, tranquilli e costanti. Certo, tutti però a suo vantaggio. Se ne erano già ben accorti i Cremonesi, nella cui città, in quell’anno particolare del 1441, da non molto tempo, egli stesso aveva ripristinato il fermo dominio del proprio casato.
Fra le altre cose, guardandolo bene in viso, percepivo che Filippo Maria Visconti non avesse avuto a suo tempo una gran voglia di far permanere a lungo quella storia matrimoniale, quell’unione sponsale partorita dalle logiche di un freddo disegno politico. Lui, il gran signore di Milano, - aveva escogitato quell’unione solo in chiave utilitaristica, nel novero di una precisa strategia, come era d’uso d’altronde in quel tempo, ed in molti altri tempi della storia. Una strategia che consisteva semplicemente nel far diventare prestissimo vedova la giovanissima figlia.
Egli mi guardava come se avesse capito la mia intuizione, o meglio il mio disappunto, nel mentre pensavo che a suo tempo il Filippo non avesse fatto altro che usare la bella figlia illegittima, o meglio legittimata in seguito, la sedicenne Bianca Maria, come una gustosa esca, al pari del verme che si usa per far abboccare i pesci, o come si adoperano gli specchietti per poter attirare e prendere col fucile le allodole.
Nel nostro caso, o meglio nel caso di Filippo Visconti, l’allodola più succosa da spennare era proprio – secondo i suoi personali e particolari cinici criteri – quel bellimbusto, quello zerbinotto di capitano di ventura. Niente di più e niente di meno. Il resto era solo fuffa, una commediola da trasformare rapidamente in una piccola ed insignificante tragedia teatrale, destinata solo alla curiosità dei balordi e dei caratteri languidi, o ancor meglio da ricordare ai posteri come una farsa per divertire quei pochi cervelli curiosi e compiacenti, provvisti del gusto sagace e vero della vita.
Ed il Filippo aveva già predisposto, dove e come sarebbe dovuta finire la festicciola, a compendio di una storia per nulla amorosa.
Tant’è vero che quella sconsiderata anima di Filippo Visconti mi fece pure l’occhiolino, come se avesse voluto coinvolgermi a posteriori nel suo piano perverso. Un progetto criminoso che, per fortuna, non era certo una sorpresa da parte mia. Già conoscevo bene questa trama, ossia il disegno di far terminare quella messa in scena, al termine del matrimonio, di quella farsa, in quella stessa e medesima notte. Certo con tutta la serietà, professionalità e cura del caso, per mano non certo di un imbecille, ma d’un bravo pugnalatore professionista, di un sicario avveduto ed esperto, pagato fra l’altro molto bene, fatto giungere appositamente dai calli di Venezia.
Questi era un tizio robusto e barbuto, che si era trovato in piena bancarotta, per una vendita andata male di maiali non più pagati da parte di un suo cliente bolognese. Tale tipo della malavita era chiamato dai più Ruzante, e di lì a breve sarebbe stato arrestato e rinchiuso nei piombi della città lagunare.
Va aggiunto per chiarezza, o “per inciso”, come diceva il mio caro amico Maspero Gatti, che quel personaggio della “leggera” veneziana, nonostante quel nome, non era, come si ipotizzò in seguito, il capostipite della linea di parentela comprendente Angelo Beolco, il grande drammaturgo, attore e scrittore patavino, chiamato appunto “il Ruzante”, nato qualche secolo più tardi.
Va precisato inoltre, come ho avuto modo d’appurare su diversi testi, che le cronache successive non chiariscono se il Visconti avesse progettato l’esecuzione dell’omicidio fissandolo in un particolare e preciso tempo, ossia se avesse deciso che avvenisse appena prima, o durante o dopo le tenerezze amorose fra i due sposi, durante la prima notte di nozze.
E per la curiosità che mi macinava dentro, sono stato talmente ingenuo da farmi uscire dalla bocca questa imbarazzante domanda. E lui, il Filippo, per tutta risposta, mi ha replicato, con un viso da bischero, che gli era sempre molto piaciuta la scena del quinto canto della Divina Commedia, dove il grande Dante Alighieri narra ai lettori l’ambiente tetro del cerchio dei lussuriosi, dove colloca i due famosi amanti presi nel sacco, Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, sistemati a dovere per essere stati colti in “flagranza amorosa”, e mandati all’altro mondo, subitamente, da parte dell’imbufalito marito cornificato dalla moglie.
Quell’arguto e sorridente Filippo, ha voluto pure confidarmi: “Io avrei fatto la stessissima cosa” e poi per dimostrami che la sua memoria di fantasma non era per niente invecchiata, si è messo pure a recitarmi il passo dantesco:
“Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.
Mi sono permesso allora di aggiungere a quell’ombra strana, fuori dall’ordinario, che si era ugualmente insinuato nella mia mente il fatto che, l’episodio dei due amanti citati da Dante, non era per nessuna ragione confrontabile con quello di Francesco e Bianca. Lo Sforza condottiero non aveva tradito proprio nessuno, per quello che modestamente avevo letto e studiato. In questo caso a tradire veramente era stato solo lui, Filippo, quell’ombra seduta con me.
Il Francesco, per quello che ero venuto a sapere, non era stato un produttore di corna, né prima del matrimonio né dopo. Anzi. Ed il Filippo, che mi guardava fisso negli occhi, non poteva ritenersi come una sorta di marito cornuto, ma solo e semplicemente come un padre semplicemente geloso, con però evidenti e preoccupanti turbe incestuose in testa. E Francesco Sforza, sempre da quello che avevo studiato, avrebbe voluto andare solo a letto tranquillo la prima notte di nozze, come capita a tutti i novelli sposi, pur avendo la consapevolezza d’essersi imparentato con una sorta di suocero non poco strano e forse un tantino geloso.
Ed allora non mi è parso vero di aggiungere, di fronte all’anima di quell’antico signore di Milano, di aver provato un grande piacere quando ho letto che Francesco abbia trascorso, quella prima volta, una bella e tranquilla per modo di dire, nottata d’amore con la sua giovane sposa.
Ed ancora adesso, mentre sto scrivendo, rifletto e mi dico: ”Cosa ti è venuto in mente, Ago?” Infatti non l’avessi mai detto! Il Filippo s’è incavolato oltre misura, o meglio si è imbufalito in un modo incredibile e pirotecnico. E mi ha fatto venire subito in mente l’allenatore Giovanni Trapattoni in panchina, quando gettava via dalla rabbia tutto quello che gli capitava per i piedi.
Il Filippo furioso si è messo allora ad offendermi, affermando che lui, la Divina Commedia, la conosceva benissimo e che io ero semplicemente un pirla nel voler confondere le cose ed i piani di lettura. E mi ha aggiunto che egli non aveva avuta la ben che minima intenzione di far chiudere le palpebre per sempre alla sua “figlioletta” (proprio così me l’ha definita).
“Ma scherziamo?”, pareva mi volesse dire col suo viso costernato ed iracondo. Sembrava che egli volesse spiegarmi, farfugliando, che avrebbe voluto a quel tempo, solo e semplicemente, levare di torno quel presuntuoso comandante di balordi, quell’assatanato di potere, quel Francesco ambizioso cresciuto male, quel Cèco della malora, quell’impiastro di condottiero da strapazzo, che non seguiva di certo il canto armonioso dell’amore, ma solo quello delle fredde e putride palanche.
Ma proprio in quel momento passò di lì sulle nostre teste un ibis, un uccello del Nilo, che mi sembrava pronunciasse una parola sola, volandogli radente sul capo: “Büšiàader”, ossia “bugiardo”!!! Filippo allora di scatto, incavolato nero, prese immediatamente in mano un arco, dimenticandosi per un attimo d’essere solo un fantasma, scordando pure che quell’arma che aveva preso in mano era fatta solo di fantasia, così come allo stesso modo la freccia. E l’ibis si è potuto così allontanare pacifico e tranquillo, seguito poi dal volo di tre splendide cicogne.
A quel punto, ho osato chiedere a Filippo quando il sicario avrebbe dovuto intervenire per risolvere il problema, il cosiddetto “affare”. Ma il Visconti non ha voluto rispondermi, cambiando invece discorso, dicendomi soltanto che non gli sarebbe proprio interessato un fico secco... Sì, che sarebbe stato del tutto indifferente per lui se, quel “maramaldo Cèco”, avesse avuto il tempo di dare qualche furtivo bacio a sua figlia o qualche carezza. Niente di più però. Niente altri approfondimenti, insomma. Egli mi disse poi, con uno sfogo che mi sembrava un rantolo, di aver avuta solo molta fiducia, purtroppo mal riposta, su quel finto cameriere assoldato a Venezia fra gli avanzi di galera, al quale aveva già pagato metà della commessa in anticipo. Questo buono a niente non avrebbe dovuto far altro che sistemare a puntino e per sempre le cose, ovvero far fuori dalle spese, semplicemente, “quel condottiero del cavolo”, come Filippo chiamava lo Sforza con disprezzo, aggiungendo inoltre e precisamente per inquadrarmelo bene: “Quel finto condottiero saltellante come un merlo da una parte all’altra degli schieramenti politici e territoriali, per mettersi nelle proprie lorde tasche bucate degli sporchi dané”.
Tale “condottiero degli stivali” - questo è sempre il pensiero furente, confidatomi dal padre della promessa sposa - non avrebbe più dovuto alzarsi con le proprie gambe, ma rimanere disteso per sempre, prima nel suo letto e poi all’interno di una bella e lussuosa cassa da morto, forgiata con legno di quercia.
E da Cremona sarebbe stato poi trasportata, la bara, con tutti gli onori al cimitero di Milano, senza far mancare tutta una gran folla attorno, tributante gli onori dovuti al genero di un grande Visconti, e con tanti fiori ed insegne svolazzanti, senza dimenticare le tantissime preghiere pagate con soldi buoni alle prefiche, insufficienti comunque a precludergli un destino segnato dal fato, vale a dire senza quindi una prevedibile sosta provvisoria in Purgatorio, ma con un volo diretto e filato verso la parte più profonda dell’Inferno.
Sì, avrebbe dovuto essere spedito via velocemente, come un pacco-dono, verso la mitica città di Dite. “Verso quella leggiadra città - mi ha voluto precisare il sarcastico Filippo - che si apre dopo il quinto cerchio dell’Inferno”.
Insomma, nella sua testa di stratega aveva previsto un minuzioso programma civile e funerario veramente lusinghiero, da prima pagina dei giornali moderni.
E poi, all’improvviso, quell’anima contorta del mio interlocutore fantasmatico, che era evidente non stesse vivendo bene - e c’era da capirlo - quella situazione di acuta insoddisfazione, mi ha chiesto pure un parere. Ovvero se fossi anch’io dell’avviso che era stata veramente una delicatezza pensare allo spegnimento precoce della vita di Francesco Sforza. Con una morte che prima o poi sarebbe comunque dovuta avvenire. Uno spegnimento della vita progettato, fra l’altro, in un luogo patrizio, non in una suburra, in un posto insomma veramente degno e prestigioso. Non quindi per la strada o in una losca bettola, come era invece costume diffuso in quel tempo.
Egli ha poi cercato di convincermi che la morte anticipata solo di qualche decennio, nello splendido Castello di Santa Croce, avrebbe dovuto essere considerata, da attenti osservatori, né più né meno che un dono, o meglio una delicatezza, ovvero il segno d’un aristocratico ed onorevole distacco e commiato.
Insomma, per farla breve, quell’ombra tarata da qualche evidente disturbo mentale, dovuto forse alla vecchiaia, o a qualche maltrattamento nel suo mondo di spiriti incavolati, di anime nervose, o di fantasmi dispettosi, mi chiedeva se ritenessi anch’io che sarebbe stata una morte confortevole se fosse veramente avvenuta nel prestigioso e nobile luogo del castello di Santa Croce di Cremona.
Ed allora mi è scappato di bocca il pensiero che le cose, per fortuna, andarono in modo ben diverso rispetto a quel disegno perverso messo in campo. Non l’avessi mai detto. Quel filantropo di Filippo, quell’apostolo di umanesimo, mi ha fatto allora una scenata collerica, urlando che non saremmo stati mai più amici.
Ed allora non ho potuto fare a meno di rispondergli per le rime, dicendo con semplicità che Francesco, evidentemente, si fidava del padre della sua imminente sposa allo stesso modo col quale Gesù si era fidato del diavolo nel deserto.
E gli ho pure aggiunto: “Ma piuttosto, intanto che siamo qui, sempre che lei me lo conceda, sarei lieto se mi raccontasse come andarono veramente i fatti, perché ogni storico - ed è logico – racconta le cose secondo le fonti studiate, ed a volte pure con delle intuizioni che si avvicinano per certi versi alla verità. Ma la verità, quella vera, il più delle volte, è sempre difficile conoscere davvero”.
Ed ho aggiunto a quell’anima, che mi stavo accorgendo si stesse stancando del mio ragionare: “Guardi, io mi siedo su quella panchina posta a cento metri dalla chiesa, se lei vuole essere così gentile nel seguirmi e di raccontarmi quello che sa, io la ascolterei con calma e pazienza”.
Con mia somma sorpresa, quell’anima mi ha guardato freddamente ed ha chinato il capo, come per dirmi di sì. Poi mi ha seguito e ci siamo seduti, ed egli ha iniziato a parlarmi sottovoce. Non vi dico la faccia di qualche passante che mi ha guardato in modo stupito per non dire strano, nel mentre io chinavo di tanto in tanto il capo in chiave d’assenso, per quello che mi stava raccontando il Visconti, il mitico Filippo.
Ed infatti, con estrema calma, il padre di Bianca Maria mi ha confidato che il giorno del matrimonio si era portato dietro, oltre ai suoi fidati soldati, anche cuochi, camerieri e cameriere provenienti dalle valli bergamasche. E che era passato a collocarli negli ambienti del Castello di Santa Croce, il giorno prima della cerimonia nuziale. I servitori in servizio permanente presso quello stesso fortilizio, li aveva invece mandati tutti a casa in “licenza premio”, e li aveva sostituiti con della sua fedelissima gente cooptata per l’occasione.
Ma al di là dei timori nei confronti di Filippo, di quello “suocero promesso” dalla testa di bischero, di quel bizzarro uomo, signore comunque di non poco conto, con il quale Francesco si stava ormai imparentando, vi era pure il desiderio da parte del condottiero di non fare brutta figura con tutta la schiera rilevante d’invitati che sarebbero giunti da tutte le parti e le corti d’Europa.
Il banchetto era stato programmato all’aperto, lungo i campi a prato attorno alla chiesetta curata dai frati di San Gerolamo, posti su un rialzo naturale del terreno, dal quale era possibile godere la vista del magico fluire del Po. Ma la “cabina di regia”, di tutto quell’insieme di preparativi, era stata collocata all’interno del bastione di Porta Mosa, dove si erano portati, sin dall’arrivo a Cremona, gli ufficiali e i soldati mercenari dello Sforza.
Anche Bianca Maria, il giorno prima del matrimonio, aveva voluto visitare tale arroccamento militare difensivo, che poté vedere così per la prima volta, e che avrebbe più accuratamente conosciuto in seguito, quando da quegli stessi spalti avrebbe guidato, in un momento fortemente critico, la risposta vincente degli Sforza e dei Cremonesi sui Veneziani assalitori.
Ma torniamo al banchetto nuziale, per dire che fra il personale di cuochi e dei servitori, fra quegli aiutanti domestici della corte viscontea, vi era pure una ragazza chiamata Tersilla, figlia di Giordana, l’anziana balia di Bianca Maria, conosciuta da tutti come Ninòn, originaria di Annicco, il borgo dove una trentina di anni prima era stato catturato Cabrino Fondulo, il tiranno di Cremona, “capitozzato” poi, come si sa, a Milano.
Tersilla aveva un dono particolare, perché era come provvista di particolari percezioni mentali, con le quali coglieva in anticipo se l’aria fosse pulita o se ci fosse nei dintorni qualche contorto inghippo, dal quale dover prontamente difendersi. Tant’è vero che qualcuno la chiamava addirittura stròlega, ossia fattucchiera, con un termine dialettale col quale s’intende di solito una donna considerata a metà strada fra l’immagine della maga e quello della strega. Na magòta, insomma, per dirla in dialetto. E come avvenuto altre volte, la Ninòn si accorse subito che qualcosa fra la gente addetta ai forni non quadrava nel dovuto modo. Sentiva dentro di sé un palpitante allarme. Così informò subito il suo Cechìno (Franceschino), come lo chiamava sin dal tempo in cui lo aveva allattato, accanto a suo figlio Sergio detto Ciùma, quando ne teneva uno attaccato ad una mammella ed il secondo all’altra.
E subito dopo Ninòn e Francesco pensarono bene di far assaggiare le varie portate del pranzo “sperimentale”, quello predisposto il giorno prima del matrimonio, ad alcuni tizi prelevati preventivamente dalle locali prigioni.
Costatando, subito dopo gli assaggi, che non si fosse nessuno steso a terra in mezzo alle convulsioni, come spesso avveniva agli “assaggiatori coatti”, si convenne invece nell’assoluta risposta positiva da parte di quelle cavie umane, venendo così confermata l’assoluta mancanza di veleno negli ingredienti dei vari piatti. Così il giorno dopo, quello del matrimonio, o meglio quello del pranzo degli sposi, si diede l’avvio in modo del tutto tranquillo alla distribuzione delle portate, glorificando, con l’appetito progressivo degli invitati, la solenne e sontuosa abbuffata nuziale, nel mentre parecchi musici attorno deliziavano con i loro strumenti quella grande festa. Bianca Maria non solo era molto contenta. Era semplicemente estasiata.
Per quella prima notte di nozze, Francesco che non si fidava, con giusta ragione, dei movimenti e degli intenti del proprio suocero Filippo, e così fece predisporre una tenda nuziale nel sito dove oggi si trova il giardino di porta Mosa. E fu proprio lì che Francesco conobbe il corpo e l’anima di Bianca Maria.
E la storia del torrone? Per questa bella epica dolciaria, e per il simbolo di una delle tre famose T della città del Torrazzo, bisognerà fare un passo indietro. Ma per questo ci sarà solo da attendere il prossimo abbozzo su questa stessa rete, fra circa un mese.
Intanto quello che posso sin d’ora aggiungere è il fatto significativo che Cremona ha voluto onorare nel tempo il ricordo dei due sposi ducali, dedicando loro due diversi spazi viari e precisamente “Largo Bianca Maria Visconti”, con lo spiazzo antistante la chiesa di San Sigismondo, ed immortalando invece “Francesco Sforza condottiero” con la dedica presente nella terza strada a destra di via Giuseppina.
Segue
Agostino Melega Cremona
Gennaio 2022