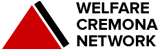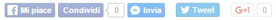L’EcoPolitica Primarie del PD God bless the left
Si è molto discusso sul plafond della partecipazione alla quinta tornata di Primarie del PD. E’ del tutto evidente che più vasta è e più rimarchevole è da intendersi come espressione del coinvolgimento di fasce di opinione pubblica. Che tale standard possa essere percepito anche come segnalatore di un consenso destinato necessariamente a ripetersi nella “bella” è tutto da verificare.
D’altro lato, è arcinoto che la loro importazione, dal modello politico-istituzionale nord-americano, nell’ordinamento italiano rappresenti una forzatura più che innovazione.
Perché, un quindicennio fa, il sistema italiano era ancora significativamente influenzato dai canoni dell’associazionismo di massa; mentre le primarie vere afferiscono ad un modello in cui i partiti erano e sono poco più che un aggregato, controllato da oligarchie e finalizzato all’éspace d’un matin di tornate elettorali. Finite le quali, si sbaracca ed il cosiddetto “party” torna ad essere quell’entità effimera di prima. Le tendenze incardinate dai cuscus, dalle primarie, dalle presidentials della recente stagione politco-elettorale nord-americana dovrebbero inequivocabilmente dimostrare, per il benessere della democrazia, che sottrarre lo strapotere di candidatura in capo alle potenti oligarchie interne ed esterne non basta più (a meno che si voglia favorire il populismo ed altro).
Se il ragionamento vale per il sistema che le ha prodotte, figurarsi se è congruente all’analisi di un modello, quello italiano ed in particolare del campo di centro-sinistra che le ha adottate (diciamo con un certo sprezzo della realtà) ad usum delphini.
Che era, dopo aver spianato completamente le macerie di quel che restava dei partiti di massa (e popolari), assumerne anche la liturgia. E’ pur vero che con Veltroni il post-comunismo italiano ripudiava l’ideologismo ed adottava il pensiero liquido e la politica leggera. E’ pur vero che l’effetto discendente fu quell’ondata di disaffezione contraddistinta dagli inconfondibili profili di un aggregato più simile ad un comitato d’affari di cariche e prebende che non ad una comunità di testimonianza civile. Ed, infine, è pur vero che le Primarie di rito dem italiano, oltre che fare “fine”, new vogue, hanno costituito un’occasione di fidelizzazione dall’alto verso il basso, piuttosto che partecipazione in senso contrario.
Insomma siamo di fronte, non già ad una eterogenesi dei fini (che presupporrebbe chiarezza di fini e non, come nell’attuale contesto, la quasi totale assenza di obiettivi di lungo respiro), ma ad una manifesta empasse. Da cui non si esce e non si uscirà, fintanto che resteranno sospese alcune variabili. A cominciare dalla correlazione di fondo tra sistema maggioritario (o semipresidenzialistico che dir si voglia) ed impostazione dell’organizzazione partitica. Mentre, ora, come si sa, siamo al centro del guado: sospesi tra una cultura del maggioritario inattuata e neanche poi rimpianta (che sarebbe speculare all’adozione del modello anglosassone) e la riadozione del parlamentarismo di doppio cameralismo espresso col sistema proporzionale (che sarebbe più congruo ai riti del vetero partecipazionismo assembleare).
Tertium non datur! Volendoci lavorare attorno, per un impulso teorico, si potrebbe approdare, però, alle stesse conclusioni di una recente riflessione del prof. Sabino Cassese “Le primarie non sono un segno di forza, bensì di debolezza del partito” In quanto lo destrutturano in quanto rendono marginale la partecipazione all’elaborazione dei progetti politici. In materia, ancor più perentoria è la stroncatura del candidato centrista alle presidenziali francesi, Macron: “un’aberrazione, uccidono le idee e impediscono di governare”.
Sia quel che sia, il fatto è che siamo immersi in una temperie caratterizzata da un tratto politico senza qualità che ha come corollario una gestione del potere che scorre via lungo una sottile linea rossa che divide il bene dal male e che appare del tutto impermeabile a qualsiasi resipiscente correzione.
La primarie del 30 aprile 2017, nell’attesa che il relativo istituto venga correlato agli esiti di nuova stagione riformista delle istituzioni e dell’organizzazione della partecipazione e della rappresentanza, vanno percepite come quell’opportunità minimale che sono: un’occasione per gli iscritti al PD e per i potenziali appartenenti al campo di centro-sinistra di esprimersi sul senso della candidatura alla leader/premiership e sul correlato (per quanto molto semplificato) programma politico.
E’ in riferimento a tale minimale interpretazione dell’istituto delle primarie negli attuali contesti che affrontiamo una riflessione attorno a quelle del 30 aprile.
Amaramente constatando (con Benigini e Toisi) che “non ci resta che piangere”, invochiamo, almeno nel titolo, superiori benevolenze sui destini della sinistra italiana.
Tra meno di quarantotto ore si apriranno, dunque, i seggi delle “primarie”. Cui, in forza di quella premessa che, obbliga (almeno moralmente) gli interessati a votare alle primarie, la dichiarazione dell’intenzione di votare per quel partito, parteciperemo senza esitazione. Di dichiarare la nostra intenzione di votare PD; che è sincera ma subordinata alla circostanza dell’eventuali assenza dalla scheda elettorale di una lista socialista.
Anche se, lo ammettiamo, hanno contribuito a confonderci le idee alcuni endorsements, di cui di seguito diamo conto.
Ma non prima di aver configurato lo spirito, donde, secondo noi, discendono; vale a dire l’aderenza all’aforisma di Wilde: “C’è soltanto una cosa al mondo peggior del far parlare di sé, il non far parlare di sé”.
Un’ansia che impone, da tempo, ai players degli attuali contesti politici di intervenire non per, ma contro e comunque per certificare la propria esistenza.
Cominciamo da Eugenio Scalfari: “Perché alle primarie non voto per Renzi. Vincerà ma non deve stravincere. E dopo dovrebbe dedicare le sue energie alla missione di fare l’Europa sempre più forte.
Pur essendo sicuro che vincerà, preferisco che la sua vittoria non sia un plebiscito. Mi dispiace che vinca? No, anzi vedrei con dispiacere che perdesse. La politica è la scienza della flessibilità. Un Renzi che vinca il 30 aprile ma non stravinca è quanto di meglio secondo me possa accadere poiché fa aumentare il peso dell’opinione pubblica.”
Il competitor Orlando, dopo il cantus ad introitum “Solo se prevalgo non ci saranno altre scissioni”, la prende su non esattamente leggera :“Le larghe intese? Improponibili. Premio di coalizione per escluderle”
L’altro competitor Emiliano si limita ad un: “Mi appello agli anti Matteo d’Italia. Lui ha perso: è Hollande, non Macron. Per riuscire a mandarlo via votino per me pure i non dem” Se vinco io, dovrà solo maledire la sua sorte”.
Prima di questi pronunciamenti da parte dei protagonisti delle primarie, c’erano stati gli addii. Gli addii palingenetici scanditi dalla ricerca di una “bella morte”. Si ricorderà quel “No al partito del capo, bisogna uscire in fretta. Il nostro più che un addio è un arrivederci“ di Guglielmo Epifani (già segretario della CGIL e socialista) dixit.
Potremmo azzardare di essere di fronte ad un’evidente intelligenza parallela tra i candidati alternativi, interessati a far lievitare le loro quote nei futuri organi del partito e a ridimensionare il vincitore, e gli scissionisti, attratti dall’idea di dare una mano agli antirenziani. Per mettere in difficoltà il personaggio in odio al quale hanno lasciato il partito e per logorarne la leadership. Per revocarla o quanto meno per depotenziarla.
Eppure non fu, almeno a parole o forse, azzardiamo, nei proponimenti dettati, sempre così.
“C’è una squadra sola, io sono nel Pd e rispetto il segretario che il Pd elegge. lavorerò con grande lealtà per la ditta…”, queste le esatte parole che Pier Luigi
Bersani da Bettola (provincia di Piacenza) pronunciò subito dopo l’avvento di Matteo Renzi alla segreteria del suo partito a dicembre del 2013.
Poi, come è andata a finire è cosa arcinota.
A prescindere dalla piena libertà di pensiero, siamo indotti a chiederci e a chiedere se tali profili preconcetti e pregiudiziali siano in linea con quello che dovrebbe essere il gentlemen agreement alla base di qualsiasi appartenenza.
Nella fattispecie, l’appartenenza ad un medesima comunità politica (il PD), la cui primaria ragione d’essere dovrebbe essere rappresentata, pur nella più convinta prerogativa dialettica, dalla condivisione della mission.
Vi pare che la fattispecie degli ultimi due anni di testimonianza dem lo dimostri? A noi, che condividiamo parola per parola Claudio Magris (“un suicidio assistito. Un partito che ambisce a guidare un Paese deve avere una sua unità, in cui le diverse tendenze non sgretolano il partito stesso e non paralizzano la sua azione politica. Chi auspica e promuove scissione ha il diritto ovviamente di farlo, ma deve sapere che in tal modo si affossa il partito, lo si trasforma da forza capace di governare in un pulviscolo di tronconi privi del consenso necessario per governare e anche verosimilmente inetti, per rissosa immaturità ideologica, a governare” pare francamente di no!
D’altro lato, come non convenire con l’analisi di Claudio Martelli: “Sarà che le ideologie e le idee sono tramontate e con loro le passioni totalizzanti e il pieno impiego psicologico, l’identificazione e la mobilitazione tendono a manifestarsi con le lotte di parte, di corrente, di fazione”
Ciò che di più ha colpito nel recente congresso e colpisce nelle primarie dei democratici è l’assenza di un vero e profondo dibattito politico sulla natura del partito, sui suoi programmi e sulle possibili intese post-elezioni. Per non parlare di un anche minimale approccio allo sforzo di delineare un progetto strategico di transizione dagli attuali contesti segnalatori di una profonda criticità di sistema ad un quadro di condivisione sociale ed istituzionale che renda nuovamente compatibili le spinte centrifughe attivate dalle conseguenze della mondializzazione e del superamento della sovranità.
Il Renzi degli esordi aveva fatto intendere un promettente ancoraggio alle consapevolezze dell’impraticabilità di un’offerta politica, che fosse ispirata alla continuità rispetto al retroterra teorico e pratico di un ciclo completamente esaurito. Come esaurito è, almeno dal punto di vista della correlazione tra presente e futuro, il potenziale di lettura dei cambiamenti e del modo di fronteggiarli. Le tradizionali dottrine politiche ed i discendenti movimenti, come dimostrano i fenomeni politico-elettorale palesi in tutto il mondo occidentale, possono tutt’al più conservare una residua funzione di riferimento. Ma, salvo sorprese allo stato improbabili, dimostrano tutta la loro obsolescenza quanto meno a livello di corresponsione al diffuso impulso di cambiamento.
D’altro lato, i recenti election-days dei maggiori paesi occidentali ed europei hanno dimostrato che la sorte dei tradizionali aggregati teorico/elettorali è segnata, se non altro dal punto di vista del rating maggioritario. E che il requisito pregiudiziale per entrare nel radar delle praticabilità di un percorso leaderistico è rappresentato dalla condizione di essere privo di precedenti esperienze politiche ed istituzionali e dichiarare un profilo testimone della volontà di andare oltre i partiti tradizionali.
La leadership renziana aveva segnalato in largo anticipo la tendenza e avanzato un’offerta in linea con tali consapevolezze. Ma essere “nuovi” a tutto tondo può bastare in contesti di solidi ancoraggi alla cultura liberaldemocratica e ad ordinamenti a forte ispirazione maggioritaria.
L’inciampo della ricetta di Renzi, che giustamente riservava assoluta priorità alla riforma sia della politica sia di una forma di governo nell’intento di mettere l’Italia al passo coi modelli occidentali, arrischia di depotenziare quasi completamente la sua chiave di volta. In quanto ne ridefinisce la gittata, che, privata di quella cifra riformatrice, ricolloca il contributo di Renzi all’interno della continuità col passato che si voleva archiviare. Se è vero che la partita della governabilità e della risposta agli inputs antisistemici si gioca al centro (ed in ciò Renzi aveva visto bene), è altrettanto vero che, con le attuali regole, un PD di maggioranza relativa non determinerà quelle discontinuità che costituiscono la premessa per un nuovo ciclo politico. L’esito del congresso riconsegna nelle mani del confermato leader la consolle di un movimento smagrito nei consensi e, soprattutto, alleggerito nelle diffuse aspettative di determinare svolte strategiche. Ammesso che consensi elettorali acquisiti e mediazioni politiche, allo stato difficilmente perscrutabili, riconsegnassero, dopo il congresso, le primarie, le elezioni legislative, di nuovo a Renzi un ruolo centrale, resterebbe irrisolta la dinamica di finalizzare la governabilità corrente ad uno snodo strategico.
In un modello, in cui gli equilibri ingessati della prima repubblica sono confluiti in un maggioritario falsato, nessun player che si avvale delle prerogative di interdizione si sognerebbe di associarsi, con il rischio di segare il ramo della propria esistenza, ad un disegno riformatore.
Andrebbe anche aggiunto che i più avveduti hanno dimostrato la realistica lungimiranza orientata dalla certezza che l’esito della governabilità come della riformabilità si gioca più che al centro nell’area delle consapevolezze ispirate dalla cultura moderata.
Che, come ha dimostrato l’esperienza delle “grandi coalizioni” a far tempo dalle elezioni del 2013, non coincide col bacino dei movimenti che presidiano l’area moderata.
Ovviamente la smobilitazione del renzismo dalla conduzione del campo di centro-sinistra, comporterebbe, per quanto la sua permanenza non garantisca fino in fondo la ripresa del filo interrotto dall’esito referendario, la totale dissolvenza dell’unica ipotesi riformista in capo alla sinistra italiana.
Non resterebbe che una “lunga marcia”, fatta di minori suggestioni mediatiche e di maggior valenza progettuale. In cui l’aspirazione maggioritaria dovrebbe essere supportata, non già dall’impulso alla reductio ad unum dei potenziali partners, bensì dalla prospettiva di un ressemblement in cui associare tutti gli apporti culturalmente omologabili in una sintesi di governabilità e di riformismo.
Partners che non possono essere individuati solo nell’attuale parterre partitico o nella rigida demarcazione degli appartenenti alla politica in senso stretto.
Inequivocabilmente, come abbiamo insistito anche di recente, il primo passo in tal senso deve essere compiuto attraverso uno snodo federativo tra i movimenti che in Italia sono parte integrante de PSE.
Incontrovertibilmente, il PD a trazione renziana esce, dal 4 dicembre e d’dintorni, se non proprio disastrato sicuramente ridimensionato, per non dire molto compromesso a livello di praticabilità di tutte le sue linee guida.
Uno sciagurato approccio al referendum ha messo la parola fine alla seconda Repubblica, non a favore della terza ma per un antistorico ritorno alla prima, della quale rivivremo i peggiori difetti, aggravati dal tempo trascorso e dalle mutate sensibilità degli italiani
Il 4 dicembre ha sancito la diffusa convinzione negli italiani dell’intangibilità del sistema/Paese. Che, in evidente contrasto con la pretesa di qualcuno di volerlo riformare, va benissimo così com’é.
I 1000 giorni di Renzi hanno mischiato le carte dell’approccio alla nuova leadership, allargandone gli orizzonti di identificazione attorno ad un profilo riformista fin qui sconosciuto nel tratto percorso dal campo di centro-sinistra.
Analogamente andrebbe quanto meno riconosciuto onestamente a Renzi almeno il tentativo di portare il campo di centro-sinistra oltre i limiti del proprio bacino di consenso.
Si chiude così la stagione delle riforme e si entra nella stagione della stagnazione e del regresso agli anni 60 (di cui occorre rendere merito ai torvi promotori del «No» alla riforma costituzionale).
Sul fatto che possa essere stato questo l’approdo del combinato ingaggio della campagna referendaria e della conseguente consegna “usurpatus delendus est” non dovrebbero esserci più dubbi.
L’appealing degli sfidanti fa leva quasi esclusivamente sul richiamo della foresta per il popolo dei post-comunisti che, con Renzi, appare orbato di leader sufficientemente autorevole da giustificare la permanenza in un aggregato politico, che è sempre meno quello originario, immaginato, nella fase conclusiva della prima Repubblica, per gestire in automatico gli spazi di potere liberati dal tracollo della Prima e dell’ormai evidente inadeguatezza del campo opposto.
Ma, appare anche orbato di pensiero politico minimamente adeguato a sostenere l’ambizione egemonica sul centro-sinistra. In una manciata di anni la politica è profondamente mutata. Ogni certezza di controllo egemonico sul pensiero e sui bacini di riferimento è svanita; e con essa le rendite di posizione (soprattutto, a livello di consenso elettorale), eredità di cicli irreversibilmente archiviati.
La rappresentanza di istanze, per molti decenni, affidate alla sinistra (in particolare massimalista) nell’attuale temperie fa capo ai nuovi movimenti di ispirazione populistica.
Se la passano male dottrine e movimenti fortemente strutturati, come la socialdemocrazia europea. Figurarsi come può essere la condizione di un movimento ircocervo come il PD. Il cui abbrivio è stato incardinato lungo una linea di liquidità e di leggerezza.
E’ andata bene (dal loro punto di vista, s’intende) fin tanto che si era ancora entro la gestione-stralcio della transizione dal dopo caduta del muro al pieno regime della globalizzazione. Poi, all’orizzonte, è apparso un out-sider che sorprendentemente, pur essendo privo di un pensiero politico organico, ha cominciato a dispensare un modello politico vagamente riformista. Catturando vasti consensi. Elettorali (ben oltre la sommatoria dei bacini di provenienza dell’ex sinistra democristiana e del PDS) ed interni (fino a controllare saldamente gli organismi dirigenti del PD).
Come ha potuto essere tutto ciò?, ha cominciato a chiedersi la “ditta”. Che ha tentato maldestramente di chiudere la stalla quando era troppo tardi.
Iniziò l’escalation della destabilizzazione del perno di quell’inedito assetto, imperniato su Renzi e sulla nuova alleanza interna al PD, che escludeva gli epigoni della continuità post-comunista. Una destabilizzazione, fatta di delegittimazione e di filibustering; nella vita interna del partito come nella rappresentanza istituzionale. Fino alla “testimonianza” referendaria (e post-referendaria), che, sancendo il ricorso a modalità “dialettiche”, tipiche della condizione di appartenenza a forze contrapposte, ha sancito l’incompatibilità della militanza nel medesimo movimento.
Si è brandita la volontà di stare più a sinistra, come se l’autorevolezza di un’offerta politica fosse un problema esclusivamente logistico. Si può stare più a sinistra semplicemente facendo il verso alle suggestioni di un passato indimenticabile ed impresentabile oppure ammiccando, come da tre anni sta indignitosamente facendo Bersani, al qualunquismo grillino?
Sensatamente no. Ed allora si tenta, nell’operazione-recupero, di ancorarsi all’incanto del riposizionamento sulla tradizione del passato.
La furbata di rivendicare l’essere di sinistra (senza l’onere di un minimo di declaratoria dei contenuti) non può costituire attendibile discrimine.
Renzi non è socialista (anche se ha portato il PD nel PSE). E’di sinistra, ma latu senso, a modo suo.
Ha commesso molti errori, che si aggiungono alle mende insite nel profilo di partenza. Le saprà correggere? Mah…?! Con tutti i limiti, la sua offerta politica é, attualmente, nel campo di centro-sinistra l’unica che si ispiri al riformismo e che non prescinda da un realistico rapporto con il contesto del Paese.
Per queste ragioni, quasi montanellianamente (in rapporto alle primarie ed al candidato) parteciperemo al voto ed, insieme (ad abundantiam) ai 10 euro, voteremo Renzi.
Se non altro per coerenza col pronunciamento espresso in occasione della campagna referendaria; che vide l’ambiente socialista cremonese schierato per il SI. Ovviamente tale sottolineatura non costituisce conclusione assiomatica.
Da fiancheggiatori del PSI (attuale), per il vero un po’ disorientati da certe testimonianze antiriformiste da parte di dirigenti nazionali che ebbero ruoli primari nel corso craxiano e che, nei contesti attuali, sostengono il fronte antirenziano, ci chiediamo se non sia giunto il momento per un patto associativo tra il PD ed i socialisti italiani. Per rendere effettiva la conseguenza dell’appartenenza del PD alla formazione continentale del PSE e dei Democratici Europei. Per rafforzare in Italia l’impronta riformista del centro-sinistra. Per riprendere un’azione di governo che, da un lato, affronti quegli conti con la realtà (vera) dei ritardi e del declino del Paese e, dall’altro, ponga in una prospettiva seria (e non in una affabulata promessa di essere più di sinistra) l’attualità di un’offerta di socialismo liberale all’Italia ed all’Europa.