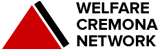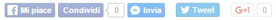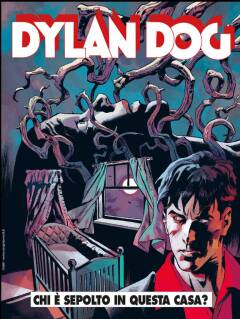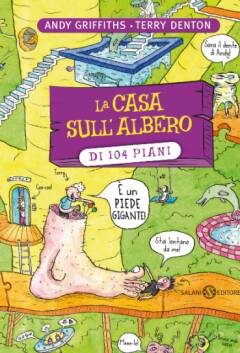PARTIGIANI
"oh fucile vecchio mio compagno / dolce amico nel combattimento” (anonimo.Canto partigiano)
IL venticinque aprile era passato, le giornate si erano fatte estive e la casa di Milanesi, l’ex capo della polizia politica, continuava, in quei mesi del 1945, a rimanere chiusa. Nei giorni del 25 aprile nella strada non si sparò, non fu come l’otto settembre del 1943 dove alla caserma fece fuoco anche un cannone. Spari di fucile ci furono più in là, oltre l’abside della chiesetta di santa Lucia e molta della gente rispose, correndo, a quel richiamo.. Nella strettoia della strada, all’incrocio con via Angelo Morsenti, partigiani armati di fucili tenevano fermo, a distanza, chi era accorso al richiamo di quegli spari. “E’ pericoloso, ci sono i cecchini”, rispondevano a quanti facevano domande. IO non li conoscevo quei partigiani, nessuno di loro era della strada, ma molti di quelli che come me erano fermi a quello sbarramento li chiamavano per nome. Altri ripetevano il loro richiamo “Partigiano! Partigiano!” mentre qualche ragazza si dava da fare per non passare inosservata . C’era chi li chiamava “ribelli”, “siam ribelli e forti siamo/il terror degli oppressor” cantava la sarta del cortile quando ancora quella canzone era proibito cantarla. “Avanti siam ribelli/forti vendicator/ un mondo di fratelli/ di pace e di lavor”! recitava un antico canto anarchico riscoperto in quei giorni, “siamo i ribelli della montagna / viviam di stenti e di patimenti” diceva, in un insieme di innegabile suggestione e di dure avversità, il canto di una brigata Garibaldi della val Borbera. . “Ogni contrada patria è del ribelle” canta ancora il più bel canto partigiano. Quell’appellativo di ribelli mi piaceva ma andò in disuso presto e comparve quello di “patrioti”. Rimase però nella memoria come cosa pronta per essere ripescata alla necessità. Rimase nelle canzoni e anche in una preghiera. Così continuai a chiamarli partigiani. LI vedevo da vicino per la prima volta quei partigiani, armati con fucili che avevano prima armato fascisti e brigatisti neri ed adesso erano nostri. In giacchetta, senza divisa, non diversi da noi, tenevano indietro la gente senza respingerla e sembravano usciti dai nostri cortili. Oltre la via Ruggero Manna, lungo la rampa ascendente che portava (che porta) al pianalto della antica Cremona, appiccicata al muro perimetrale del palazzo, una fila di partigiani armati tentava di raggiungere il grande portone della antica patrizia residenza. I partigiani stretti al muro cercavano di non offrire bersaglio a chi dalla soffitta era pronto a sparare verso il basso. Dall’altro lato della strada, chi in piedi e chi accucciato, protetti dalla sporgenza dell’estremo spigolo del palazzo PErsichetti, due armati tenevano gli occhi ed i fucili puntati alle finestrelle delle soffitte della casa dirimpetto pronti a contrastare un eventuale attacco dei cecchini. I fucili tacevano da troppo tempo ed il trepidare dell’attesa per il riaccendersi della battaglia pareva stemperandosi. In una atmosfera che andava rilassandosi cominciava a circolare il dubbio che tutto si fosse già concluso nel chiuso del porticato, senza spari e senza sangue. Delusi, alcuni degli spettatori lasciavano lo sbarramento mentre qualcuno dei giovanissimi partigiani mostrava il fucile alle ragazze lusingato dal loro interessamento. IO, grazie alle “adunate”, di quell’ antico fucile sapevo quasi tutto. Di trasformazione in trasformazione era giunto fino ad essere fabbricato nella fabbrica cremonese “Anonima Revelli Manifattura Armi da Guerra” conosciuta dai cremonesi con l’acronimo di“Armaguerra”. Sua derivazione, arsenali di produzione, modelli e modifiche fino all’ultimo cambio dell’originario calibro in quello “Mauser”tedesco, era stata materia di “addestramento”alla “premilitare”. In quei giorni d’aprile il fucile “91” era fra le mani dei partigiani dello sbarramento. Improvviso, ormai quasi inaspettato, il fragore percorse veloce gli incroci e i rettilinei delle strade, il silenzio venne rotto da numerosi scoppi che sembravano provenire non dalla strada ma dal cortile o dal monumentale scalone. La gente curiosa, quella assiepata e trattenuta da questa parte della via Ruggero Manna, intimorita si ritrasse con disordine verso la piazzetta della chiesa di santa Lucia e i partigiani si buttarono a terra per non offrire agevole bersaglio. Gli spettatori tornarono al ripristinato sbarramento partigiano quando i fucili tacquero e l’aria ebbe disperso il rimbalzante rincorrersi dell’eco.Nel ritrovato silenzio circolò la voce; “è morto è morto” e tutti pensarono al fascista. C’era chi, pur stando da questa parte dello sbarramento, già conosceva lo svolgersi del fatto, ed il nome del fascista snidato e caduto passava di bocca in bocca. Fra i vetusti ferri fucinati e ribattuti delle ringhiere, in una delle rampe parallele dello scalone nobiliare, sotto la vasta cupola affrescata ed addolcita da amorini della mitologia, morì non il cecchino fascista che, a quanto se ne sa, visse a lungo, ma Poli Amilcare partigiano della 4a Brigata SAP-Ghinaglia ed il suo nome è ricordato sulla grande lapide sotto il portico del Comune.
LA STRADA
Noi ragazzi continuavamo a giocare e a far corse in quel tratto di strada, sopra quell’acciottolato aguzzo che a detta del calzolaio Maggi, al quale veniva imputata la scarsa qualità del cuoio, era il responsabile della prematura rottura delle suole delle scarpe. LUI le rattoppava incollando sulle sforacchiature un dischetto di cuoio che in gergo veniva chiamato “ el ciculàat”. Per entrare nello spazio del calzolaio bisognava scendere tre gradini. Una grande stanza più in basso del piano di calpestio stradale conteneva tutto: letto, cucina e laboratorio. IL deschetto era sistemato proprio di fronte a dove si entrava, in piena luce. Lui, il calzolaio, era seduto in modo da poter vedere subito chi entrava. Alla sua destra una sedia con le gambe segate, perché risultasse alla stessa altezza del piano di lavoro del deschetto, era per un inesistente altro lavorante o per gli ospiti. IO mi sedevo lì ed ascoltavo storie di una antica emigrazione in luoghi che non conoscevo. Maggi era andato per il mondo in cerca di fortuna. Fu calzolaio ma anche cameriere di un vescovo brasiliano oltre a tante altre cose.Non trovò fortuna e tornò in Italia fermandosi lì in quel basso nella nostra strada. IL deschetto del calzolaio Maggi era per noi una inesauribile miniera. Suddiviso in tanti scomparti conteneva una qualità infinita di chiodi, che andavano dalla sottilissima sumèensìnàa ai più robusti e lunghi ciòod pèr supèi. Approfittando della bonarietà del calzolaio attingevamo in quel labirinto di scomparti il chiodo più adatto alla auto-costruzione di cose che servissero per il gioco. Troneggiava, sul deschetto, il vasetto di vetro della colla. Intinto in quella mucillaggine vischiosa, un pezzo di legno che poteva essere stato il manico di un pennello. A quel vasetto ricorrevamo quando, per la costruzione dell’aquilone, non bastava la colla fatta con l’acqua e la manciatina di farina clandestinamente trafugata in casa. Lungo il viale per il PO, sulla sinistra, dal canale che esiste ancora fino alla casermetta dei carabinieri da anni scomparsa, un fosso di bonifica influente nel Morbasco divideva dalla scarpata della strada le infinite tettoiette della fornace Frazzi. All’ombra di quelle capannine gli operai, i filadùur, allineavano i mattoni forati perché, protetti dal sole, asciugassero all’aria prima di essere cotti al fuoco della fornace. In quel colatore di drenaggio crescevano spontanee delle sottili canne, le arelèe, che raccolte ed incrociate servivano a costruire la leggera intelaiatura che sosteneva la grande ala e le code catenarie dell’aquilone. Trattenuto con un filo e trascinato, se la corsa era abbastanza veloce, l’aquilone si sosteneva in aria.
LA RIGHÈTTÀA
La via Bissolati era sempre il luogo dei nostri giochi e non era raro, nelle sere di quella estate, che da quel suo quasi naturale prolungamento che sta fra la piazzetta di Santa Lucia ed il corso Vittorio Emanuele dove il toponimo era già cambiato, arrivasse la voce urlata di una donna. Noi ragazzi andavamo a vedere. Altra gente passava od arrivava, come noi, attirata da quelle grida. C’era chi si fermava e chi andava oltre;: “lè la Righèttàa” dicevano e tiravano diritto. Fra quelli che si fermavano i più avevano parole di comprensione e dal loro conversare conobbi parte della storia di quella donna. Non di raro qualcuno si staccava dal gruppetto, le si avvicinava con affettuosità, le passava una mano sotto braccio o le avvolgeva le spalle quasi in senso protettivo, dicendole: “Dai, Righètàa fàa mìia cuzé, vieni via”. Lei, la donna cercava di svincolarsi da quegli abbracci e dal marciapiede che costeggiava un tratto di muro del vecchio macello comunale poco oltre la porticina della casa del veterinario, guardava ed agitava verso l’alto un pugno che non riusciva ad essere minaccioso. A volte si toglieva uno zoccolo mimando il gesto di volerlo lanciare o, attraversata di corsa la strada, lo batteva forte contro la porta, che gli altri inquilini della casa avevano avuto cura di chiudere e le sue grida ostili parevano di pianto. Io non la conoscevo, non era della strada ed arrivava da chissà dove fino alla nostra strada per gridare il peso che le stava dentro. LI’ all’ultimo piano della casa di fronte, dove le persiane di tre finestre rimanevano chiuse nonostante la calura estiva, abitava il destinatario di quelle grida. IO lo conoscevo e lo incontravo spesso prima del venticinque aprile. Ci vedeva da un occhio solo e, probabilmente, era per questo che camminava con la testa alta leggermente ripiegata all’indietro. IL mento sporgente conferiva all’insieme una sembianza di volitività forse non cercata, ma in chi lo incrociava il messaggio che riceveva era di minaccia. Nella strada si diceva di lui che fosse stato un “batour”, uno di quelli che andavano con il manganello, uno squadrista. Basso di statura e rotondotto veniva indicato con un sopranome, na scutumàja, che nel nostro dialetto può indicare una cosa piccola ma anche i lasciti organici di una transumanza che noi ragazzi, quando ci avventuravamo per giochi e per scoperte lungo le alzaie ed i sentieri del PO, vincendo il ribrezzo eravamo costretti a calpestare. DA qualche tempo “Bàgool” non si vedeva in giro. L’aria che tirava in quell’estate del 1945 non era buona per lui. A fare la spesa quotidiana da “Dernèen” e da la “Zòrèe” veniva sua moglie. Una donna pallida che non per colpa teneva gli occhi bassi, alla quale le altre donne del quartiere rivolgevano la parola.
All’indirizzo di quell’uomo lei, la “ Righèttàa”, lanciava il suo dolore di madre ed anche le sue bestemmie.
“Bagòol, canchèer faciòon, dame indrèe el mèe Rosòol”!! gridava.
Poi quell’estate passò e della Righètàa, nella strada, si parlò sempre meno, forse se ne perse anche il ricordo. IL figlio Rosòol viene ricordato il 25 aprile di tutti gli anni ed il suo nome continua a figurare sulla grande lapide sotto i portici del comune, insieme agli altri partigiani uccisi in valle Susa.
BÙCABÉLA
Sollecitato da una mia domanda, di quella valle lontana mi parlò un giorno, era l’estate del 1944, un ragazzino della strada. LO chiamavamo “Bùcabèla”, una “scutumàja” che non so dire da dove derivasse. Oltre al “Fèròo”, dei ragazzini di quelle estati è l’unico che rivedo. Eravamo (lo siamo ancora) per la generosità di sua madre, fratelli di latte. Adesso lui gioca a carte. Quando mi ritrovo in centro, ogni tanto giro per quella antica strada che nei tempi andati forse portava ad una remota porta di ingresso della città e vado oltre il voltone. Lui, Bùcabèla, lo trovo al “Centrale” seduto ad uno dei tavoli in fondo, non interrompo la sua briscola o il suo tresette. Aspetto che vengano calate le ultime carte, che si taciti il gioire per i punti fatti ed il recriminare vivace per quelli non fatti. L’affettuosità si rinnova nel tono della voce e negli sguardi. Un “Come va ?”, un saluto e via, mentre loro ricominciano a mischiare le carte. Ricordo come in quella lontana estate nella strada si parlasse di lui, si accennasse a qualche cosa che riguardava la sua famiglia... Fra gli adulti più che un parlare era un sussurrare con il sospetto di essere uditi da “altri”, il bisbigliare di una cosa che avrebbe dovuto rimanere segreta, un mormorio che m’incuriosiva ed al quale prestavo orecchio in una generale sensazione di tristezza. Capii che la questione riguardava suo padre al quale doveva essere successo qualcosa mentre era in luogo segreto, lontano da casa. Chissà come trovai l’ardire e un giorno, sopraffatto dalla curiosità, glielo chiesi. “E’ morto,ucciso in valle Susa” rispose. Fra noi, finchè restammo ragazzi, della cosa non si parlò più. Poi il nome di suo padre lo lessi sulla grande lapide dedicata ai Caduti per la Libertà sotto i portici del comune.
LE NOSTRE CANZONI
“Non ci lasciano più cantare le nostre canzoni,/ Robenson mio fratello nero dai denti di perla,/ mio usignolo con ali di aquila,/no,non ci lasciano cantare le nostre canzoni”.
Nazim Hikmet
In uno dei nostri libri è riprodotta una vecchia e bella fotografia. Ritrae un palco montato davanti al palazzo comunale, l’arengario è alle sue spalle. Chi sta sul palco guarda ad una piazza o parla ad una folla che si intuisce esserci, ma assente nell’immagine. “Una delle prime manifestazioni per il 25 aprile” recita la didascalia. Sul palco, in atteggiamento tribunizio, Emilio Zanoni, che fu anche sindaco di Cremona. Poi diverse persone, prevalentemente, al tempo socialiste o comuniste,. tutta gente del CLN con i nomi in dicitura. Oltre all’oratore figurano: Giuseppe Speranzini, Enrico Fogliazza, Guido Uggeri, Arturo Verzelletti, Kumli, Dante Cabrini, Lazzaro Goi, Menotti Screm. Seria, forse ancora per lutto in abito nero, con la testa girata leggermente verso destra, sopra quel palco compare anche un'unica donna. Il suo nome precocemente dimenticato non figura nella legenda. IO la conosco, è Rosa Palma ed il nome di suo marito, uno dei tanti partigiani caduti in valle Susa, figura sulla grande lapide sotto il portico del comune. Rosa abitava in quel tratto di strada che , superata una leggera deviazione verso destra, costeggiando i divisori del vecchio macello e della fabbrica del ghiaccio, correva al centro e parallela fra i resti delle antiche mura di difesa della città e la Cremonella, già al tempo tombata sotto la via Bissolati. Noi ragazzi sapevamo che era lì e appoggiando l’orecchio al robusto legno di una porticina bassa sempre chiusa sentivamo il suo rantoloso gorgoglìo, quasi un anaerobico respiro. Passò il tempo e Rosa Palma cambiò quartiere andando ad abitare in una inurbata campagna,oltre il cavo Cerca e la osteria del “Gelsomino”. Per antica ed affettuosa conoscenza ogni tanto l’andavo a trovare. Una volta, in una di queste visite, mi chiese in un dialetto che nella pronuncia risentiva delle sue ascendenze meridionali: “Tu, Ennio, alle manifestazioni del 25 aprile ci vai ancora, porti ancora la bandiera”? Non aspettò riposta e scotendo la testa in un modo che mi parve esprimere perduta illusione o rimpianto per quei tempi andati, aggiunse: “Io no, non ci sono più andata”. CI vado ancora, cara signora Rosa, a quelle manifestazioni che negli anni mi hanno accompagnato e non dimentico di portare la bandiera di sempre, quella rossa. Ci vado ancora, anche se adesso la banda suona solo marce militari e non più le nostre canzoni.
Ennio Serventi
Cremona
19/04/2011
Altri Racconti di Ennio Serventi
- Serventi.In questa terra amata
https://www.welfarenetwork.it/serventiin-questa-terra-amata-20110314/