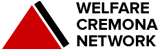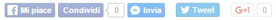Cosa intende la sinistra italiana quando enuncia solennemente "il lavoro prima di tutto"? La retorica ideologica del “postindustriale” ha prodotto, anche nel fronte progressista, equivoci da cui bisogna uscire DI GIUSEPPE CASADIO
Cosa intende la sinistra italiana quando enuncia solennemente “il lavoro prima di tutto”? L’interrogativo è ormai di lunga data e sbaglia chiunque pensi che a rendere davvero convincente quell’affermazione basti una dose in più di antagonismo nelle enunciazioni, una misura in più di radicalità nei programmi. Naturalmente, sia chiaro, in una società molto composita e segnata da iniquità brucianti e crescenti l’antagonismo fra gruppi di interesse è fisiologico, e ciò va riconosciuto senza infingimenti. In certa misura è un propellente necessario, una risorsa energetica rinnovabile ed ecocompatibile. E, parimenti, la radicalità della dialettica non può che essere commisurata all’urgenza sociale del cambiamento.
Ma dicendo ciò siamo soltanto alle “premesse di valore”, a principi di metodo che sono significativi, tutt’al più, del modello di democrazia che si intende perseguire. Da questo punto di vista, limitando lo sguardo alle vicende più recenti della sinistra italiana, la coalizione “Italia Bene Comune” presentatasi alle elezioni dello scorso mese di febbraio si qualificava come un soggetto politico limpidamente di sinistra, strategicamente in sintonia con le forze progressiste operanti nelle altre grandi democrazie europee, in molti casi governandole. Il travaglio successivo al voto non può mettere in discussione questa evidenza, e non deve vanificare la prospettiva di un suo ripristino.
Tuttavia ciò, di per sé, non basta a dare risposte convincenti al quesito iniziale. Come può risultare credibile quella priorità declamata? Innanzitutto, se la sinistra politica saprà sciogliere ogni ambiguità circa il modello di sviluppo che immagina e progetta per il futuro della società italiana. Ogni ipotesi di uscita dalla crisi lo impone. La profondità e la persistenza della crisi che da alcuni lustri sta deprimendo il sistema produttivo, la prevalenza di politiche socialmente inique e di stampo liberista nell’azione dei governi, hanno scomposto la stratificazione sociale, alimentando molti fronti di competizione aspra fra ceti, interessi, persone. Si è svilito il valore del lavoro come collante fondamentale della cittadinanza, e quindi, conseguentemente, il sistema delle sue tutele.
Il quindicennio che abbiamo alle spalle ci consegna l’urgenza di un’opera di vera e propria ricostruzione della coesione sociale in un contesto radicalmente nuovo. Ma il sistema sociale non si ricostruisce a prescindere dalla struttura economica; da qui la centralità della questione di quale modello di sviluppo perseguire. Pur tenendo conto delle profonde trasformazioni nel frattempo intervenute e di quelle ulteriormente necessarie, il nostro paese conserva uno straordinario patrimonio di strutture produttive e di cultura manifatturiera. In ciò consiste, ancor oggi, la nostra principale risorsa per il futuro.
Mi piace citare, in proposito, un passo di una recente lettera del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a Repubblica: “Mettere a rischio la manifattura italiana vuol dire minare a fondo la coesione sociale e la vita delle comunità”. Penso si tratti di un giudizio ineccepibile sulla nostra storia sociale e, a un tempo, di una considerazione dirimente per il nostro futuro. Furono la duttilità, la versatilità del lavoro e un diffuso spirito imprenditoriale a portare l’Italia, nell’arco di pochi decenni, fra i paesi più industrializzati del mondo, e soprattutto i prodotti della manifattura italiana ad affermarsi sui mercati dei beni di consumo e d’investimento. Si trattò di un processo di enorme valore economico, ma anche civile e culturale. Nell’ambito del quale si realizzarono le conquiste fondamentali per il mondo del lavoro, sia in termini di tutele individuali e collettive che di acquisizione di una forte soggettività politica da parte delle organizzazioni della rappresentanza del lavoro nelle sue diverse articolazioni.
È comunque da lì che dobbiamo ripartire. Il saper fare produce valore, restituisce coscienza di sé e orgoglio civile ai produttori, alimenta il consolidarsi di nuove culture. Dunque, non si sta divagando; la retorica ideologica del “postindustriale” ha prodotto, anche a sinistra, equivoci da cui bisogna uscire. Ovviamente, la nozione di “manifattura” include oggi tutte le straordinarie trasformazioni tecnologiche e organizzative che la contemporaneità impone: può e deve incorporare sapere, innovazione, ricerca; deve e può sviluppare nuove forme d’integrazione produttiva dei sistemi di piccola impresa al fine di sopperire al deficit di massa critica per aggredire la dimensione globale dei mercati. L’importante è aver chiaro che quella rimane la nostra risorsa fondamentale. Le conseguenze di una tale scelta sono determinanti sia sul fronte delle politiche destinate a sostenere la ripresa dello sviluppo, sia sul fronte delle politiche del lavoro in senso stretto.
A tal proposito, è davvero necessario porre fine alla logorante sequenza di interventi di manutenzione delle regole del mercato del lavoro; non è così che si crea nuova occupazione. Anzi, le statistiche sul lavoro da almeno un decennio dimostrano che la ricerca di sempre più fantasiose forme di occupazione flessibile producono dequalificazione, sotto-inquadramento, caduta dei livelli del reddito e, quindi, deprimono ulteriormente l’economia senza generare nuova occupazione. E diffondono sempre più, fra le giovani generazioni, un sentimento di estraneità a quella cultura del lavoro che ha fatto della nostra società una delle più avanzate e civili. Rischiando di apparire troppo sommario nel giudizio, evidenzio un solo dato di fatto, oltre a quello drammatico e universalmente noto della disoccupazione giovanile: i più recenti dati Istat ci dicono che le retribuzioni mensili nette degli under 30 al primo impiego – parliamo dunque di giovani regolarmente occupati – sono mediamente di 804 euro per i diplomati, 1.004 euro per i laureati. Uno scandalo.
È dunque il momento di uscire da sofisticati tecnicismi. Ciò che serve affermare con convinzione è che si devono estendere le opportunità di percorsi d’ingresso nel lavoro che prevedano periodi di integrazione fra formazione e lavoro, e ricondurre le forme di occupazione temporanea alle fattispecie effettivamente necessarie in ragione delle specifiche esigenze dei cicli produttivi, restituendo all’autonomia negoziale delle parti in sede di contrattazione il compito di individuarne le casistiche.
Dopo l’orgia delle flessibilità a menù, ispirate dalla “dottrina Sacconi” (e di molti ineffabili giuristi da laboratorio) è necessario restituire dignità e trasparenza al mercato del lavoro, riconoscendone le esigenze anche di flessibilità, ma responsabilizzando i soggetti della rappresentanza. In conclusione: chiarezza di riferimenti, semplicità e razionalità di proposta, sono le condizioni essenziali per essere credibili, soprattutto quando si affrontano questioni tanto cruciali per la vita delle persone. E coerenza nei comportamenti, naturalmente.
Fonte: http://www.rassegna.it/articoli/2013/06/28/102176/sinistra-e-lavoro-da-dove-ripartire
2013-06-29