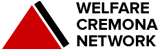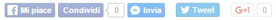A Soresina, dove ho frequentato la prima e la seconda media e dove ho giocato nella locale squadra di calcio nel campionato 1967/68, con l’allenatore Virgilio Fiameni, vengo sempre molto volentieri. Un grazie, ovviamente, è rivolto pure alla Direzione dell’Istituto che ci ospita, con la speranza di non deludere le aspettative di chi mi ha convocato e le vostre che mi state ora ascoltando.
Inizierò subito col dire che ho pensato a voi, giovani studenti, nel mentre assistevo a Cremona ad un importante Congresso Internazionale sullo spreco alimentare, tenutosi il 3 e il 4 marzo presso la Sala Maffei della Camera di Commercio, che ha visto la partecipazione dei consoli di trentatré Stati esteri, i quali si sono confrontati sul tema della salvaguardia degli alimenti, nel tentativo di offrire la condivisione di esemplari buone pratiche. Come saprete, la Carta di Milano, eredità dell’Expo 2015, ha sensibilizzato il mondo intero “a consumare solo le quantità di cibo sufficienti al bisogno, assicurandoci che il cibo sia consumato prima che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in modo tale che non si deteriori”.
In relazione al movimento d’opinione promosso da Expo 2015, il 2 agosto del 2016 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato in via definitiva la proposta di legge contro lo spreco alimentare riassunta in una sollecitazione a tutte le famiglie con figli in età scolare, traducibile con questo concetto: “chi porta a casa gli alimenti che non consuma è una persona che apprezza il cibo, lo rispetta e per questo non lo spreca”.
A Cremona, i convegnisti del 3 e 4 marzo, coerentemente a questo assunto, hanno sottolineato un aspetto incontrovertibile, ossia come la sopravvivenza del genere umano sia strettamente legata all’alimentazione, alla sua gestione, alla creazione di sistemi produttivi meno costosi e più efficienti che garantiscano un livello di vita dignitoso e sufficiente per dare all’uomo lavoro e dignità affinché possa sentirsi libero nelle proprie scelte di vita.
Ora, mentre i consoli di tanti paesi esteri parlavano, io pensavo all’Istituto Tecnico Ponzini e a voi, e mi chiedevo:”Adès cùza gh’òo d’endàa a dìighe a chèi fiööi là? (Adesso cosa devo andare a dire a quei ragazzi di Soresina?)”. E mi sono dato la risposta, che è molto semplice, ossia che insieme al cibo non si debba sprecare il tempo.
Cibo e tempo sono due varianti con le quali conviviamo quotidianamente. E con esse dobbiamo fare costantemente i conti. Ebbene, se il consumo di cibo deve essere regolato e meglio gestito, penso che lo stesso concetto vada esteso al modo col quale discipliniamo il tempo, ossia come gestiamo i segmenti di vita che fuggono inesorabilmente via, nell’arco prospettico che unisce l’inizio dell’esistenza con il punto in cui essa chiude i battenti.
In questo spazio intermedio, più o meno lungo, accanto al consumo del cibo e del tempo, s’inserisce inevitabilmente ed inesorabilmente la gestione del proprio corpo e della propria salute. E va da sé che per gestire meglio il corpo e la propria salute, in un mondo che vede un miliardo di obesi e un miliardo di affamati, debba essere regolato e disciplinato con avvedutezza il consumo di cibo ed il consumo del tempo, in pratiche tese a rendere apprezzabile, nel più gratificante dei modi, il dono primario della vita stessa.
In detta parentesi vitale, alimentata dal cibo, deve essere ritagliato coscienziosamente un avveduto spazio per l’efficienza fisica, con la pratica del moto, resa possibile con l’esercizio ginnico e lo sport, individuale o a squadre. Un ritaglio non significa tutto il tempo, ma solo una parte. E quindi nel mentre sono qui ad invitare tutti a fare sport, sollecito nel contempo tutti a non ripetere l’errore che il sottoscritto fece in certi momenti dell’adolescenza. Infatti, da ragazzo, attraversai un periodo durante il quale, trovandomi all’oratorio a tirare calci ad un pallone, con scarpe peraltro inadatte, perdevo la nozione del tempo, dimenticandomi così dei libri che avrei dovuto studiare. E così in terza media, nella terza C della scuola media Virgilio di Cremona fui “baccato” come si suole dire. L’anno dopo, in terza B, incontrai l’amico Renato Bandera, dopo averlo conosciuto qualche anno prima ad Annicco, dove egli veniva a trovare suo cugino Amilcare Achilli, mio caro compagno di giochi. Quell’anno, nel 1962/63, vi era in classe con noi un secchione, di cui per rispetto non riporto il nome, per il quale non esistevano né lo sport e né le ragazze. Per lui c’era solo lo studio. Sembrava, a noi ragazzi alla buona, un Giacomo Leopardi in miniatura. Certo un Leopardi senza la gobba. Serio, serissimo, col viso imperturbabile sempre rivolto in avanti. Mai una battuta, un sorriso, sempre con quel braccio teso verso l’alto pronto a rispondere a qualsiasi domanda degli insegnanti. Un fenomeno; un fenomeno che però non rientrava nella gamma dei nostri riferimenti ideali. Mi ricordo che si fece escludere dalle due ore di palestra dedicate all’educazione fisica. Fu un mistero ed un esempio tutto sbilanciato sui bisogni sacrosanti dello studio e della conoscenza, senza nessun tipo di attenzione però al corredo ineludibile della massa muscolare che abbraccia il corpo ed accompagna, nel vivere, quello straordinario strumento che è il cervello.
Vi confesso a questo punto, mettendo da parte i vecchi compagni di scuola, e passando invece ad un consunto di verifica sulla mia vita; vi confesso, dicevo, di potermi ritenere tutto sommato fortunato nel fare un bilancio fra l’attività fisica sviluppata negli anni ed il consumo alimentare di cui ho potuto godere, dapprima, con la cucina bolognese di mia madre Laura e di mia nonna Giuseppina e, poi, con la cucina cremonese di mia moglie Rosella.
Sul piano dell’educazione fisica ho avuto poi altrettanta fortuna con l’esempio di mio padre William, già paracadutista in epoca bellica, il quale conviveva con il mito della ginnastica militare che praticava tutte le mattine. E nel contempo egli aveva il culto e il rispetto per ogni briciola di pane presente sulla tavola. E quando si andava in un ristorante, il papà chiedeva sempre, agli increduli camerieri, pane raffermo, pane vecchio, perché questo a suo dire - ed è vero -, facilitava la digestione essendo esso privo della componente umida.
Con quell’esempio iniziale, mi è parso naturale, a dodici anni d’età, di fondare ad Annicco una squadra di calcio, con lo stesso nome del 185° reggimento dei parà di mio padre, ossia “Folgore”. E con la “Folgore” organizzai un torneo sfidando i pari età di Paderno, Farfengo, Grontorto e Barzaniga, in un tempo in cui per telefonare fuori dal paese bisognava chiamare il centralino di Soresina. I miei genitori mi permettevano, infatti, di usare liberamente sia il telefono a manovella e sia la macchina da scrivere, un’Olivetti 32.
Mi ricordo che a quel tempo tutti facevano merenda con i surrogati Ferrero, surrogati di cioccolato la cui vendita veniva incentivata anche dalle figurine degli indiani appiccicate sopra alla confezione.
A quattordici anni ho frequentato la scuola calcio, il NAGC (Nucleo Addestramento Giovani Calciatori), della federazione di Cremona, con l’allenatore Eugenio Bergonzi, e poi ho giocato ininterrottamente per vent’anni. A fine carriera (chiamiamola così) non ho mai smesso di andare a correre sugli argini del Po, fino a quando ho sostituito la corsa con la passeggiata, a ritmo sostenuto, in collina.
Va pure aggiunto che in città non mi muovo mai se non in bicicletta.
Devo dire, a questo punto, che molta acqua è passata sotto i ponti dell’ultimo mezzo secolo di storia contemporanea. Quando avevo sedici anni non c’erano piste ciclabili in Italia od isole pedonali in città. Non si vedeva nessuno fare footing. Mi ricordo che quando mi preparavo durante l’estate per il campionato di calcio successivo, ed andavo a correre lungo la periferica via Rosario a Cremona, i camionisti che passavano si mettevano a ridere come se stessero vedendo scappare un matto inseguito da un fantasma. Ora la consapevolezza della positività del moto si è molto diffusa e vedo gente di tutte le età correre e camminare, o passeggiare anche per il solo fatto di portare a spasso, quotidianamente, il cane proprio o altrui.
Nella fortuna che mi è venuta incontro nella vita, c’è anche quella del rapporto con mia moglie, che avendo lavorato per anni nel settore dei prodotti destinati alle erboristerie, ha un’attenzione scientifica ed alimentare per i doni della natura. Da qui, non c’è giorno che ella non mi solleciti a cibarmi con le bacche di bosco, more e mirtilli neri e rossi, ribes, uva spina, e con le bacche del biancospino (i cagapùj) e le goji, frutto della longevità, proveniente dalla Cina, contenenti vitamine del gruppo A, B e C. A tavola, ovviamente, non consumiamo solo bacche, ma anche altri alimenti in misura moderata e molta frutta, il tutto accompagnato da due dita di vino rosso.
Va da sé che in casa nostra non vi siano scarti od avanzi alimentari. Le briciole di pane le mettiamo a disposizione delle tortore, dei merli, dei passeri, dei pettirossi, dei saltimpalo, delle cince, degli uccellini vari che vengono costantemente a trovarci davanti a casa. Preciso che non abitiamo in un bosco, ma a porta Romana, nella prima periferia della città di Cremona. In sostanza, con le briciole agli uccellini, andiamo a rinnovare l’idea di fondo che albergava una volta nelle famiglie italiane, quando esse non erano ancora state abbagliate dal consumismo d’origine nord-americana, e quindi dalla pratica diffusa dell’usa e getta.
Infatti, un tempo, sia nelle famiglie più abbienti come in quelle più modeste, quando gli avanzi non erano più commestibili e quindi utilizzabili per gli uomini, venivano indirizzati all’alimentazione degli animali, come le galline con gli avanzi di minestra e verdura, e soprattutto come il maiale, a cui si poteva dare di tutto.
Nelle famiglie medie, dove non c’era la servitù che poteva godere gli avanzi, questi potevano, a volte, essere riscaldati e mangiati in un altro pasto, ma più spesso e più volentieri venivano reimpiegati per confezionare altri cibi, più gustosi e, soprattutto, diversi e quindi più gradevoli.
In sintesi, ritornando alla mia personale esperienza di vita, ritengo proprio di non essermi allontanato molto dai postulati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la quale viene intesa per attività fisica “
La sedentarietà – ossia lo stare fermi, non darsi una mossa – è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Quindi un’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute.
Care ragazze e cari ragazzi, sono convinto che la più parte di voi faccia già del moto e dello sport. Da qui l’invito mio è quello di continuare a farlo. Per chi non vi si esercita ancora, il mio invito è quello di provarci. Non è mai troppo tardi. Con la pratica di un’attività fisica regolare il cuore diventa più robusto e resistente alla fatica. L’attività aerobica aumenta la richiesta di ossigeno da parte del corpo e il carico di lavoro di cuore e polmoni, rendendo la circolazione più efficiente. Un cuore allenato pompa una quantità di sangue maggiore senza dispendio supplementare di energia: dieci battiti cardiaci in meno al minuto, significano 5.256.000 battiti all’anno risparmiati.
Vita e cibo formano dunque un binomio indissolubile, un asse che sostanzia il cammino dell’uomo. Potremmo anche dire che la vita è cibo e che il cibo è vita. I due termini possono reciprocamente prendersi per mano nell’articolazione della frase, proponendosi ora come il soggetto ed ora come l’oggetto dell’espressione stessa. Ciò che non cambia è il processo che permette all’umanità di vivere e di prosperare.
Le considerazioni che vi ho anticipato le ho trovate pure sul libro Pàan e sapièensa. Cucina cremonese antica, a cura di Luisa Piccioni, traduzione in italiano del testo latino De honesta voluptate et valitudine, ossia Il piacere onesto e la buona salute, di Bartolomeo Sacchi, detto il Plàtina, umanista e gastronomo, nato a Piadena nel 1421 e morto a Roma, sessantenne, nel 1481.
Il testo si compendia in una analisi della gastronomia, sulla dieta, sul valore del cosiddetto “cibo del territorio” e sull’utilità di una regolare attività fisica.
Infatti vi si dice nel capitoletto “Come tenere in esercizio il corpo”: “Poiché la pigrizia indebolisce il corpo e le malattie sono la conseguenza della pigrizia, si devono fare buoni esercizi fisici onde purificare il sangue intossicato per mancanza di moto e perché le membra siano sempre più valide e pronte ad affrontare ciò che si deve fare. Inoltre, poiché il movimento produce calore, eccita l’appetito; e la mente, con l’aiuto dei sensi, diventa più agile e più perspicace nell’apprendimento dei segreti meravigliosi della natura. Ma questi esercizi non si devono fare se prima non è avvenuta la digestione, né tanto meno a digiuno completo perché il corpo è debole; si deve quindi aspettare la prima digestione dopo di che non ci si deve preoccupare né per aver mangiato cibi pesanti né di avere lo stomaco vuoto.
Sono esercizi efficaci le passeggiate, le occupazioni varie, il salire e scendere per i declivi, quando si è in casa, il trasporto di oggetti non pesanti: quando si coltivano orti la raccolta dei frutti, la sarchiatura, l’erpicatura, l’innesto, la potatura.
Fanno pure bene al corpo il gioco svelto con la palla, grossa o piccola, gli esercizi a cavallo e a piedi, la lotta. Inoltre, non devono essere trascurati dall’uomo civile e nobile il gareggiare nel salto, scagliare giavellotti, tendere l’arco, andare a caccia, cosicché, se sarà necessario, potrà usare valorosamente le proprie armi. Tutto ciò è più salutare e piacevole se viene eseguito all’aperto e al sole piuttosto che al coperto e all’ombra.
Inoltre, sono particolarmente apprezzabili tutti gli esercizi che fanno sudare e che provocano una certa stanchezza.
E’ opportuno dedicarsi principalmente ad esercizi che tengano in movimento tutte le membra nella stessa misura per non rischiare, trascurandone una parte, di affaticare troppo l’altra.
E’ anche vero che può essere pericoloso sia il troppo ozio che la troppa fatica: perciò è bene stare nella via di mezzo per non mutare il piacere in dolore”.
Ecco il concetto da condividere col Platina e da mettere in pratica anche al giorno d’oggi con la ricerca di questa via di mezzo, di questa misura che tiene in considerazione le varie esigenze cercando un giusto e corretto equilibrio. Per chi studia e vuole diplomarsi e poi magari laurearsi, l’equilibrio va cercato fra studio e tempo libero, nel quale spazio temporale, quello del tempo libero, è bene tener conto delle esigenze del corpo. E successivamente, sia nel tempo dell’impegno professionale e nel tempo dell’attesa nella ricerca di un lavoro, è sempre bene tenere oliata la macchina corporale stando molto attenti al rischio narcotizzante dello sbadiglio e della noia.
E’ molto meglio correre per i campi e nuotare in piscina o in qualche canale o roggia, giocare a tennis, a basket, a bocce, o impegnarsi in una delle numerose discipline dell’atletica leggera, che sbadigliare nella sonnolenza e nella sedentarietà.
Vi accennavo prima all’uso personale e quotidiano che ho con l’amata bicicletta.
Mi piace allora ricordare che qui a Soresina vi è uno stupendo Museo riferito alle due ruote, creato e curato dall’amico d’infanzia Alfredo Azzini, originario di Annicco, che recentemente ha aperto anche una sezione dei velocipedi, che consiste in un rimando della memoria ad un’epoca storica totalmente diversa dalla nostra, vissuta dai padri dei nostri trisavoli. Fra le bici d’epoca di questo straordinario museo soresinese, ve sono alcune appartenute al corpo dei fanti ciclisti di cento anni fa, usate nella Grande Guerra del ‘15/’18. Quello era un tempo nel quale il cibo non solo non veniva scartato, ma nel quale gli avanzi venivano riusati per creare dei piatti che sono entrati a far parte della nostra tradizione. E non c’è famiglia cremonese o soresinese che non li abbia gustati. E non c’è sportivo, ciclista o calciatore od atleta di quei tempi lontani, che non se ne sia cibato.
Ad esempio, vi ricordo la panàada, la zuppa fatta con le briciole del panbiscotto, o col pane raffermo tagliato a pezzetti: lo si metteva nell’acqua per ammorbidirlo, lo si condiva con un po’ di olio e di burro o conserva. Come scrive il ricercatore Valerio Ferrari in un brillante studio, per rendere la panàada più saporita e sostanziosa, una volta scodellata bollente nei singoli piatti –– “la si poteva condire con una grattata di formaggio o sciogliendovi dello stracchino grasso”.
Se avanzava minestra al mezzogiorno la si riscaldava la sera: non c’erano frigoriferi e freezer allora e quindi bisognava mangiare tutto subito e non si faceva fatica vista la scarsità di cibo in quell’epoca. Con la stessa minestra avanzata, un pugno di farina bianca, un po’ di zucchero e un filo d’olio si faceva pure el pagnòch o pìtu-cùtu. S’impastava il tutto e lo si cuoceva sul camino, dentro una teglia, col coperchio coperto di cenere calda per qualche ora. Inevitabilmente cadeva un po’ di cenere dentro che veniva spazzolata via, poi lo si mangiava tagliato a fette. Quello era il dolce della casa.
Con l’avanzo di minestra e l’aggiunta di burro, farina e zucchero, si faceva inoltre el cifùt, che veniva messo in teglia o avvolto nella carta da zucchero e posto sulle braci. Veniva chiamato anche la tùurta de i regàs de scòola (la torta dei ragazzi di scuola). Altro piatto del riuso era la bertulìna, composta col riso avanzato nel pranzo, mischiato con farina bianca e gialla e deposta nel focolare. Vi era inoltre la murùuza, predisposta con la pasta avanzata, mettendo la pasta asciutta residua in una teglia, con l’aggiunta di un po’ di pomodoro, e facendola poi cuocere sulla cenere.
Nei ricordi di un mondo in cui la famiglia si riuniva spesso attorno al focolare, è presente pure la chisóola dùulsa, schiacciata dolce di polenta avanzata. Così in tale mondo, un altro segno che ci rimanda ad un orizzonte arcaico e mitico, è quello di una fine focaccia, il cui impasto risultava annerito nella cottura a causa dei gratòon, o gratòn per dirla in soresinese, ossia i piccoli ciccioli di maiale inseriti.
Per tale motivo essa veniva definita la fügàsa gratùna, formata appunto dai ciccioli di maiale, amalgamati con farina, lievito, olio e un po’ di latte avanzato. Insieme al fascino della creazione di nuovo cibo, c’era un evidente fascino dell’inventiva linguistica, della creatività semantica, caleidoscopio d’un mondo che voleva mettere ali alle proprie radici, ali sempre ben radicate nel proprio territorio d’appartenenza.
Non possiamo inoltre dimenticare le mariconde, ottenute con pane raffermo ed altri ingredienti. Così pure non può essere lasciato nel dimenticatoio la pulèenta brestulìida, ossia il riciclo della polenta avanzata, ammorbidita nel latte freddo e mangiata anche col cereghìin, con l’uovo arrostito en de ‘l óoli gròs, nell’olio grosso, quello della linùuza, ossia nell’olio di lino.
La maestra Gentilia Ardigò di Casalbuttano ha scritto: “Da noi, nelle nostre case di contadini ed operai, era regina della mensa la polenta gialla di granoturco: acqua, sale, farina; si rimestava a lungo nel paiolo di rame appeso alla catena del focolare acceso, poi si rovesciava sul tagliere di legno, si tagliavano le fette con un filo e se ne mangiava a volontà con la frittata di uova di pollaio, con ciccioli, lardo, salame o qualche pucìin di frattaglie. Quella che avanzava sul tagliere si abbrustoliva a fette sulla polentiera davanti al fuoco e poteva costituire il pasto della sera. Si diceva:”La pulèenta l’è na siùra che a mangiàala la cunsùla (La polenta è una signora che a mangiarla ci consola)”.
La maestra Ivalda Stanga, ricercatrice della cultura popolare soresinese, ha ricordato invece nei suoi testi una forma alimentare particolarmente gradita dai bambini, ottenuta con la polenta avanzata, e probabilmente consumata anch’essa a merenda. Questa fine poetessa ha scritto:”Ai bambini piacevano le palle di formaggio: con la polenta si facevano le palle, si inseriva nel centro un pezzo di formaggio, si chiudeva e si mettevano a cuocere in un tegame nella cenere, fino a che avessero fatto la crosta; piacevano tanto ai bambini perché il formaggio fondeva a faceva lunghe file”.
La polenta veniva consumata anche a merenda. A Soresina, ad esempio, come spuntino pomeridiano, si dava – come ha scritto sempre Ivalda Stanga – “una fetta di polenta con dentro un cucchiaio di zucchero, oppure due fichi secchi. Per gli adulti c’era l’accompagnamento d’una sardina, comperata al mercato”.
El pìpa-sèner era un’altra ciambella cotta sotto le braci, prodotta con gli avanzi della polenta, dal cui processo culinario è derivato il nome. Si otteneva impastando tre etti di farina gialla con due etti di farina bianca e un etto e mezzo di zucchero, con l’unione poi di buccia di limone grattugiata, un uovo e due o tre fette di polenta ben schiacciata. Dopo averla coperta con la carta azzurra dello zucchero per non sporcarla di cenere e carboncini, si metteva la ciambella a cuocere lentamente sotto le braci. Una volta cotta, veniva cosparsa di zucchero a velo.
Quando mancava il pane e c’era poca polenta, s’improvvisava la püta, una simil-polenta con impasto di farina gialla, sale e acqua abbondante. Con maggiori calorie era invece composta la pùta citata da Ivalda Stanga, composta da farina gialla col latte ed un cucchiaio di zucchero cotta al fuoco. Un altro piatto, questa volta compenetrato con la polenta non consumata durante i pasti, con l’aggiunta di farina bianca, un uovo e zucchero, era il dolce del pìirla e vòolta, che si cuoceva in padella come una frittata.
La maestra Elide Polenghi Paternieri, di San Daniele Po, mi ha scritto dicendo che attraverso gli avanzi della minestra o della polenta si creava un impasto ‘duretto’ con un po’ di farina, alto un dito, atto a preparare al frìtu-frùtu, il fritto-frutto. “Poi lo si passava nella padella di ferro e lo si faceva friggere con un poco di strutto. Si creava la crosticina, lo si girava e si passava dall’altra. Una volta cotto lo si metteva nella carta per togliere l’unto. Poi lo si zuccherava un po’. Era una vera goduria”.
Ezio Tira, di Volongo, mi ha segnalato invece fra i cibi d’avanzo la ghiottoneria de’l tuzèl, chiamato così in bresciano, o de’l tuzél detto in cremonese. El tuzél era il nome dato alle strisce di formaggio ancora tenero che venivano arrostite, dopo essere state rifilàade, rifilate, ossia tolte dagli stampi di tela dai quali fuoriuscivano nei caseifici. Sembravano serpentelli, mi ha detto l’amico Vittorio Pellegri di Pieve San Giacomo, che gustò da bambino tale regalo offertogli da parte del capo d’un caseificio locale. Giuseppe Azzoni, da parte sua, mi ha inviato questo ricordo:”Ero un bambino di cinque, o otto o nove anni. Per qualche tempo ho abitato a Villapasquali, in faccia al caseificio Bocchi del paese. Andavamo in due o tre amici in mezzo alle larghe vasche del latte. E quando si metteva il grana in forma ci davano i ritagli che uscivano dalla fasce. Ricordo il fresco ombroso dell’ampio salone nell’estate, i piedi nudi sul pavimento di cemento liscio, il profumo del latte e il gusto del tuzél che non saprei descrivere ma era come… da favola”.
In questa disamina va pure annotata la goduria delle crööste de furmàc (croste del formaggio). Una goduria tesa a valorizzare un antico proverbio che dice:”In mancàansa de furmàc, gh’è bòon àanca la cröösta”, ossia che bisogna accontentarsi anche del poco che rimane a disposizione. Ma era un cosiddetto ‘poco’ col quale leccarsi i baffi, evidentemente. Infatti, Alfredo Azzini, titolare come già detto del Museo della bicicletta di Soresina, rivive li crùusti non come un cibo riduttivo e non le pone per nulla allo stesso livello delle pelàje de strachìin (delle bucce dello stracchino). No, lui, le crùuste, se le sogna ancora adesso. Infatti confessa:”Adoravo le croste di formaggio grana, all’epoca di colore nero, che venivano messe sulla piastra della stufa ad abbrustolire o addirittura nella minestra mentre bolliva. Le croste erano veramente una leccornia”.
“La crosta di grana, ormai grattugiata fine al limite - aggiunge a propria volta Renato Bandera – veniva fatta abbrustolire sui cerchi arroventati della stufa a legna, con i bambini seduti tutt’intorno. La crosta spandeva in cucina un odore di unghie di cavallo bruciate dal maniscalco, perché perdeva la parte grassa sulla piastra. Diventava molle e un po’ affumicata ma appetitosa”.
Altro piatto prelibato d’avanzo, in uso a Cremona, era quello dello stràcia-müüs, traducibile con l’espressione “spruzzi in faccia”. Avveniva che allorquando in famiglia si preparavano i marubini (la pasta ripiena per i giorni di festa), utilizzando lo stampo circolare e stellato, restavano molti avanzi di pasta fresca che si recuperavano in vario modo. Il più caratteristico è, ancor oggi, mettere questi irregolari ritagli di pasta, i cosiddetti maltagliati, a cuocere nel brodo con i fagioli. Succedeva e succede che la pasta dei marubini, piuttosto spessa e pesante, risultando tagliata in modo irregolare, cadeva e cade dal cucchiaio nel brodo, mentre la si portava e la si porta alla bocca, provocando spruzzi in faccia, lo stràcia-müüs.
Una attenzione accurata era dedicata poi agli avanzi di carne. Con l’avanzo di carne bollita, con passata di pomodoro e verdure dell’orto (zucchine, peperoni, verze, cipolle), si preparava lo stufato. Con le frattaglie della gallina (testa, budella, zampe, punta delle ali) si faceva un ottimo intingolo. Alfredo Azzini mi ha ricordato che nel soresinese, con i colli e le creste di gallo, si preparava el regüt de còo e còoi (il ragù di capi e colli), i cui ingredienti erano appunto i colli, le creste e le minuta di pollo, ossia budella e lo stomaco del pollo stesso, detto masóola, mazzuola.
Durante la ricerca che ho compiuto per l’Accademia della cucina cremonese ho saputo dalla signora Emanuela Arié degli involtini con foglie lessate di verza. Essi si preparavano col riso avanzato e con la carne avanzata, insieme ad olio sale pepe, più un uovo (a volte con patate lessate schiacciate). La cottura in padella veniva eseguita con poco olio, accompagnata da una sfumatura di vino bianco. Col riso, si riutilizzava pure la salsiccia avanzata. Dal canto suo, Renato Bandera, mi ha scritto:”Ricòordete de la véerza Pòola (ricordati della verza Pola), con le foglie cerose e più dure della stessa verza, che venivano tagliate finissime e insaporite con aceto, tanto aglio e poi passate in olio, cotte molto a lungo, a fuoco lento per cercare una morbidezza che altrimenti non avrebbero avuto”.
Nel terminare un segno d’attenzione lo debbo pure dedicare alla tùurta de ròi, alla torta di maiale, piatto tipico del Soresinese, in un impasto con brööt de òs, brodo d’ossi oppure latte, grasso degli intestini (el rüsööl), soffritto con cipolle, buccia di limone, uvetta a piacere. Ho saputo, durante la mia ricerca, che una scodella di questa torta veniva distribuita ai vicini e ai parenti.
In chiusura di questa carrellata, vorrei rimandare però il pensiero ad un dolce augurale simbolico, la tùurta de Riadél (la torta di Ariadello), la cui consumazione chiude, sin dal lontano 1666, anno dell’inaugurazione del santuario di Ariadello, la festività della Madonna, che la comunità soresinese ha sempre celebrato, nella seconda domenica di maggio. La tùurta de Riadél è una sorta di torta margherita, “fàta cöös sùta la sèner e li bràazi de’l camén (fatta cuocere sotto la cenere e le braci del camino)”. E se non vado errato, un tempo, per questa festa di maggio, in un compendio di folklore, ritualità gastronomica popolare e sport, si facevano pure le corse in bicicletta.
Per riassumere quanto sin qui detto, la mia breve relazione ha voluto rappresentare un modestissimo contributo alla campagna di sensibilizzazione che è in atto per modificare una situazione che vede in Italia quasi cinque milioni di tonnellate di prodotti alimentari buttati annualmente (non solo avanzi di cucina, ovviamente, anche se circa il 30% del cibo acquistato finisce in pattumiera), per un valore di 8 miliardi di euro. Non v’è dubbio, dunque, come scrive l’amico Valerio Ferrari <
---------------------------------
Agostino Melega, bolognese d’origine e cremonese di fatto, ama definirsi “esteta dell’identità padana”, nelle vesti di cultore delle tradizioni popolari, del folklore e dei vernacoli propri della storia dei popoli vissuti nell’areale del Po e dei suoi affluenti. Egli ha collaborato, come esperto di queste espressioni culturali con RAI 1, RAI 2, RAI Tre, con radio Colonia, la radio degli emigrati italiani in Germania, con il periodico nazionale “Cammino” e con tutte le fonti della comunicazione cremonese di massa, giornalistica, radiofonica e televisiva.
Ha ideato e realizzato, con la collaborazione di amici e di vari enti istituzionali, grandi manifestazioni folkloriche, quali I Màascher, I dé de la fümàana, l’Autosbüürla e la Festa del Torrone. Ha scritto sei commedie in dialetto, portate tutte sulla scena, due libretti sui giochi di una volta, ed ha curato la silloge delle poesie in dialetto di Emilio Zanoni, sindaco di Cremona per dieci anni. Da quarant’anni, Melega tiene, sui temi della cultura identitaria cremonese, conferenze all’Unitré di Cremona, l’Università della terza età.
Suoi saggi d’approfondimento sono stati pubblicati sulle antologie de “La Strenna dell’Adafa” e de “La Scuola classica di Cremona”, oltre che sui “Quaderni della Delegazione di Cremona” dell’Accademia italiana della cucina. E’ sposato; ha due figli e cinque nipoti, e si propone a quest’ultimi come “nonno ludens”, come divertito animatore, per impazzire insieme a loro di gioia tutte le volte che viene da essi convocato.