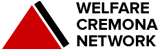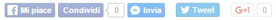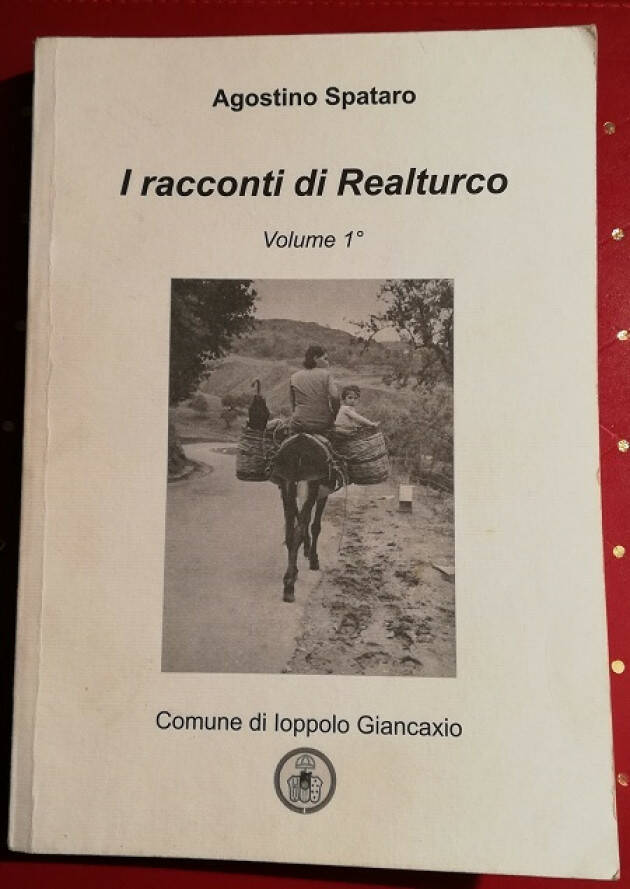I racconti di Agostino Spataro L’ORTO DEI MELONI *
Può succedere che immagini ed episodi lontani nel tempo riaffiorino alla mente, nitidi, come se fossero accaduti il giorno prima. Talvolta, la patina del tempo conserva e migliora la qualità del ricordo, anziché sbiadirla. Alta definizione della memoria o nostalgia, desiderio di ritorno al passato?
Qualunque possa esserne la causa, tale marcia all’indietro spesso si giustifica con lo squallore della vita presente. Quanto al futuro si naviga a vista, fra gli scogli.
Il nostro piccolo mondo dei ricordi diventa così il bene più prezioso. Ciascuno ha il suo e lo custodisce come un giardino segreto. Naturalmente, anch’io sono stato custode geloso del giardino dei miei ricordi. Ora ho deciso di aprire il cancello agli eventuali visitatori.
*Si era intorno alla metà degli anni ’50. Agli inizi del mese di giugno, mio padre trasferiva la famiglia dal paese in campagna, nell'orto di meloni e pomodori che coltivava in contrada San Benedetto, una placida piana di terre feraci distesa fra Aragona, Favara e Agrigento.
D’estate, quasi tutte le famiglie si trasferivano in campagna. I benestanti (burgisa) per controllare i raccolti, i mezzadri e le vigne: i coloni e i braccianti per coltivare l'orto di meloni.
In paese restavano i pochi impiegati e gli artigiani in compagnia di un nugolo di disperati senza terra né lavoro. La coltura del melone giallo (detto “di gelatu”) era una tipica tradizione locale e costituiva un'attività integrativa del misero reddito del bracciante.
In tutto il circondario, Ioppolo deteneva una sorta di esclusiva di tale prodotto, come un marchio Doc. Quell'ortaggio saporito, dalla pelle gialla ricamata da misteriosi ideogrammi, era il principale sostegno dell'economia delle famiglie povere.
Chi voleva “fare l’ortu” doveva pregare un proprietario per ottenere un terreno. Pregare, sempre pregare! Mai diritti. I poveri dovevano sempre pregare qualcuno. Non solo i santi, ma anche qualche potente di paese. Ai possidenti conveniva dare il terreno poiché con l’orto (così come con le leguminose) si preparava un’ottima “maisa" per il grano. Ossia alternando le colture, si consentiva al terreno il tempo di “riposare”.
Anche la vecchia madre-terra era rispettata, aveva diritto al riposo, non era super sfruttata, maltrattata come oggi accade. Le richieste erano tante e i proprietari alzavano il prezzo della concessione. Pretendevano qualche quintale di meloni o di pomodori come compenso.
Fu così che un gruppo di braccianti, fra i quali mio padre, decisero di andare oltre i confini del territorio comunale, di esportare la coltura in quella vasta piana.
L’appezzamento cambiava, ma sempre all’interno dell’ex feudo San Benedetto di proprietà del barone Saguto di Favara e di un certo cavaliere Salamone di Aragona. Su queste terre regnavano alcuni voraci gabelloti che si arricchivano rubando ai proprietari e sfruttando i piccoli coloni.
In altre circostanze, in altri luoghi i derubati avrebbero realizzato un accordo per eliminare l’intermediazione parassitaria e mafiosa.
Purtroppo, la pigra e gaudente nobiltà siciliana la preferì ai coloni, ai braccianti.
*Sul finire di maggio, ancor prima della chiusura delle scuole, iniziava il conto alla rovescia in attesa della partenza. In quella campagna, attraversata dalla linea del treno, si svolgeva la nostra vacanza. Mia madre si occupava dei preparativi. Raccoglieva il necessario e ne faceva "trusce".
Il trasferimento avveniva a dorso di un asino che mio padre aveva battezzato "Vastianu". Partivamo di buon’ora, attraverso la campagna desolata, come un gruppo di nomadi beduini alla ricerca di un luogo, dove impiantare la tenda. Nel nostro caso, il pagliaio.
L’itinerario era sempre lo stesso: s’imboccava la discesa della Fontanazza, verso il Passu di Ragona dove s’incontra un fiumiciattolo secco d’estate e turbolento d’inverno.
Indi, la salita verso le Maccalube, “Fimmina morta”, Pozzo della Cravunara, Fontana Zorba, Stazione Caldare. Da qui si apre la piana di san Benedetto che giunge fino alle pendici del colle di Agrigento.
Per il trasloco erano necessari due o tre viaggi. Si trasportava lo stretto necessario: le terraglie, le masserizie, alcuni capi di biancheria, gli arnesi da lavoro, il piccolo pollaio domestico e, quando c’era, anche il maialino.
Per quanto gagliardo e paziente, l’asino faticava a portare il carico. Una volta si bloccò a metà della salita verso “Cravunara” per fare pipì. Non volle più ripartire, nonostante i colpi delle verghe di "gruche".
Per alleggerirne il peso, mia madre smontò. Solo allora si mosse il bel citrullo. A me e a mia sorella Zina fu concesso di restare accucciati ognuno dentro un “cartìddruni” (cestone di canna e di vimini).
Ondeggiavamo dentro quei cestoni come quegli esploratori assisi sulla groppa di un elefante nella giungla indiana. Potevamo ammirare l’arido paesaggio, i nudi calanchi che l'acqua aveva scavato nei millenni.
A destra, il pianoro grigiastro delle Maccalube, piccolo e bizzarro deserto, punteggiato da vulcanelli di fango, nelle cui viscere si annida un mistero. Maccalube, (dall'arabo Maqlub = caos) luogo mitico della nostra infanzia, per noi era tabù. Nessuno poteva accedervi per timore che si avverasse la terrificante profezia di Beniamino: tutta l'energia del sottosuolo si raccoglierà in quel punto e la terra esploderà oscurando il cielo e il mare. Quel giorno, sarà l'apocalisse a Maccalube. Guai a chi si troverà nei paraggi, perché sarà inghiottito dalla terra come fu inghiottita la Cartagine siciliana.
Da sinistra, giungeva l'incessante gracidio dei rospi che annunciava l’imminenza del pozzo della Carbonara, uno dei "malpassi" di questo circondario. Un tempo, non molto remoto, era infestato di bande di briganti senza cuore che calavano come avvoltoi sulla povera preda, a spogliare i braccianti mietitori della misera paga settimanale. Questi erano gli “eroici” briganti siciliani! Rubare ai poveracci e inchinarsi davanti ai feudatari. Molti di questi falsi “Robin Hood” divennero “burgisi” rispettabili e capi mafiosi.
Dopo Carbonara, il paesaggio muta come d'incanto. Lo stretto sentiero pare segnare un discrimine fra il deserto d'argille e le terre grasse della piana, dove si stendono boschi di mandorle e d’ulivi, eleganti quintine di pistacchi e solitari carrubi, gli alberi di zorbe, vere delizie invernali.
Il passo della Carbonara rappresentava il punto critico del tragitto. Ancora vi si aggirava qualche brigante. Perciò, papà batté l'asino par affrettarne la marcia.
Vastianu, giunto dinanzi al pozzo, si bloccò di nuovo e cominciò a ragliare, rivendicando il rispetto di una vecchia consuetudine: quella dell’abbeverata.
Trangugiò un’intera “bagnera” d'acqua fresca e ripartimmo.
Il " pagliaru" era già pronto. Mio padre e Lillo l’avevano costruito nei giorni precedenti, seguendo una tecnica antica. Con assi di legno e steli di “zabbara” (agave) alzava lo “scheletro” che si ricopriva con fascine di stoppie gialle di grano (fasci di ristuccia).
Somigliava a un “tucul” africano: partiva da una base circolare (4-5 metri quadri) e culminava a punta. Aveva una sola bocca d'entrata e uno sfiatatoio sul retro.
Mia madre preparava il lettone ovvero un materasso imbottito di paglia o di crine che occupava l'intera superficie della capanna. Dormire sul materasso era un privilegio riservato alle donne e ai bambini. Gli uomini, cioè mio padre e Lillo, dormivano fuori (a lu stiddratu) sopra un giaciglio di stoppie.
*In campagna, l'uomo regola la sua giornata con il sole. Nella torrida estate siciliana il sole si trasforma in un tiranno implacabile: egli è dispensatore di luce e padrone del tempo. Taluni lo temono e vorrebbero che non spuntasse mai. Per noi bambini, invece, l'alba era l'inizio dei trastullamenti.
Ci turbava un po’ il tramonto per le sue ombre e, soprattutto, perché ci costringeva ad andare a letto subito dopo la frugale cena.
Cena? In realtà, si trattava dell’unico pasto caldo che la sera riuniva la famiglia. Non c’erano piatti, ma un grande vassoio (chiamato "tazza") cui attingevamo tutti i commensali. Ricordo le montagne di spaghetti o di “pasta di zitu”, innaffiati con sugo di pomodoro fresco e foglie di basilicò sopra uno strato di melanzane fritte. E sopra tutto, formaggio di capra a volontà.
Per noi era una pietanza comune, quasi quotidiana. Con il tempo scopriremo che era “la pasta alla Norma” ossia uno dei piatti più rinomati e aristocratici della cucina siciliana. Un altro piatto di largo uso era “u pani ammugliatu" (pane inzuppato) in una minestra di "tinnirumi", (un'erba dolciastra) insaporita con olio d'oliva e qualche spezia.
Mio padre si alzava molto presto la mattina. Prima del sole. Ogni tanto mi svegliavo anch’io a quell’ora. Lo vedevo partire in direzione di Aragona e poi scomparire dietro la chiesa della “Zorba” verso Passofonduto, dove lavorava in un cantiere stradale. Dieci chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. Venti chilometri, quasi sempre, a piedi. Ogni giorno.
La sera, quando il sole era al tramonto, io e mia sorella Zina gli andavamo incontro.
Lo aspettavamo sotto un albero di acacia spinosa che cresceva sul ciglio del pianoro. Scrutavamo l’orizzonte dal caos delle Macalube alla stazione Caldare. A quell’ora, molti uomini si muovevano su quella lettiera d’argilla. Ombre che il sole cadente proiettava, bislunghe, sulle stoppie tosate, oltre la regia trazzera.
Ombre erranti dentro un reticolo di sentieri invisibili, dentro una trama di fili di ragno di cui solo loro conoscevano le vie d’uscita. Camminavano lesti, sospinti dalla fame. Strano, invece che debilitarli, la fame sembrava fortificarli. Correvano perché sapevano che li attendeva il pranzo odoroso, in famiglia.
Era lui, nostro padre, la nostra cara ombra, l’uomo che ci aveva generati e che s’ammazzava di lavoro e di fatica per farci crescere sani e dignitosi. Ricordo il suo odore acre, di polvere imperlata di sudore.
La giornata lavorativa di un operaio, di un bracciante durava otto ore e “tanticchia”. In realtà, quel “tanticchia” era un’altra ora rubata dai padroni. Mio padre fu un gran lavoratore e un gran camminatore. Nella sua lunga vita avrà macinato chissà quante migliaia di ore di lavoro e decine di migliaia di chilometri, a piedi.
Nel suo quotidiano andirivieni, raramente trovava un passaggio sui camion o su qualche carretto.
*A quel tempo, si usciva dal disastro della guerra, dalla barbarie dei rapporti sociali. C’erano la Costituzione e le leggi della Repubblica, ma in Sicilia la “legge” era sempre la stessa: quella del re e quella, più obbrobriosa, della delinquenza. O quella più edulcorata, ipocrita dei “proverbi” pensati e usati per regolare il sistema delle relazioni sociali e politiche. Invece che alle leggi democratiche si ricorreva ai proverbi, ai luoghi comuni e, all’occorrenza, al nerbo di bue.
I proverbi erano/sono pillole prodotte in laboratorio da abati condiscendenti e letterati codini ammessi alla mensa dei blasoni con il compito di mantenere il popolo ignorante e superstizioso. Per tenerlo lontano dalla rivoluzione democratica, dalla modernità.
A ben pensarci, gran parte della cosiddetta “cultura contadina” ha poco di contadino e molto di tale filosofia retrograda che ha manipolato, condizionato il genuino modo di essere delle popolazioni rurali.
In Sicilia furono alzate dighe contro le idee dell’illuminismo, contro le conquiste napoleoniche. Lo spirito della rivoluzione francese restò di là del Faro. L’Isola fu tagliata fuori dai processi d’innovazione e di progresso civile. Si perse un’occasione storica, decisiva per ottenere libertà e dignità e un’identità certa.
E senza dignità, la povertà diventa insopportabile, degenera in bassezza, in sconcezza morale.
Contro tale stato di cose si sono svolte lotte poderose per la terra, per il pane e per la libertà.
Purtroppo, con scarsi risultati. Molti siciliani, meridionali sono andati a cercarli all’estero. In gran parte li hanno trovati. La nostra emigrazione è stata anche questo: ricerca, riconoscimento dei diritti civili, umani.
E d’estate, quando gli emigrati tornavano con le loro mogli bionde, alla guida di automobili di lusso c’era sempre qualche vecchio padrone che masticava amaro e ogni tanto sbottava: “I jardina siccaru e i munnizzara jureru”, dove per “giardini” dovevano intendersi loro, i proprietari schiavisti, e per “mondezzai” gli ex jurnatara emigrati in Belgio, in Germania.
Ero un bambino e non sapevo che mio padre, uomo semplice, schivo e silenzioso, un anti-eroe tutto lavoro e famiglia, aveva già dimostrato, con i fatti, una stupefacente forza di volontà contro i due più terribili mostri apparsi sul suolo d’Europa nel XX secolo: il fascismo e il nazismo.
Pietro Spataro, classe 1912, fu uno dei pochissimi che rifiutarono di prendere la tessera del Fascio pur avendo in famiglia una “camicia nera”, un membro della milizia fascista.
L’otto settembre (1943) lo sorprese sul fronte albanese. Rifiutò, con altri suoi commilitoni, di combattere sotto i comandi degli eserciti nazisti e repubblichini. Con lui c’era un altro ioppolese, il signor Domenico Sprio. Insieme affrontarono la deportazione nei lager nazisti in Germania pur di non rinnegare il giuramento al re. Non perché monarchici, ma solo per “fedeltà alla parola data” - mi confidò molto tempo dopo- “e poi questi fascisti non mi sono mai piaciuti”.
Furono circa seicentomila i soldati italiani deportati dai nazi-fascisti. La gran parte perirono di fame, di stenti, di freddo o sotto il piombo vile delle SS e dei bombardamenti. Pochi tornarono. Dopo morto, ci fu consegnata una medaglia del presidente della Repubblica Italiana a ricordo di questa tragica avventura dalla quale uscirono dopo tre anni di guerra e due di lavoro durissimo, bestiale nei lager, (li chiamavano “gli schiavi di Hitler”) a pane e acqua e “scorce” (scorze) di patate. Ne andiamo fieri.
Ogni mattina, di buon'ora, mio padre si recava, a piedi, a lavorare presso un’impresa di costruzioni che operava sulla statale per Palermo, mentre Lillo, a dorso d'asino, andava nei paesi vicini (Aragona, Comitini, Favara) a vendere meloni e pomodori per le vie. Mia madre era sempre preoccupata per questo ragazzino di 14 anni mandato allo sbaraglio per sentieri impervi e posti malfamati.
A mezzogiorno cominciava la penosa attesa. L'angoscia traspariva dal volto tirato di mia madre che, forse, si sentiva anche un po’ in colpa. Si agitava per un nonnulla, scrutava continuamente l'orizzonte. Una piccola macchia nera lì, sul fondo la rincuorava; poi, improvvisamente, spariva e la gettava nella costernazione. Con noi non si confidava, ma percepivamo il suo stato d'animo. Filavamo dritti, perché al minimo screzio erano botte. Finalmente, all’orizzonte appariva un'altra macchia, un’ombra in movimento. La vedevamo imboccare il viottolo sotto il “ponte di ferro” della linea ferroviaria dietro il quale c’era il nostro orto. Mia madre si sentiva rasserenata; con la sua bella voce intonava una canzone della giovinezza. Per noi questo era il segnale della serenità ritrovata. Potevamo correre incontro a Lillo che tornava. Felici di ricevere una caramella “pipirita”.
Al calar del sole, la stessa scena si ripeteva, anche se con meno trepidazioni, per l'attesa dì mio padre di ritorno dal cantiere. Solitamente, compariva da dietro la piccola selva di "gruche" che ostruivano la vista della stazione ferroviaria. Fra me e Zina si svolgeva una gara a chi per primo riusciva “a toccare papà”. Correvamo, a piedi nudi, sulla terra dura, spumante di arsura. I nostri piedini erano talmente incalliti da essere insensibili perfino alle punture di spine secche di una macchia chiamata "piscialasimu" che cresceva ai bordi del viottolo.
Durante le “vacanze” le scarpe erano abolite. Si andava scalzi per l'intera estate. Le scarpe si usavano soltanto nei mesi freddi e piovosi. Papà, che è stato sempre un tipo riservato e timido, ci accoglieva con un sorriso mite, appena accennato, e prendeva in braccio il secondo arrivato. Spesso toccava a Zina. Non capivo questa stravaganza. Il premio al secondo e non al primo? Talvolta, per protesta, scoppiavo a piangere e così riuscivo a farmi prendere in braccio da papà. Mi piaceva sentire l'odore del suo sudore che impregnava la camicia a quadri, accarezzare la sua barba leggermente ispida.
*Il nostro nomadismo ci portava in quella vasta piana attraversata dalla ferrovia e dalla statale per Palermo. Due infrastrutture importanti sulle quali si svolgevano una parte rilevante dell’attività economica e il dramma sociale di molti paesi dell’agrigentino.
A Ioppolo non c'è mai stata la ferrovia. Il treno era un miraggio. L’avevamo visto soltanto al cinema. Per noi era un grande privilegio vedere passare tutti quei treni. Davvero tanti in un solo giorno. Ce ne potevamo vantare con i nostri amichetti che mai avevano visto un treno vero. A ogni passaggio, correvamo “a salutare” il treno. Dalle carrozze una mano rispondeva al saluto. Con quel gesto, l'ignoto viaggiatore diventava nostro amico.
Con il tempo, acquisimmo una perfetta padronanza dell'orario dei vari passaggi. Dentro il “pagliaro” c'era una sveglia e all'ora prevista correvano sotto il "ponte di ferro" in attesa del “nostro” treno sbuffante col suo pennacchio nero. Da Agrigento partivano lunghi convogli per il continente e “littorine” per Palermo, per Grotte, Canicattì, Caltanissetta, fino a Catania che portavano famiglie di migranti e carcerati.
In senso contrario marciavano i treni-merci che dalle miniere di Casteltermini e d'Aragona, di Comitini, di Racalmuto trasportavano pani gialli di zolfo e monticelli di candido salgemma all'imbarcadero di Porto Empedocle. Talvolta, la nostra gioia s' impietriva quando, in coda al convoglio, scorgevamo una o due carrozze con le finestrelle sbarrate e sopra il tetto gli sfiatatoi per la presa d’aria. Erano carrozze speciali che due/ tre volte il mese trasportavano i carcerati da una prigione all'altra.
La vista di queste carrozze mi procurava un senso di mestizia, un dolore cupo che m'impediva perfino di salutare. Quel treno trasportava un’umanità irredenta, reclusa che, a suo modo, si ribellava contro un sistema sociale iniquo.
In quell’epoca, la giustizia era marcatamente di classe. In genere, il sentimento popolare parteggiava per il condannato ritenuto vittima di un’ingiustizia, di una prepotenza. Fra il popolo era diffusa una sorta di solidarietà verso chi incappava nelle grinfie della legge. Anche perché in carcere andavano solo i poveracci. Solitamente, si trattava di ladri e di ladruncoli o d'incauti protagonisti di faide insensate, di tipi irruenti accusati del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, di mariti traditi che avevano lavato con il sangue l’onore macchiato. Era ancora in auge il delitto d’onore, frutto amaro di un codice barbarico che lo Stato democratico aveva recepito nel suo ordinamento. Confesso che una delle più grandi soddisfazioni che ho provato durante il mio mandato parlamentare fu quella di votare per l’abolizione di quel vergognoso articolo.
In galera c’erano anche tanti assassini per legittima difesa ossia quelli che erano riusciti a premere il grilletto un attimo prima del loro aggressore. Raramente finivano in galera i grandi truffatori, gli intrallazzatori delle tasse e i loro protettori altolocati, i don e i cavalieri che in ogni paese facevano e disfacevano le cose.
*n pomeriggio di una giornata torrida, imboccai la direzione della palma solitaria che svettava da uno spuntone di roccia sulla quale sedeva la villa rossa del barone Saguto. Mi avvicinai senza incontrare né cani né uomini di sorveglianza. Il portone era aperto ed entrai.
Mi ritrovai all'interno dell'ampia corte, frastornato dalle meraviglie. La dimora baronale, di un rosso pompeiano, si alzava sopra le case basse della servitù. Solenne e sfacciata, occupava l'intero lato est. Una posizione ideale che favoriva l'esposizione ai tepori del sole mattutino e del meriggio ed evitava il caldo cristallizzato di mezzogiorno.
Una vasta terrazza, adornata con balaustre di marmo rossastro di Custonaci, si protendeva fin sopra le case basse dei coloni. Al centro della terrazza c’era un tavolinetto in ferro lavorato, con sopra un libro aperto, le pagine sfogliate dal vento, e un bicchiere.
In un angolo, vicino alle stalle, alcuni uomini rudi chiacchieravano accostati a mucche ruminanti. Erano in attesa del turno per la monta. Era quello uno dei giorni stabiliti nei quali il toro del barone, famosissimo in tutto il circondario, concedeva le sue prestazioni a pagamento. Una bestia magnifica, potente della quale si narravano meraviglie. Per gli allevatori il toro era un mito, una sorta di star del cinema. Per i tanti smargiassi di paese era un termine di paragone, un sinonimo di benefico eccesso, indicatore di straordinaria potenza sessuale.
Era descritto come un ammasso di muscoli coperti da un bel mantello di pelo nero e lucido. Aveva una testa enorme, ricoperta di ciuffi riccioluti e sormontata da un paio di corna corte e appuntite.
C’era chi osava spingersi con la fantasia fino al mitico Minotauro di Cnosso.
La bestia riusciva a servire anche 10-12 vacche il giorno. Fortificava la razza, perciò le sue prestazioni erano assai richieste in tutto il circondario. Nei giorni di monta, c'era sempre la fila dietro la porta della grande stalla, dove il toro operava. I bovari venivano per appuntamento, secondo un calendario. Insomma, un esemplare raro che rendeva "maregni" (monete) d'oro al signor barone.
Adorato e temuto come un mostro sacro della tauromachia, nessuno osava avvicinarlo per timore della sua reazione. Ben nutrito e controllato a vista, raramente lasciava la stalla in cui viveva, legato con catene alle caviglie, praticamente in cattività.
L’unico che riusciva a trattarlo era zi Peppi detto “cazzeri" poiché di mestiere era un manipolatore di peni bovini. Era questi un bovaro sulla sessantina, eternamente impregnato di lezzo stallatico, che il signor barone aveva assunto per affidargli la mansione esclusiva di badare al benessere del toro e di assisterlo nella sua importante funzione riproduttiva.
Zi Peppi, lusingato da tanto privilegio, si dedicava anima e corpo alle cure del toro per il quale selezionava i migliori foraggi e le più belle fave del magazzino. Ogni sera, prima di mandarlo a nanna, lo ripuliva dei parassiti, lo lavava, lo strigliava e gli preparava un decotto di un'erba afrodisiaca che cresceva soltanto nel letto del fiume Drago. Il dosaggio di quell’intruglio così benefico era segreto e faceva gola a tanti (umani) che desideravano emulare le prodezze del toro del barone.
La vera perizia di zi Peppi “cazzeri” consisteva nell’assistere il toro durante la monta, specie quando l’animale non si comportava secondo la norma.
Talvolta era svogliato, faceva lo schizzinoso, si negava, rifìutava la prestazione. Per stanchezza o per altro. Chissà? Chi mai poteva leggere nel pensiero di un toro?
Zi Peppi, che lo conosceva bene, riusciva a intuire il suo disagio. Gli parlava all'orecchio in una lingua strana, gli carezzava il collo e poi la pancia e giù ancora verso i genitali.
Finalmente, il toro partiva alla rincorsa diritto dentro la “inizza” (vacca giovane) che attendeva legata a un anello della mangiatoia.
Poteva capitare che il toro, seppure benintenzionato, non riuscisse a penetrare la vacca. In questi casi, zi Peppi interveniva prontamente in suo soccorso: con le mani afferrava il poderoso membro e lo guidava… nella giusta direzione.
*Nonostante l'intenso movimento ferroviario cui assistevo mai ero salito sopra un treno. Chissà quali sensazioni proveranno quelle persone, sedute comodamente, mentre il treno fila come il vento, a cento all'ora? Desideravo fare questa esperienza. Purtroppo, non c’era stata l'occasione.
I nostri viaggi erano tutti uguali e sempre a trazione animale. Il nostro treno era Vastianu. Povera bestia!
Una sera mia madre mi annunciò che l'indomani saremmo andati ad Agrigento, in treno. Accolsi la notizia con la più viva eccitazione. Finalmente, si stava per avverare il sogno. Indossai il vestito della festa. Mi sentivo imbracato, goffo ma felice di partire, nonostante lo strazio ai piedi per via delle scarpine divenute troppo strette. Andando a piedi nudi, il piede cresceva a vista d’occhio.
Ci avviammo verso la stazione Caldare, contento di fare la conoscenza con il mio amico treno. Salimmo su una littorina affollata di viaggiatori. Presi posto sulle gambe di mia madre. Fuori la magia della natura che il treno attraversava come una saetta. Vedevo correre i campi gialli di grano e i filari di cipressi snelli; correvano le case, i “pagliara”, i muretti di pietra bianca lungo i sentieri polverosi. Vidi correre anche il nastro orto di meloni e le galline.
Potenza del treno! Anche il nostro piccolo mondo di campagna era impazzito. Il caos cessò alla prima fermata, alla stazione bassa di Agrigento. Qui scese molta gente. La littorina si alleggerì e prese come un respiro profondo per affrontare la salita verso la Centrale.
Procedeva a rilento, a tratti a singhiozzo, pareva aver perduto la baldanza di prima. In piedi, accostato al finestrino, ammiravo il superbo spettacolo dei paesi intorno: Raffadali, Montaperto, anche Ioppolo. Poi la visione, immensa, del mare “carta di zucchero” (l’azzurro preferito da mia madre) con le sue onde quiete, luccicanti che andavano a infrangersi sui moli del porto empedoclino. Sotto la valle, con le sagome eleganti dei templi dorici, la nostra Grecia che resiste a tutti i malanni.
La massa azzurra mi sconvolse. Era la prima volta che vedevo il mare. Ne avevo tanto sentito parlare dai nostri migranti che tornavano dalle Americhe. Ne parlavano come di un mostro instancabile, ingordo che certe volte inghiottiva perfino i grandi bastimenti. N’ebbi paura. Ora la visione del mare che si apriva ai miei occhi era di una serenità stupefacente.
Eravamo arrivati ad Agrigento, la cittaduzza di Pirandello, che, dopo avere abbattuto le torri medievali, ne stava innalzando altre "moderne", pretenziose in cemento armato. Una sfida alla selva dei campanili delle chiese barocche. La città ci inghiottì. Mia madre mi teneva per mano. Aveva paura del traffico caotico: automobili rumorose, un tram che sferragliava per via Atenea accanto a carretti, a carrozze affollate, a eleganti calessi decappottati trainati da cavalli pettoruti. Per le strade un formicolio di gente indaffarata. Mìa madre camminava lesta, senza molto badare a quella confusione che a me parve uno spettacolo bellissimo, eccitante.
Sconoscevo la destinazione del nastro viaggio. Chiesi a mia madre e finalmente mi disse che stavamo andando dal dentista per farmi cavare una mola “purrita” (carìata). Non ero mai stato da un dentista.
La via Atenea era tutta un gran spettacolo. Come allocchito, ammiravo le vetrine sfavillanti dei negozi, le cataste di tessuti dei “panneri”, i tanti caffè che allora erano luoghi di socialità, d’incontro e di conversazione.
La via era affollata di persone che procedevano in entrambe le direzioni. Gente di paese e di città costretta a muoversi, a fatica, nell’intenso traffico veicolare.
Per il resto, la via era un corridoio animato da coppole nere, grigie, da qualche raro fez, residuo di uno stile importato ormai al tramonto. Ogni tanto, s’incrociava un elegantone in doppio petto che ostentava un cappello sontuoso. Per noi il cappello era simbolo di potenza, di ricchezza. Difatti, in paese, lo portavano in pochissimi: il medico condotto e il cavalier Lampasona. Pensai che ad Agrigento dovessero esserci molti medici e cavalieri…
(Joppolo 10 /4/ 1994)
* (testo revisionato da “I racconti di Realturco”. Due volumi pubblicati a cura del Comune di Ioppolo Giancaxio- 2017)