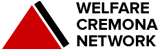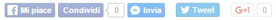L’ARTISTA ARNALDO GIROLDINI (“OTELLO”) | Agostino Melega (Cremona)
Una trentina di anni fa, per la precisione il giorno di Natale del 1989, Rosella ed io invitammo a casa nostra Arnaldo Giroldini, un artista allora legato alla scuola pittorica di Sergio Tarquinio.
Arnaldo, chiamato “Otello” dagli amici, oltre a donare ai suoi quadri una energia e una palpitazione inusuali, conservava nel suo eloquio un vernacolo cremonese diamantino, più unico che raro, nel quale la metafora sguazzava libera e creativa, andandosi ad intrecciare con un uso dei proverbi nemmeno ricercato, tanto esso era naturale, vivo e zampillante nel frasario usato.
Otello, se lasciato viaggiare senza ostacoli con la parola, diventava un torrente in piena, una cascata dirompente di termini che s’inseguivano gli uni accanto agli altri, nell’innesto di una collana di sillabe colorate di toni e d’accenti inimitabili.
Egli veniva ad approdare, sorprendentemente, a soluzioni linguistiche che sembravano inventate, lì sul momento, tanto esse apparivano inaspettate e nuove, ed invece erano stupendi reperti d’un vocabolario luminescente d’antica foggia.
Quel vibrare di parole – una volta saputo il contesto nel quale Otello l’aveva ereditato ed appreso – mi si presentò come il distillato di un linguaggio non più partorito da una singola ed effervescente persona, ma come la reliquia d’un intero ed ininterrotto levigar di lingua appartenente ad un collettivo, ad una comunità intera.
Otello era infatti il figlio di quella popolazione cremonese di gergo, che ha creato l’immagine, la cifra identitaria, il riferimento comune inciso nell’antropologia dell’antica ‘Contrada del Cannone’, di quel rione popolare definito in dialetto con i termini di Stràada Canòon, chiamata anche dai più affezionati nostalgici Stràada Càna.
Dagli episodi raccontatimi da Otello anche in seguito, ho avuto la sensazione che in quel rione non ci fosse molto discrimine, molta distanza e differenza fra teatro e vita, fra il dramma e l’esistenza. Devo confessare che il nostro artista mi incantava sempre nel parlarmi di com’era un tempo la vita in quell’angolo di città “dùa gh’éera de töt (dove c’era di tutto)”, al centro di un mondo in cui la miseria e la promiscuità copulavano e del quale i giovani abitanti di Stràada Canòon o del confluente San Bòsol (san Bassiano o Bassano) erano come dei gelosi autoctoni.
Nella nostra lunga frequentazione (per tredici anni siamo stati vicini di pianerottolo, in via Maffi 17, al “Cascinetto”) mi parlò spesso, da novello Danilo Montaldi, dei personaggi della ‘leggera’ viventi in quel mitico rione, e me li presentava come se fossimo entrambi davanti ad una moviola di un film in bianco e nero del neo-realismo italiano. Come non ricordare la messa a fuoco dell’immagine degli sfrattati e della gente della caserma Pagliari confinante con Stràada Canòon?
Con i suoi sišòon (ragazzi sporchi e indolenti), chiamati della ‘Corea del Sud’ che si contrapponevano a cudulàade (con tiro di sassi) a i regàs de’l gašaghèer (ragazzi del chiacchiericcio simile a quello delle gazze) di San Martino e definiti come quelli della ‘Corea del Nord’. Fra i vari personaggi della memoria figurativa di Otello, vale a dire fra i protagonisti del film orale del produttore e regista Arnaldo Giroldini, ho trascritto in un quadernetto, per ricordarli bene, gli attori di strada chiamati Gratantòni, Màangia-fuòoco, Papòon, la Vàca Ròja. Così come ho annotato le comparse del film mnestico otelliano: i suldàat della ‘Manfredini’, le madalèene dei due postriboli della zona, i fióoi de la bòs (della boxe, del pugilato), e tutti quegli uomini e donne spesso sdentàat (sdentati), perché “gh’éera mìia la mùtua (non c’era la mutua)” che “la te pasàava i dèent (che ti passava i denti), e che “a fòorsa de biasàa i ghe metìiva dò ùure (che a forza di masticare biascicando impiegavano due ore)”.
Tutto questo mondo – mi diceva Otello – dove “gh’éera mìia el diabéete (non c’era il diabete), e dove “a fòorsa de óof, de làt e de pàan bescót (a forza di uova, di latte e di pan biscotto) de pansòon ghe n’éera mìia (di gente con la pancia prominente non ce n’era proprio). J éera töti màagher impìch! (Erano tutti magrissimi!)”.
E come dimenticarmi del mondo dei ragazzi di quell’epoca lontana descrittami dal narratore Otello. Non erano certo uguali a quelli del romanzo “I ragazzi della via Pál” dell’ungherese Ferenc Molnár, ma avevano lo stesso, identico spirito delle lögie (monelli bislacchi e scapigliati) de Stràada Càna. Gli arnesi del lavoro ludico di questi ultimi erano le fionde, i tirasàs (tirasassi), le sghìe (sassi acuminati), le càne de fréce (le cerbottane), simboli in qualche modo di tensioni e di contrapposizioni pesanti proiettati nel gioco di monelli disordinati, ossia, per essere ancor più chiari, erano i segni speculari di ben più accentuati contrasti fra gli adulti.
Otello mi diceva che le persone adulte di Stràada Canòon, morse dal bisogno e dalla fame, dopo essere stati protagoniste di liti verbali e non fra di esse, trovavano di botto la pace di fronte all’idea, al progetto, e alla preparazione meticolosa di spedizioni ‘particolari’ nel contado.
Mitico divenne nella storia del rione il ricordo del furto delle “trèenta furmàge a’l Furcél (trenta forme di formaggio al caseificio del Forcello)”. Un furto per inedia, progettato collettivamente, anche se eseguito solo da alcuni, ed il cui bottino venne suddiviso in tantissime parti, non solo destinate a dare sollievo a stomaci rinsecchiti, ma piuttosto usati per ripartire e condividere la responsabilità di quel reato con tutta la collettività presente in quell’angolo urbano. Era come saldare un rito di ‘caccia grossa’ con la vita dell’intera tribù dei contradaioli, come a voler segnar l’identità e i confini del quartiere, e tratteggiare col cibo rubato e ripartito una specifica identità ed alterità, ossia la differenza contingente di un clan di famiglie rionali con il resto della città indifferente.
A detta di Otello non mancavano però rapporti di buon vicinato e di condivisione, per certe missioni nei pollai del vicinato, con rappresentanti di Piàsa Antunéla, vìa Magèenta, vìa de la Tùr, ed anche di vìa de i Mìle. Nel virtuale confine d’appartenenza con questo largo ‘Quartiere Basso’ era pure interessata anche via Massarotti, ma solo per gli abitanti “de la pàart de chì (della parte di qui)”, visti appunto in relazione di vicinanza e d’esclusiva integrazione con la comune chiesa intitolata a san Bassano, a San Bòsol (san Bassano), il santo patrono di Lodi, edificio connotato della semplicità di una santella rurale, frequentato anche dalle löge e dai loro genitori di Stràada Càna.
Sulla strada dei ricordi, nell’eloquio di Otello uscivano riferimenti ad una carrellata di persone che attraverso il nomignolo, la scutumàja, assumevano la valenza immaginifica di personaggi non omologabili, non clonabili, non riproducibili: Cialóoncio, i fradéi Làber e Nóoda, Tanìin, Mèru, Cicàlo, Carlòon Bišéla; e poi ancora, in questi disegni di fantasia, in questa sintesi seriale della parola fattasi materia in quadri dialettali attraverso il rilievo di persone in carne ed ossa: Cicèt, fióol de la Cicéta, Arnàj, i fradéi Pòta e Pòpa, Candešìna, che non potevano essere sicuramente confusi con Rišòt, Gnàgnu, Parmèt, Mariòon e le Pìle, Giachéta, Bràci, Niclèt, Patòon, Milòt, Giabò, Ciùi, né tantomeno potevano essere scambiati con Franšùa, Giàna, Ughèto o con Sclàavo, singolare figura ricordata più volte con accenti affettuosi anche da Ugo Tognazzi, in films ed interviste. Diverse di queste persone, quando avevano bisogno di telefonare, o di essere chiamate per telefono, passavano per il negozio di frutta della zia di Otello, che coabitava con lo stesso nostro pittore-narratore, e che svolgeva anche questo servizio di telefonia pubblica a beneficio di tutti. Da qui la conoscenza viva e vissuta di Otello con i personaggi dei quali abbiamo ricordato i soprannomi.
Altra nota caratterizzante l’epoca del secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta insomma, era questa: la più parte della gente del rione aveva el lavandéen o sicèer (lavandino o secchiaio) all’aperto. E nel descrivermi con precisione questo scenario, pensavo ad un Otello ben in grado di proporsi come sceneggiatore nella compagnia di Eduardo De Filippo, pronto a trasferire quei ricordi sulla scena; tutta questa vita di povertà e di rude semplicità si trasformava, insomma, in un canto pittorico, ma senza alcun lamento, crudo e terso nella sua realtà storica.
Un giorno Otello mi ricordò pure la grande rivalsa sportiva dei ragazzi del rione, con riferimenti gioiosi alla locale squadra di calcio giovanile, la mitica Juventìna, emblema dell’orgoglio della contrada negli anni ’50, avente sede nell’osteria della Cooperativa, e vincitrice di memorabili trofei in incontri sul campo sterminato dello Zini. Il primo di questi, il 6 luglio del 1952, con la vittoria della Coppa Bernamonti, sulla squadra dell’Alba di san Bernardo. Il secondo, al termine del campionato provinciale juniores del 1954, nel quale in premessa tutti avevano il terrore sportivo nei confronti della Marini, della Lisetta, della Scassa, della Mazzola e della Leoncelli, con il trionfo, in uno spareggio drammatico con la stessa Scassa, per 3 a 2.
La squadra, che veniva apostrofata beffardamente dagli avversari “de i strasòon (degli straccioni)”, lasciò lo Zini fra un tripudio di folla entusiasta e lo scampanellio immediato di biciclette dalle góme pièene (gomme piene) si sparse per la città, annunciando a tutti la grande vittoria.
In quella squadra giocava, quale terzino sinistro, Aristide Guarneri, chiamato col soprannome di “Varistu”. Partendo dall’entusiasmo della “squàadra de i strasòon”, dopo qualche anno, “Risti” sarebbe diventato, con la mitica Inter di Helenio Herrera, per ben due volte campione d’Europa e campione del Mondo fra club internazionali, con la vittoria di due coppe dei Campioni e di due coppe Intercontinentali. Una piccolissima rivincita su quanti, qualche anno prima, avevano le maglie tutte nuove, diversamente dalle proprie tutte usurate.
Era la rivincita degli abitanti dei “quartieri bassi”, di tutta Stràada Canòon e dei suoi alleati delle vie contermini. S’illuminava Otello nel portare alla mente l’orgoglio e la vivacità della sua gente, umile e cara.
Bisogna inoltre aggiungere che, insieme allo sport, quel rione popolare amava la musica, il canto. Infatti i suoi contradaioli riempivano i loggioni dei due teatri cittadini, il Ponchielli e il Politeama Verdi, ogni qual volta vi fossero state opere in programma. E si accendevano discussioni nelle sere successive. Il melomane è anche tifoso e si trasforma inevitabilmente in accusatore o in difensore ad oltranza. E la piazzetta di san Bassano si trasformava in tribunale e in teatro all’aperto, perché dopo aver processato quel o quella cantante, tutti si mettevano a cantare. Molti coristi della corale del Ponchielli provenivano da qui, mi diceva Otello, così come da qui proveniva il grande baritono Aldo Protti.
Il nostro artista Arnaldo Giroldini un giorno, dopo aver studiato ed essersi innamorato della storia del popolo degli Incas, mi mostrò le teste forgiate in terracotta di quella gente amerinda. Fu quella l’occasione nella quale egli mi regalò un suo quadro in cui era dipinta una grande lanca del Po.
E ora, ogni qual volta guardo quella tela, vedo specchiarsi in essa il suo sorriso maliardo e soddisfatto. Ed allora lo saluto con la mente e col cuore: ”Ciao, Otello, me desmentegaròo màai de té”.
Agostino Melega (Cremona) 6 giugno 2020