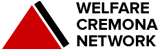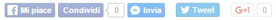Un piccolo immigrato in pée per tèra (a piedi scalzi) | Agostino Melega (Cremona)
Ebbi a scoprire la bellezza della campagna di Annicco nell’estate del 1955. Ero giunto con la famiglia, in questo paese del Cremonese, da Sant’Agata Bolognese nel novembre dell’anno prima, insieme alle mie due sorelline Agnese ed Anna e papà William e mamma Laura.
A Sant’Agata avevo iniziato la prima elementare dalle suore dell’ordine di Santa Clelia da Budrio, ma dopo quasi due mesi mi trovai in mezzo a nuovi scolari che anziché il grembiule portavano una blusa nera e che parlavano con la maestra Giovannina Bozzetti in una lingua strana che non capivo per niente. Seppi, da adulto, che il dialetto era interdetto allora dalla normativa scolastica, ma la maestra per farsi capire bene lo usava intelligentemente. In quei frangenti, quell’idioma era familiare a tutti, tranne però che a me, ultimo arrivato.
Non capivo nemmeno perché mi chiamassero “Melegòt” (“Granoturco”) oppure “Melegàs” (“Gambaccio del granoturco”). Quando ebbi ragione di pensare che fosse una presa in giro, applicai le regole che avevo imparato fin dall’asilo delle suore di Sant’Agata: usare i pugni senza disdegnare il bastone. Dopo l’uso di questa forma comunicativa vivace, contro quello che oggi viene chiamato “bullismo”, fui finalmente rispettato. Da “Melegàs” divenni semplicemente “el Bulugnées” (“il Bolognese”), ma questo lo sentivo quasi come un titolo onorifico. Nel contempo, ancor prima che le lezioni dell’anno terminassero, avevo già appreso il dialetto usato dai miei compagni di scuola. Parlavo finalmente anch’io col “mì”: “mì stòo bèen chì a Nìch” (io mi trovo bene qui ad Annicco).
A farmi da guida nella lussureggiante campagna del paese fu una banda di bambini capitanata da Mario Zanoni, che aveva un anno più di me. La meta affascinante, che mi avrebbe donato in seguito moltissime emozioni, era un fosso colatore: la Gabriéela, posta non molto lontano dagli argini e stagni di Acqualunga Badona.
Tutti i bambini della banda erano in “pée per tèra” (a piedi nudi) e mi chiesero a che cosa mi servissero i sandali. Provai subito un senso di vergogna e di inferiorità. Allora, dopo un po’ di strada, nascosi le calzature nei pressi del campetto sottostante le scuole elementari. E quindi ripresi con gli altri, molto divertiti, il cammino da scalzo, attentissimo ad ogni sassolino lungo la strada, che mi appariva davanti agli occhi come un braciere. Fu una vera e propria prova d’iniziazione per essere accolto in modo ufficiale e gradito da quel clan infantile, che si era divertito a vedermi camminare come una gallina zoppa. Per arrivare alla “Gabriéela”, superato il ponticello della “Giüseplìna” (piccolo fosso posto ai piedi del castello dove fu imprigionato Cabrino Fondulo da parte dei Visconti, nel XV° secolo), ci si inoltrava, per giungere a “la Gabriéela”, lungo una strada in terra battuta che portava al mulino chiamato “la Bùusca”, provvisto di una definizione dialettale che veniva a creare come un curioso riferimento ad un bosco coniato al femminile, come se si volesse indicare un mitico e misterioso “bosco-mamma”, o meglio, il segno di una selva matriarcale e cupa.
Giunti a “la Bùusca” bisognava ancora proseguire il cammino ed attraversare, per fare presto, un campo coltivato, e poi finalmente si giungeva al sito del fosso, accolti dalla frescura di un gruppo di platani rigogliosi, che venivano a costituire, come per magia, una sorta di quinta vegetale dietro la quale potersi nascondere nel caso di visite improvvise di qualche adulto curioso, o peggio ancora di qualche genitore in cerca della propria prole inselvatichita.
La prima volta che arrivai al mitico colatore non feci il bagno: non avevo con me le mutande di ricambio. Vidi alcuni bambini buttarsi nell’acqua nudi. Quella cosa lì a me però non piaceva, non andava proprio bene. Altri bambini invece avevano tratto le proprie mutande da bagno dalle cavità degli alberi, come se quei tronchi fossero degli armadietti, come quelli in uso nelle società canottieri “Baldesio” o “Bissolati” di Cremona. Il nascondimento delle mutande lo feci anch’io in seguito, andando a cercare e scegliere il mio personale “armadietto arboricolo”, il mio buco vegetale, dopo aver sottratto da casa, senza essere visto, un paio di quegli intimi ed indispensabili “slip”.
A proposito di quei giorni, mi ricordo pure i sottili strati di sabbia su quegli argini ed il profumo dell’erba cipollina; così come mi ricordo il concerto bellissimo dei merli, delle tortore, delle cince, ed il nido di un’anatra selvatica con l’uovo dentro in uno stagno posto oltre la Gabriéela.
Mi rammento bene pure il fosso posto al di sopra del luogo deputato dei nostri bagni. Lì un giorno mi azzardai a tuffarmi. La corrente era molto forte ed io mi trovai sotto l’acqua in grande difficoltà. Mi tirò fuori un ragazzo grande e simpatico, che aveva tre anni più di me, Mario Perucca. E dopo questo salvamento mi prese in giro in paese per alcuni giorni, facendo il mimo delle mie smorfie da quasi annegato. E rideva Mario nel raccontare l’episodio. E io lo lasciavo ridere, mentre mentalmente continuavo a ripetergli il mio “grazie”, dopo averglielo detto più volte a voce.
Tornai molte altre volte a fare il bagno alla “Gabriéela”, senza mai più entrare nel fosso traditore che sovrastava di traverso, con tutta la sua boria, la fonte del piacere natatorio di tanti bambini. Certo che la cosa fu problematica quando mia madre si accorse, nel conteggio della biancheria, della mancanza di un mio paio di mutande. Ed allora dovetti dire la verità e riportare a casa quel pezzo d’intimo corredo. E fui costretto a chiedere “la copertura da bagno” in prestito al mio clan di riferimento. La prima volta mi venne detto di prenderle da un gelso ai bordi del campo. Ma erano troppo larghe. Correvo il rischio di essere chiamato poi per sempre “Müdàanda” e le andai a rimettere dove le avevo trovate. L’estate a “la Gabriéela” finì lì.
Mia madre mi spedì infatti come un pacco da mia nonna Giuseppina, a Sant’Agata Bolognese, dove per fare il bagno si andava nei maceri della canapa vicino ai casolari in campagna. Ma erano siti molto pericolosi. Avevo sentito la storia di un bambino annegato. E lì il bagno non lo feci mai.
Agostino Melega (Cremona)
2 maggio 2020