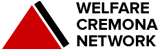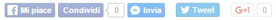Nessuno deve aver pensato di poter replicare il modulo aggregativo e comunicativo delle “sardine”; manifestamente estraneo, per tipologia di location e di mission, agli intendimenti della flash mob di Largo Priori.
Nell’immaginario, nelle consapevolezze e nelle determinazioni è apparsa visibile e palpabile una sollecitudine che rimanda ai “ranini”; vale a dire alla fascia degli utenti-cittadini, messa sotto schiaffo da un provvedimento, ancora in itinere, ma dagli approdi difficilmente equivocabili.
Pur non appartenendo né direttamente né indirettamente alla fattispecie (che ci iscriverebbe alla casistica dei portatori di conflitto d’interesse) e volendo comunque dar conto di un raro evento di mobilitazione dalle motivazioni feconde, vi abbiamo partecipato, inizialmente, con animo inzuppato di tristezza e di sconcerto. Ma ne siamo usciti con uno spirito improntato, qualunque saranno gli esiti, di speranza.
Per un risultato di aggregazione civile non scontato, né nelle dimensioni né nei propositi.
Ci é piaciuta la compostezza, che ha fatto premio sia sulla cognizione della gravità del problema sia sull’identificazione del timbro comunitario come unica e potenzialmente feconda risposta.
Una volta tanto si sono mobilitate in tale spirito tutte le “parrocchie” politiche, a prescindere dalla collocazione rispetto alle alleanze locali, regionali e nazionali e dai diversi tassi di corresponsabilità dei rispettivi terminali nell’adozione del provvedimento.
La constatazione costituisce una positiva novità nel modo di fare politica. Ed in omaggio a ciò evitiamo, almeno stavolta, ritorsioni e reprimende a carico di chi avrebbe dovuto intervenire, indipendentemente dalle superiori ragion di stato.
I portatori delle coccarde e dei palloncini gialli hanno rappresentato una bella amalgama di campioni anagrafici, di rappresentanza sociale e politica, di modo di comunicare.
Insomma, un bel gesto comunitario ed una bella pagina di coesione, entrambi scomparsi per tanto tempo dalle abitudini e dalle testimonianze della vita pubblica, urlata ma sorda a sentire le ragioni degli altri.
Ma sbaglieremmo se non facessimo uno sforzo per cogliere, in aggiunta al buon esito della manifestazione, quello che per noi è un sentiment e per la controparte è un rumor.
Non proprio a macchia d’olio o a tappe forzate ma non è difficile cogliere nella contestualità della denuncia e della mobilitazione nel capoluogo come in altre località, direttamente od indirettamente interessate dalle conseguenze del contestato provvedimento, una consapevolezza ed una volontà di risposta. Che, come nel caso di Casalmaggiore, è approdata ad un inizio di gradualizzazione delle contromisure. “Le imposte e le tasse pagate dal territorio provinciale hanno la stessa dignità di quelle pagate nell’area metropolitana e nelle aree coccolate dal potere regionale. A ciò deve corrisponde un pari standard di qualità e di accessibilità.”, si è sostenuto sul Listone.
Un principio questo da cui si sono ben tenuti distanti i governanti lombardi; che con i ridimensionamenti prima tentati all’ospedale di Crema, poi con la soppressione del centro nascite dell’Oglio Po e, da ultimo, con il ridimensionamento della medicina d’urgenza e la soppressione dell’UTIN hanno mostrato, ormai senza alcuna possibilità di fraintendimento, dove vogliono parare.
A brigante brigante e mezzo: non si può più tergiversare e traccheggiare e ritenerci appagati dall’effetto annuncio di questa riuscita mobilitazione.
Sia pur partendo da un incipit tematico, ha sviluppato, infatti, ben percepibili richiami a contesti più vasti. Che, per quanto si riferisce alla tutela ed alla rappresentanza complessive della negletta provincia, determinare consapevolezze e definizioni potenzialmente in grado di incidere in modo significativamente diverso dal passato nel rapporto col potere politico-istituzionale di livello superiore.
La bella addormentata, che è stato il territorio marginalizzato sia nei progetti strategici sia nella destinazione delle risorse e dei servizi, sta mostrando segni di risveglio dal torpore, in cui è stata precipitata, per larga parte, ad opera di una manifesta sottovalutazione dell’establishment politico e, per una parte non esattamente trascurabile, dalla propria incapacità di condividere un’idea comune di sé e da un clamoroso under statement nel correlarsi e farsi valere coi padroni, si sarebbe detto un tempo, del vapore decisionale.
La classe dirigente territoriale, inchiavardata in un contesto mai entrato né nel concept né nel sentiment di comunità frazionate e dislocate in una dimensione longitudinale di oltre 120 chilometri, ha plasticamente rinunciato nell’ultimo quarto di secolo a riannodare i fili di un destino comune e a rappresentarli convenientemente.
Affinché entrassero quanto meno nel range dell’ascolto e delle potenziali opzioni.
Non sempre fu così. Per effetto di due circostanze. La prima si richiama alla configurazione di un passato che nella scansione storica può essere definito recente (secondo dopoguerra); in cui il ceto politico locale seppe esprimere (attraverso parlamentari fortemente collegati al “collegio” ed attraverso protagonisti della scena nazionale) una significativa rappresentanza del territorio. La seconda, invece, riguarda e ad un tempo spiega l’attenuazione del potere di rappresentanza, come effetto collaterale della polarizzazione dei meccanismi di designazione delle posizioni elettive. Se si eccettua, infatti, la fattispecie del centro-sinistra rimasto per alcuni versi ancorato alle designazioni dal basso, l’altro versante (peraltro stabilmente maggioritario) ha quasi sistematicamente escluso dalla rappresentanza parlamentare la selezione locale.
Mentre restava sola prerogativa locale (ancorché) la filiera della designazione all’interno dell’istituzione regionale.
Ciò in quanto la modifica del codice genetico dell’antico associazionismo politico (in cui convivevano paritariamente le prerogative generali ed il forte ancoraggio alla territorialità) e la transizione al modello della verticalizzazione politica, ha finito per omologare alla leadership politica la priorità del mandato territoriale.
D’altro lato, questo processo di verticalizzazione politica è progredito specularmente alla verticalizzazione della catena di comando delle istituzioni e della strutture operative.
Il cambio di passo dalla pratica consociativa al modello maggioritario non poteva non avere una rimodulazione degli organigrammi.
Come abbiamo considerato in un precedente approfondimento, la chiave di volta della transizione dall’originaria lettura della struttura territoriale del SSN, che in qualche misura era rimasta aderente alla sanità pubblica ed alla rappresentanza della rete istituzionale locale, al nuovo format si ebbe con l’ “aziendalizzazione”. Vale a dire con la cosiddetta riforma sanitaria attuata durante il ciclo formigoniano, che trasse origine dalla legge 31/97.
La quale, appunto, stabiliva l’aziendalizzazione della sanità e la divisione delle funzioni tra Azienda sanitaria locale e Azienda ospedaliera. L’Asl (che poi avrebbe cambiato nome e giurisdizione territoriale) diveniva il soggetto coordinatore nella programmazione socio-sanitaria. Nel cui divenire è stata esclusa qualsiasi pur vaga idea di partenariato con l’espressione degli interessi originari degli ambiti territoriali.
Dopo oltre vent’anni di non sempre onorato servizio, si può motivatamente concludere che questo modello sanitario lombardo, caratterizzato da aziendalizzazione verticale e da forte tasso privato, (con cui si è tentato di certificare un rating AAA (che di eccellente ha solo un’asimmetrica destinazione di risorse e di carichi, oltre che un’indubbia destinazione ad utenza d’alta fascia) ha finito per massimizzare la spesa (senza un corrispondente livello di efficienza e qualità dell’offerta). L’ineludibile rientro, specie dopo gli “splendori” di un governatorato, assimilabile per durata e modalità ai regimi totalitari , imporrà inevitabilmente una politica di tagli. Il cui preannuncio sembra, da un lato, preservare i privilegi della sanità privata, passata, salvo qualche graffio, quasi totalmente intonsa dagli scandali) e, dall’altro, mirare a provvedimenti di “razionalizzazione”. Che di ottimizzazione hanno solo la pretesa di ridimensionare la periferia della struttura sanitaria, specie quella ospedaliera. Settore al quale, peraltro, la sollecitudine delle direzioni monocratiche non era stato fatto mancare quasi niente.
L’ampio range delle facoltà d’azione di esse, infatti, è strettamente interfacciato alle prerogative della struttura politica centralizzata.
Dall’assessorato regionale, tanto per intenderci, promanano rules of engagement; che non ammettono margini interpretativi in capo ai prescelti (su basi selettive assolutamente discrezionali e funzionali ad una forte subordinazione al potere politico); i quali agiscono da valvassini quando non da capitani di ventura.
E men che meno ammettono margini di interlocuzione sia nella filiera interna dell’organigramma (che non sia la mera trasmissione/metabolizzazione delle linee) e, figurarsi, nella fattispecie del (doveroso) rapporto con l’utenza (che ne è il destinatario finale) e con le istituzioni del territorio.
Alla luce di un siffatto inquadramento del modello operante ed imperante (sulla cui fattualità accettiamo qualsiasi sfida) non stupisce lo stupore della Direzione Generale, i cui vorticosi turn over sono tra l’altro alla base di una non perfetta conoscenza della struttura e dell’utenza.
Ma chi se ne frega!!!, pare di leggere, come suggerì Bush senior, sulle labbra di qualche impudente autocrate che ha stimato come impossibile qualsiasi reazione.
Si deve al coraggio del civil servant, che è il primario (nel frattempo quiescente) artefice dell’eccellenza in fase di smantellamento, se non è passata, come si dice gergalmente, in cavalleria questa bella impresa.
Oh…certo, ma dov’è il problema se si tratta solo un centinaio di “ranini”, nati oltre che sotto peso ai limiti di minimalissime prospettive di sopravvivenza e di crescita?! Se i rispettivi mamme, padri, nonni dovranno (a meno che il parentado non sia catalogabile nella famiglia Addams o nella matrigna di Biancaneve) probabilmente per non pochi mesi sottomettersi alla routine quotidiana del trasferimento alle strutture bresciane (talmente eccellenti da essere, in barba al rispetto dei parametri, addirittura due, di cui, ça va sans dire, una privata)? Con l’ovvio carico di spese, tempi, negativi riflessi sul lavoro (di cui non si è minimamente voluto tener conto).
Destino comune alla cugina utenza cremasca, che, comunque priva dell’Utin, verrà indirizzata (sulla base di parametri trilussiani) non alla struttura cremonese (che così avrebbe potuto conseguire le condizioni di sostenibilità e di conferma), bensì a quella di Pavia.
Quest’ultima chicca, da un lato, dimostra quanto tengano nel dovuto conto i satrapi regionali le ragioni della coesione e della dignità territoriale e della par condicio di accessibilità ai servizi.
Ma, come abbiamo considerato in una precedente riflessione sarebbe assolutamente fuorviante confinare l’incidenza del taglio in un’ottica meramente settoriale.
La “razionalizzazione”, che, come abbiamo ricordato, ha in passato agito sull’Oglio Po, che ha lambito l’apprezzato nosocomio cremasco e che ha lanciato preannunci per la medicina d’urgenza non avrà altro effetto che una dequalificazione sistematica dell’intero presidio ospedaliero del territorio. Oltretutto fungendo da agente della fuga dei vertici medici.
D’altro lato, l’assessorato, che un tempo era della Sanità, ha cambiato nome in Welfare, in esso comprendendo il segmento assistenziale.
E, dato che non vuole farsi mancare proprio niente nell’accanimento contro la periferia, ha già preannunciato una cura dimagrante nella rete territoriale delle RSA.
Il che evidenzia un disegno sistematico di penalizzazione della sanità pubblica e dell’utenza dislocata nella periferia del territorio regionale.
Perpetua filosofeggiava: “mala cosa nascer poveri”. In questo inizio di terzo millennio bisognerebbe soggiungere: “ancor peggio nascere nei territori marginali!”
La testimonianza di ieri accredita l’esortazione di Pietro Nenni: “Non arrendersi mai, non riconoscere mai che non ci sarebbe più niente da fare…”
Specie, quando la portata di un provvedimento, come quello attinente alla TIN, colpisce un segmento dell’utenza, che ha un forte impatto anche simbolico.
POST SCRIPTUM
Nei conversari occasionati dal commiato dal flash mob è serpeggiato, tra partecipanti old fashioned, qualche interrogativo. Cosa farebbe Felice Majori, che dedicò un’intera vita professionale al crescita di questo moderno nosocomio?
Meglio non pensarci! Ma come reagirebbero gli altri grandi apostoli di questa grande realizzazione civile. Gli ultimi dei quali e determinanti furono il presidente e la vicepresidente del Consiglio di Amministrazione impegnati nella progettazione e costruzione (Emilio Priori e Maria Galliani).
Meno di un secolo fa la dotazione sanitaria cremonese era imperniata nel vecchio Ospedale Maggiore ed in quello di Via Ugolani Dati. Avevano le caratteristiche dei vecchi ricoveri di mendicità e, per di più, pur distanti di qualche centinaio di metri, operavano separatamente.
Grande apostolo della loro unificazione fu il socialista Giuseppe Garibotti, il cui know how era stato acquisito grazie al ruolo di impiegato nell’amministrazione ospedaliera.
L’amministrazione socialista eletta nel 1914 con a capo Attilio Botti e nel ruolo di assessore Garibotti (inventore delle aziende municipalizzate), pose tra le priorità sia l’unificazione sia la costruzione di un nuovo unico ospedale, peraltro, nella zona in cui sarebbe stato costruito cinquant’anni dopo.
L’impresa titanica sarebbe stata forzatamente rinviata ai tempi migliori, succeduti al ventennio.
Permase come priorità assoluta in un carnet di emergenze ed in un contesto di povertà.
Private e pubbliche, bisognerebbe aggiungere.
L’opera avrebbe richiesto finanziamenti cospicui che difficilmente sarebbero approdati a Cremona dalle fonti statali.
Il recupero delle risorse sarebbe stato possibile in regime di autofinanziamento; cioè impiegando i lasciti e le donazioni dei cittadini benefattori.
Quanto sopra per dire che in un Paese come il nostro, in cui si attende che i presidi sociali scaturiscano dall’intervento dello Stato e delle Regioni, può sorprendere che una realizzazione significativa come l’Ospedale Maggiore (che maggiore è destinato a restare ancor per poco, considerata la minaccia dei tagli) sia stata voluta e finanziata dai cittadini cremonesi.
Circostanza che fa percepire come ancor più inaccettabile e persino odioso l’accanimento della Regione. Soprattutto, se non si perde di vista il valore civile, come scrisse nella circostanza della scomparsa di Majori, l’indimenticato primario chirurgo prof. Alquati, di quegli “illustri cremonesi illuminati e lungimiranti che hanno reso possibile i riconosciuti grandi risultati dell’organizzazione ospedaliera.”