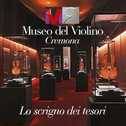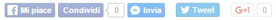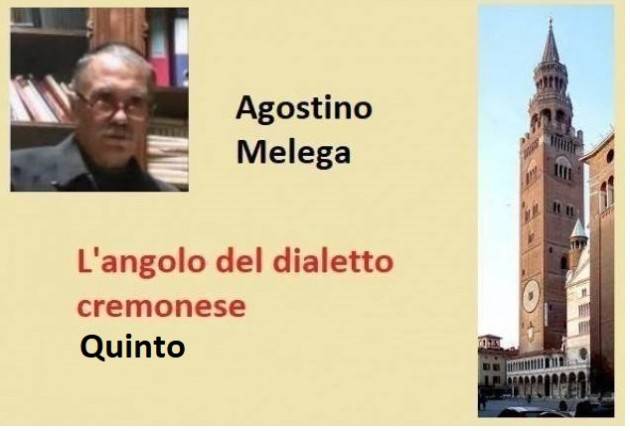ANGOLO DEL DIALETTO CREMONESE (5) | Agostino Melega
LUCIANO DACQUATI, ARTISTA A TUTTO TONDO Nella nostra disamina, siamo giunti ad incontrare Luciano Dacquati, artista della penna e non solo, essendo stato giornalista, scrittore, ricercatore, musicista e cantante.
Anticipo subito col dire che parlare di lui mi è molto caro. Egli è stato, infatti, un uomo generoso, leale, buono, mai stanco e mai sazio di posare mattoni per quella cattedrale dello spirito incompiuta che è il libro della cultura profonda di una comunità, della sua e nostra gente.
La sua vasta opera, i suoi preziosi libri, sono pagine aventi un grande valore antropologico, perché prodotti attraverso la trascrizione delle mille varianti creative della gente cremonese. Un popolo che ha costruito il proprio profilo nel rapporto stretto fra città e campagna, formando una stratificazione complessa di riferimenti e di valori, il più delle volte consegnati solo alla tradizione orale.
Luciano è stato il gran traduttore, il gran traghettatore della vulgata popolare orale, con tutti i suoi straordinari ingredienti, verso la pagina scritta, verso una documentazione che è divenuta nel tempo un faticoso impegno d’amore, una forma di rispetto e di speranza nei confronti delle generazioni future.
Certo, uno strumento fondamentale per questa incessante ricerca è stato il dialetto, el parlàa nustràan, il parlare nostrano, attraverso il quale Luciano ha voluto conservare, dall’usura del tempo, inestimabili valori: le radici della mentalità, della sensibilità e del pensiero di una comunità intera.
Mi ricordo quando mi rivolsi a lui, nel tempo in cui egli non era ancora direttore de La Provincia, chiedendogli il sostegno per la promozione della manifestazione de I Màascher, ossia del recupero del Carnevale cremonese per le strade del quartiere del Vecchio Ospedale, al servizio delle politiche d’integrazione educativa e sociale del Centro di formazione professionale dell’Anffas, presso la quale struttura allora operavo come animatore.
Era la fine del mese di gennaio del 1979. Egli lo fece molto volentieri e mi diede una bella mano con i suoi articoli, cosicché l’iniziativa, partecipata da circa tremila cremonesi, ebbe un successo straordinario. E furono molte altre le circostanze vissute all’insegna di una feconda collaborazione, avvenute sia a casa sua che altrove.
Alla cascina Boccansolo, ad esempio, nei pressi di Gerre de’ Caprioli, dove egli viveva con la sua numerosa famiglia, se brüšàava töti j àn la Vécia (si bruciava tutti gli anni la “Vecchia”), e si recitavano poesie e si cantava. E venne pure il momento di attivare insieme degli spettacoli di beneficenza con la recitazione di poesie in dialetto e canti della tradizione cremonese. Stessa cosa si faceva presso Radio Cremona. Poi, all’improvviso, tutto un quadro esistenziale venne drammaticamente a spegnersi. Era il 7 luglio del 2010. Luciano, in quell’amaro e funesto giorno, a settant’anni d’età, si spegneva.
Per quanto riguarda il dono della poesia, altra primizia della penna di Luciano, porterò qui l’attenzione su una sua composizione dal titolo E dòpo, pö nièent (E dopo, più niente), che meritò nel 1990 il “Premio speciale per la poesia cremonese”, durante il “Settembre Offanenghese”, a cura dalla Biblioteca di Offanengo.
Questo fu il giudizio della giuria del tempo: “Il caratteristico paesaggio padano, ritratto con minuta quanto affettuosa precisione, si pone, nel contempo, come interlocutore e oggetto di osservazione da parte dell’Autore che ne trae ispirazione per meditare in chiave leopardiana sulla brevità della vita”.
E DÒPO, PÖ NIÈENT
En s’cinchél d’üa véerda
marsìs in dèl càamp
tra quàter gašòon
pirlàat de ‘l aràat.
Fümàana in de l’àaria
che sùul, né memòoria,
né ušei, né campàane,
i riès a šbüšàa.
Gh’è gnàanca na bèega
che móof el terèen;
gh’è gnàan na lüšèerta
che pàarla de vìta.
Gh’è nùma en sturlìin
pugiàat a ’n ràm sèch
che vàarda stremìit
la tèra che móor.
E mé, vùuši möt
la mée gràan paüüra
in fàcia a la nòt
che šlóonga i sóo pàs.
La lüüs la delégua.
Dumàan (se ghe n’è)
‘l è amò tròp luntàan;
incóo (chèl che cöönta)
‘l è nùma na brìiša,
na gùsa che séca
nèl röšen de ‘n fòs
che ‘l céerca ‘n pòo d’aàaqua;
la mòolta la quèercia* *ricopre
la vìta che nàs,
la vìta che móor.
E dòpo, pö nièent (2).
E DOPO PIÙ NIENTE. Un racimolo d’uva verde/ marcisce nel campo/ fra quattro zolle/ girate dall’aratro.// Nebbia nell’aria,/ che sole, né memoria,/ né uccelli, né campane,/ riescono a bucare.// Non c’è neanche una biscia (un verme)/ che muove il terreno.// non c’è neanche una lucertola/ che parla di vita.// C’è solo uno storno/ appoggiato a un ramo secco/ che osserva spaventato la terra che muore.// E io, grido muto/ la mia grande paura/ in faccia alla notte/ che allunga i suoi passi.// La luce dilegua./ Domani (se ce n’è)/ è ancora troppo lontano;/ oggi (quello che conta)// è solo una briciola,/ una goccia che secca/ nella ruggine di un fosso/ che cerca un po’ d’acqua;// il fango ricopre/ la vita che nasce,/ la vita che muore./ E dopo, più niente.//
Luciano che non aveva mai condiviso interamente le scelte grafematiche del Comitato che aveva provveduto alla stesura del Dizionario del dialetto cremonese, si distanzia dalle soluzioni dello stesso organismo scientifico, scrivendo, ad esempio, come abbiamo appena letto, dèl càamp, anziché de ‘l càamp.
Così come lo stesso Luciano opta per nèl röšen, diversamente da in de ‘l röšèn come indicherebbero le soluzioni dello stesso Dizionario. E poi vi è una questione aperta, una questione “d’orecchio”, nell’uso degli aggettivi possessivi. Infatti, gli estensori del DDDC e i glottologi estensori delle regole grafematiche indicano -me-, -to-, -so-, quali aggettivi in dialetto per dire mio, tuo, suo e quindi el me lìber, el to lìber, el so lìber (il mio libro, il tuo libro, il suo libro). Ma se si ascolta bene la parlata di moltissimi cremonesi si può decifrare l’espressione el mée lìber, el tóo lìber, el sóo lìber, avente una vocale aggiuntiva nel possessivo. Ci possiamo allora chiedere se essi si sbagliano nell’usare questa pronuncia. Noi crediamo proprio di no. Ma convenzionalmente, aggiungiamo pure, è preferibile scrivere con la “modalità corta”.
Bene, detto tutto questo, diamo l’appuntamento ai lettori per la volta prossima, per incontrare un altro valente verseggiatore, vale a dire Enzo Gerevini (detto “Genzo”) di Piadena.