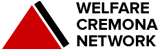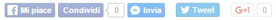IL DIALETTO, SEGNO IDENTITARIO PRIMARIO Agostino Melega (Cremona)
L’esperienza attraversata presso Auser Cremona, con l’attivazione e la cura per tre anni consecutivi di corsi di “Dialettologia d’arte”, mi ha offerto la possibilità di alcune riflessioni sui dialetti nativi e sulle varianti elocutive che il tempo parzialmente ha cristallizzato e che continua a cristallizzare, andando poi ad assumere una varietà di forme nuove in una dinamica storica evolutiva.
Dico “parzialmente” perché detti idiomi hanno una genesi similare a quella dei bozzoli del baco da seta, tendendo quelle stesse forme verbali ad essere caratterizzate, quali strumenti del linguaggio, da una inarrestabile metamorfosi.
Infatti, nelle cellule fonetiche delle parole, albergano sempre dei meccanismi dinamici che possono essere paragonati a quelli delle crisalidi dei bachi da seta, dei cavaléer, per dirla in dialetto, ossia dei bachi che tendono per loro natura ad uscire dai bozzoli stessi e trasformarsi in farfalle.
Anche la parola plasmata, e racchiusa temporalmente nel bozzolo della tradizione, vive, secondo il nostro personale giudizio, lungo il tracciato di una lenta mutazione dettata dal tempo, sotto l’influenza di varie ibridazioni, che portano a trasformare i propri fonemi d’origine in termini inediti, quali fossero nuove farfalle discorsive, le quali, appoggiandosi sulle bocche dei parlanti come nuove parole, vivificano il loro dire in un ciclo espositivo ininterrotto e rinnovato.
Sappiamo dalle mutevoli civiltà della storia che l’uomo, dotato di ragione e di sentimento, onde distinguere una cosa da un’altra, ha creato specifici termini, caratteristici lemmi, atti a differenziare e a distinguere il rimando specifico ai diversi oggetti di riferimento.
Ed ogni lingua locale, nazionale od internazionale che sia, dimostra nel proprio vocabolario la proiezione di tale indirizzo, in una costante attenzione al rapporto fra le cose segnalate e le parole usate per definire e evocare quelle stesse cose.
Va altresì detto che ogni lingua, calata in uno specifico territorio, si muove nel tempo con un proprio particolare codice espressivo. Ed avviene che una stessa cosa venga chiamata nelle varie lingue nazionali e da quelle locali in modi differenti, all’ombra di ogni campanile, con suoni, accenti e toni diversi anche in luoghi non molto lontani gli uni dagli altri.
Ciò dipende dal fatto che nel creare e tramandare le parole natie, le popolazioni locali hanno voluto nel contempo marcare e distinguere in modo preciso, inimitabile, la propria origine, la propria etnia, il proprio clan, il proprio modo d’interpretare il mondo visibile e quello invisibile.
Tale visione identitaria, alla quale la parola fa eco, è stata tramandata in chiave creativa nel tempo, con proprie modalità espressive e descrittive, nel seno di pacifici dialoghi fra persone, diversificando però le indicazioni verbali anche fra popolazioni dislocate, come abbiamo già accennato, a pochissimi chilometri di distanza dai loro siti abitativi.
E sono state perlopiù generate, queste diverse distinzioni della parola, nella fucina verbale della propria casa, nell’ambito della propria famiglia, e alla fonte espressiva nel proprio borgo con i propri consanguinei e con i propri compaesani, o nella propria isolata grangia o cascina.
E lo hanno fatto uomini o donne, fossero essi stati cremonesi, cremaschi o casalaschi, quali saggi bipedi intelligenti, per non sentirsi omologati in una sorta di “broda” indistinta ed insipida, e per non essere confusi col resto del mondo. Lo hanno fatto, al contrario, con l’intenzione di creare, nel modo più naturale possibile, un proprio codice espressivo limitato territorialmente, mirato solo nel voler dare valore e difesa al proprio inimitabile ed ineguagliabile senso d’appartenenza a quello specifico luogo, nel rispetto verso la propria precisa identità antropologica.
E le nostre genti padane, come per tutte le altre genti del globo terrestre, sono andata via via affermando che la loro anima non è in vendita, perché essa non ha l’attitudine e l’istinto di confondersi con l’indifferenziato ed omologante pensiero che pare voler dominare oggi il mondo. Un mondo che pare guidato solo dal mercato globale e dalla musica dei soldi e dalle sirene della grande finanza, orchestrata da qualche sempiterno pifferaio.
La gente dei tanti dialetti invece ha sempre risposto istintivamente in passato nel voler porre un argine nei confronti del rullo compressore di quel pensiero strategico che intende coprire il pianeta Terra con le maglie di un unico manto, attraverso le ristrettezze imposte da un solo ed omologante pensiero. La risposta della gente che ama il parlare di casa, tramandato dagli avi e dalle varie generazioni che si sono succedute, è composta a sua volta da semplici ed umili moti dell’anima, traducibili con poche e chiare parole: “Questo è il mio parlare, questo è il mio vernacolo, questa è la lingua del mio pensiero e del mio cuore”. E mi sento di riaffermare quanto ho appena detto, usando le parole degli amici anglosassoni e francofoni: “Questo è il mio slang!”. “Questo è il patois di casa mia!”.
Questo, e nient’altro che questo, ma è proprio lì il cuore della questione.
“To be, or not to be: that is the question”, fa dire il grande William Schakespeare al suo Amleto, mentre questi entra in scena nel terzo atto dell’omonimo dramma.
“Essere o non essere”, è lo stesso dilemma pure in chiave linguistica, nel cui ambito si colloca il voler essere o non essere figli di una tradizione verbale da rispettare, tutelare e rinvigorire. Oppure, nel caso del diniego, e quindi nel non voler essere tali, non rimane altro riferimento che quello di trovarsi come figli trovatelli e delegittimati, in uno spazio culturale dominato dall’anonimato, dall’indeterminatezza, in una dimensione mentale vaga e confusa.
Il dialetto vuole solo ribadire “io sono unico; ed uso, per esprimere questo concetto in dialetto, il pronome mé, come dicono sia a Cremona che a Crema, oppure mì , come pronunciano ad Annicco, o mè come affermano a Casalmaggiore.
Mé, o mì o mè pàarli cùma màgni o màangi, voci del verbo cremonese urbano mangiàa o del casalasco e cremasco mangià o del soresinese maià, voci verbali che rimandano alle variante cremasca maiá, oppure con magnà, in altra variante casalasca.
“Io parlo come mangio”, non è solo una battuta gergale, perché esiste una stretta sintonia fra le diverse aree linguistiche e le loro specifiche gastronomie. Non credo, infatti, che il bussolano, el bisulà soresinese, sia assimilabile a qualche altro dolce, per il solo fatto d’avere il prodotto un grosso buco centrale.
Non sta in quel buco, infatti, lo spartiacque dell’essere o del non essere, ossia la differenziazione fra un segno d’identità culturale antropologica ed un altro segno diverso seppur simile, ovvero per riconoscere o negare una catena naturale che lega un uomo o una donna ad un prezioso lascito verbale e gastronomico.
Vale a dire il lascito, - rimandando la questione solo al piano linguistico -, di chi ha voluto rivestire di particolari e non riproducibili accenti, e connotati idiomatici, l’umanità di un borgo o di una città, dove altri uomini e donne vivono oggi; la stessa terra amata dai loro predecessori al pari di una seconda madre.
Tutto questo è visto ed interpretato nella cornice di una umanità che ha caratteristiche proprie, peculiari, affascinanti, poste in un quadro d’osservazione prezioso, che assomiglia molto a quella sorta di poetica incantevole che ogni singolo fiore ci offre in un giardino di mille e più colori.
O come, per altro contesto ed altra diversa metafora, veniamo ad esempio attratti in modo ammirato dalle tessere policrome di un mosaico carico d’arte.
Ed è come se ogni tessera assumesse la vibrazione di una parola d’incanto, l’una diversa dall’altra, ed il loro insieme, con i colori dell’iride, vada poi a formare e costituire la bellezza della struttura di quel particolare linguaggio d’estetica d’arte.
Ed allora mi vien da ribadire un’ovvietà: un conto è pensare ad un mosaico, modesto o rustico che sia, ed un altro conto è riferirsi ad un pur pregevole liscio asfalto che, pur gettato in opera in modo diligente, è sempre piatto, monotono, identico dall’inizio alla fine, su una strada amorfa lastricata d’uniformità.
Orbene, mi viene ora pure d’accennare al rapporto fra parola ed ambiente, pensando alla differenziazione delle lingue. Infatti, quando giungo a questo approfondimento, rimango sempre affascinato dal rimando a quanto che avviene nel linguaggio del popolo degli eschimesi.
Quella gente, infatti, abituata al freddo polare artico, ha nel proprio lessico moltissime espressioni – c’è chi ne ha contate quaranta - per indicare una sola cosa: la neve. Sono tutte denominazioni che specificano il diverso modo di scendere delle falde dal cielo e della loro diversa modalità di depositarsi al suolo nel formare il bianco mantello. Ed è sorprendente, come attesta l’antropologo Hugh Brody, che vi sia, fra i tanti riferimenti verbali, uno solo di essi riferito alla neve e al ghiaccio idonei alla costruzione degli igloo.
Questo dato ci conferma di come il linguaggio si radichi e viva in stretta simbiosi con l’areale geografico nel quale e dal quale le parole stesse vengono distillate.
Tornando ai riferimenti nelle nostre zone, dobbiamo dire che, per dati storici ed ambientali oggettivi, le lingue vernacolari della pianura padana non hanno per fortuna idiomi diversificati che rimandano alla neve e al gelo perenne, pur conservando differenziazioni quando si riferiscono, ad esempio, alla brina, con brìna e brinàada (ovvero la gelata con brina), e con altri termini specifici che vanno dalla galavèerna alla galabròoša o galabrüüša o galabröša, senza dimenticare el calìif, termine in uso pure nel Soresinese.
Va detto, ad ogni modo, che i dialetti attorno al Po non sono comunque lingue d’acqua, calda o fredda o gelata che sia. Sono piuttosto lingue di terra, lingue di campo, lingue di fatica, di stagioni forgiate dal sùul ferèent, e dall’umida fümàana dell’autunno e dell’inverno.
Sono questi gli idiomi di riferimento stagionale che i secoli ci hanno donato, in quella sorta di Eden in cui viviamo tutti quanti noi, un paradiso terrestre posto da Dio Creatore fra i fiumi Po, Adda, Oglio e Serio, in un’area topografica chiamata da chi la cerca sull’atlante geografico “provincia di Cremona”.
Quando parlo di dialetto mi viene spontaneo riferirmi inoltre ad una strofa di una poesia dal titolo Lingua e dialettu, del siciliano Ignazio Buttitta, riguardante il valore del vernacolo nel radicamento del senso e del segno dell’identità di un popolo.
La strofa così canta:
Un populu
diventa poviru e servu,
quannu ci arrubano a lingua
adduttata di patri:
è persu pi sempri.
(…)
LINGUA E DIALETTO. Un popolo/ diventa povero e servo,/ quando gli rubano la lingua/ ereditata dai padri:/ è perduto per sempre (...)//.
La stessa strofa mi sono permesso di tradurla così in dialetto cremonese urbano:
En pòpol el divèenta puarèt in càna e servitùur,
quàant i ghe ròba la lìingua in bùca
che ‘l gh’àa ereditàat da i pàader:
per sèemper ‘l è pèers
(e a guadagnàaghe ne gh’è vèers ).
Quello che si vuole affermare con tale rimando poetico è l’idea che senza l’idioma natio, senza la parlata con la quale una terra, un’area geografica, una città, un borgo di campagna si sono dati via via nel tempo quale libera e condivisa scelta, al fine di dotarsi di un veicolo espressivo, di uno strumento locale per palesare la propria particolare modalità interpretativa della vita, la propria autentica identità, avviene inesorabilmente che la popolazione di quel luogo, privata di tutto ciò, si perda in un diafano nulla.
Senza quel dire, accennavamo, senza quella caratterizzazione verbale della propria natura sensoriale ed intellettiva, in termini di veicolo di comunicazione e di relazione interpersonale autoctona; senza tutto questo, quella terra, quella città o quel borgo di periferia sono destinati all’abiura del proprio adamantino sé; sono posti sulla china di un viaggio senza ritorno, come avvolti in un affastellarsi linguistico avulso dal quella interiorizzazione che porta una persona a caratterizzare la propria immagine, la propria inimitabile sembianza.
Quella persona rimane allora inghiottita da una babele parolaia generica, amorfa, piatta, diafana, povera e soprattutto propedeutica a diventare soprattutto “serva” del mondialismo anonimo, come attestano per l’appunto i versi del grande poeta palermitano.
Agostino Melega (Cremona)
Giugno 2020