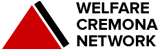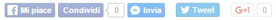Scoprire nel pieno di una grave pandemia che la propria industria farmaceutica dipende per alcune componenti essenziali da un solo produttore cinese, non è piacevole; soprattutto se questo produttore si trova nel paese che è all’origine della pandemia. Ancora meno piacevole è scoprire che metà delle maschere chirurgiche disponibili, anch’esse cruciali per far fronte alla pandemia, sono prodotte in Cina.
Sono notizie che impressionano, tanto più che si inseriscono in un dibattito in corso già da tempo sul bilancio della globalizzazione. Ad essa sono attribuiti molti pregi (ha sottratto alla povertà più di un miliardo di persone nei paesi emergenti), ma ha anche prodotto un certo numero di inconvenienti come un aumento delle disuguaglianze nei paesi sviluppati. Già prima della pandemia si discuteva di cambiamenti nelle regole per conservare gli aspetti positivi, attenuando quelli negativi. Insomma, per rendere la globalizzazione più sostenibile e più equa.
I fenomeni citati all’inizio puntano però il dito su un aspetto più circoscritto ma non per questo meno importante: l’impatto della globalizzazione sulle strutture produttive. Il suo effetto più importante non è stato tanto sul commercio mondiale in senso lato, ma quello sulla struttura delle filiere produttive. Ormai non esiste più quasi un solo bene complesso che sia concepito e prodotto in tutte le sue parti in un solo paese. Le imprese di tutti i paesi hanno diversificato le loro filiere e catene del valore in modo da ottenere la massima efficienza e minimizzare i costi.
Il fenomeno raggiunge il massimo dell’integrazione all’interno dell’Europa dove avere un mercato unico non significa solo diversificare l’offerta nei supermercati. Significa anche che il latte prodotto in Irlanda del Nord deve diventare formaggio e burro nella repubblica d’Irlanda, per poi ripassare la frontiera per essere consumato (frontiera che Brexit non deve quindi ristabilire). Significa che l’industria automobilistica britannica, sempre dopo Brexit, rischia di perdere il libero accesso ala componentistica che in gran parte ha origine nel continente. Significa che Volkswagen avrebbe difficoltà a riaprire gli impianti chiusi a causa dell’epidemia, se non riaprono anche i suoi fornitori italiani.
Gli stessi fenomeni, anche se in modo meno intenso, si verificano a livello mondiale. Cambiare la catena del valore è ovviamente possibile, ma richiede tempo ed è costoso. Il processo di cui parliamo si è intensificato anche grazie all’internazionalizzazione della finanza.
Già prima dell’epidemia erano nate in Europa inquietudini su un nostro ritardo tecnologico nel settore cruciale della rivoluzione digitale di fronte a Usa e Cina. A questo si era aggiunto il timore che la Cina approfittasse della sua posizione di vantaggio e del suo scarso rispetto per le regole dell’economia di mercato, non solo per avvantaggiarsi della diversificazione delle filiere ma anche per prendere possesso del cuore delle competenze tecnologiche europee.
Non deve quindi sorprendere che fenomeni come quelli citati dell’industria farmaceutica o delle mascherine, siano invocati per chiedere un radicale cambio di rotta: una rilocalizzazione in Europa di parte delle filiere che avevamo internazionalizzato. Qualcosa in questo senso è ragionevole e probabilmente succederà. Da un alto per ragioni strategiche: non possiamo scoprire di non essere padroni delle parti essenziali della nostra industria farmaceutica. Dall’altro perché uno degli effetti della rivoluzione digitale, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, sarà di ridimensionare un po’ alcuni aspetti delle filiere produttive che sono molto dipendenti dal costo del lavoro. Un movimento spontaneo in questo senso era già in atto prima della crisi.
Tuttavia, fare di questo fenomeno la bandiera di una auspicata deglobalizzazione in nome di una ritrovata sovranità europea, sarebbe un grave errore. Dipendere da un solo fornitore è un errore da non ripetere, ma la risposta razionale non è necessariamente o sempre la rilocalizzazione. Può semplicemente essere la diversificazione degli approvvigionamenti.
Inoltre, l’efficienza non è la sola motivazione per l’internazionalizzazione delle filiere produttive. Anche se il mercato interno europeo resta fondamentale, la nostra industria non può separarsi dai due mercati principali a livello mondiale: quello più dinamico e innovativo degli Usa e quello in più rapida espansione in Asia. Per esistere bisogna essere presenti ovunque.
Infine, anche se sono giustificate le opinioni di chi vorrebbe maggiore attenzione alla domanda interna nella strategia economica dell’Ue, non possiamo rinunciare alla nostra vocazione esportatrice. Oltre certi limiti, deglobalizzare può comportare costi elevati; anche perché malgrado la retorica trumpiana gli Usa non deglobalizzeranno e tanto meno lo farà l’Asia. Dobbiamo in sostanza riuscire a distinguere. Da un lato, c’è il problema cinese, che è reale, politico e strategico, oltre che economico e industriale. Dall’altro, c’è il futuro della globalizzazione che è questione molto più complessa.
Del resto non esiste una maggioranza potenziale per una simile politica nemmeno un Europa. Certamente non seguirebbero i paesi del nord e dell’est. Sarebbe anche un errore attribuire significati eccessivi alla recente evoluzione tedesca più attenta a esigenza di politiche industriali e di reazione all’aggressività cinese. La Germania resterà comunque un grande paese esportatore. La bandiera della deglobalizzazione rischia quindi di restare una fantasia francese e italiana. Con l’Italia che a volte dimentica di essere il secondo esportatore in Europa. Strana schizofrenia nazionale.