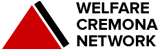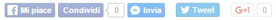LA MAIALATURA di Agostino Melega
Il crudo e ghiotto rituale contadino d’un tempo

*L’alimentazione, l’allevamento e l’ identità comunitaria
La storia dell’alimentazione delle comunità è un tutt’uno con la storia delle civiltà dei popoli. In essa si rifrangono i costumi, le abitudini, la cultura, la dimensione del sacro ed il rapporto che le diverse umanità si sono date nell’interpretazione del soffio vitale e divino che nell’energia del cibo si materializza.
Il legame identitario con un territorio, lo spirito d’appartenenza si sono cristallizzati nel tempo anche attraverso i diversi modi con i quali le comunità hanno declinato l’approccio alla mensa e alla cucina. E, in attesa di esse, vale a dire in preparazione dell’incontro con l’alimento (sul desco, nel convivio, nel banchetto), si sono sedimentati – quel legame e quello spirito – pure nell’approccio con la terra arata e con i coltivi nei campi e con gli animali dall’allevamento.
Così, contestualmente, si sono scanditi parimenti i ritmi dei giorni feriali e di quelli festivi. E con i vari tempi dei pasti, si sono fissate pure le pause della penitenza, dell’astinenza e del digiuno. Vuoto e pieno, crudo e cotto, dolce e salato, magro e grasso sono le icone aggettivate e funzionali di un cammino dell’uomo che, in stato di salute, ha sempre, in chiave naturale e fisiologica, chinato il capo per gustare i prodotti alimentari posti sulla mensa, e con quell’inchino, ora volontario appena prima del pasto, ora meccanico ed istintivo, ha segnato nella postura la sua dipendenza da una dimensione più alta ed altra, come per associare, col capo reclinato, il ricevimento del cibo con l’intimo ringraziamento che il cristiano eleva al Padre per aver ricevuto il pane quotidiano.
E così, anche l’incontro col cibo più semplice, più modesto, più ordinario diventa preghiera, nel momento in cui il gesto è sostenuto dal pensiero verso l’Alto. Diventa motivo d’unione della parte col tutto, diventa contatto e sintesi fra materialità e spiritualità dell’individuo con la materialità e la spiritualità del Cosmo, diventa veicolo dell’uomo verso il Mistero, verso Dio.
Dentro la complessità del rapporto fra costume, religiosità e cibo, in questa cornice così suggestiva, andremo ora ad esplorare la memoria collettiva per riavvicinare al presente un rituale proprio della casa contadina padana di una volta, portandoci con la mente verso quel microcosmo che animava nel Cremonese la vita di cascina.
Ci porteremo insomma verso quella comunità umana che nella vita del quotidiano seguiva con particolare attenzione e con fiduciosa speranza l’allevamento di un animale prezioso: il maiale, concepito come una sorta di cassaforte alimentare.
E ne seguiva la crescita preziosa a favore dell’economia culinaria dell’intera famiglia per l’anno veniente, ponendosi in chiave distintiva propria della specificità culturale ed antropologica locale.
Infatti il maiale rappresentava per la famiglia contadina una sorta di “marcatura di confine”, di specificità originale e culturale in chiave antropologica. Un confine culturale rispetto alle abitudini alimentari dettate dalle fedi religiose di altre civiltà mediterranee, come quella ebraica e quella mussulmana, per le quali il maiale è il più impuro fra gli animali e le cui carni sono profondamente disprezzate.
Certo il tutto è riferito ad un tempo nel quale diversità e convivenza si rapportavano prevalentemente in spazi ampi e lontani ed il confronto non avveniva sui luoghi di lavoro o nelle mense scolastiche. Il problema vero ed unico era quello dettato dal rispetto verso la propria tradizione, in un contesto in cui l’identità col territorio e con la sua storia, per abitudine consolidata, era massima e priva del semenzaio della confusione dettato dall’indifferenza, nemica giurata di ogni delicato distinguo, di ogni opportuno rispetto verso ogni ”integrazione possibile”.
Lo spartiacque padano nei confronti del maiale era posto allora fra il tempo antecedente l’uccisione dell’animale stesso ed il tempo successivo. E questo spartiacque coincideva col momento dell’abbattimento di tale ricchezza animata, venato dall’ambivalenza che ogni atto cruento, a guisa di sacrificio, porta con sé da sempre nel regime della dieta carnea. Il confine era posto fra attesa e tranquillità alimentare; e la barriera, la sbarra, il filo spinato dell’ansia, venivano tolti con grande gioia, nell’incontro col sollievo suscitato dall’adempimento della mattanza.
*Il tempo dell’atto cruento
Il giorno nel quale un tempo veniva ucciso il maiale era contraddistinto da una intensa eccitazione che coinvolgeva tutta la famiglia contadina. Tale occasione veniva vissuta come una grande festa da grandi e piccoli, anche se con modalità emotive del tutto diverse gli uni dagli altri. Per tutti era comune la consapevolezza che attraverso quel rito domestico veniva ad essere raggiunta la sicurezza alimentare per un anno e placata l’ansia costante del sopraggiungere di una sempre possibile carestia, eventualità sottesa alla memoria dal ricordo delle ristrettezze subite dalle generazioni precedenti.
Si scacciava, con la “festa del maiale”, lo spettro sempre incombente della fame, un timore che manteneva un richiamo costante nell’immaginario popolare anche attraverso i racconti serali dei filòs nelle stalle, e proposto pure attraverso la metafora delle leggende e delle fiabe dove vibravano spesso le emozioni dettate dalle laceranti condizioni causate dalle epidemie del passato, dal flagello della guerra, dalle incursioni di briganti e banditi, dallo scompiglio della natura, dallo sconvolgimento fluviale e dalla rapina, dai ratti furtivi e dalle aggressioni delle acque sulle terre padane.
La fame era la pre-condizione della morte, ne costituiva l’annuncio. Da qui è facile intuire come l’animale per eccellenza del cortile, “l’animale-dispensa”, il maiale, venisse considerato a guisa di simbolico liberatore del nesso fra causa e effetto: esso placava la fame ed allontanava di conseguenza la morte. Il maiale, chiamato in dialetto cremonese nimàal o ròi, e nei vari vernacoli padani maièl, pòrch, porsél, pursé, purzèl, gogìn, gugiol, sì, hì, nì, ninàt, ninéin, busgàt e in tanti altri modi, non era però un bene accessibile a tutti gli abitanti della cascina. Solo i più parsimoniosi o i più fortunati potevano permettersi a primavera di acquistare un maialino, en nimalìin, di allevarlo ed alla fine assaporarlo in tutte le sue cento trasformazioni alimentari, vero e proprio re al centro dell’economia e della gastronomia domestica.
Il giorno dell’arrivo in cascina dei venditori di maialini doveva essere un altro grande evento soprattutto per i bambini, per i piccoli protagonisti del mondo rurale. Ne abbiamo la riprova attraverso una testimonianza autobiografica, ambientata in quel di Piadena, e così raccontata dal grande Mario Lodi, in “I bambini della cascina. Crescere tra le due guerre: “( I venditori) venivano dal reggiano, con un carro carico di cestoni e in ogni cestone c’erano tanti maialini. Io e Natalino corremmo là per primi: le belle bestiole erano pulite, di un bel colore rosa, il codino arricciato. Per me erano bellissimi, più dei cani. (…) Ne prese uno anche mio padre e io lo toccai (…) Natalino era felice. Al mattino e al pomeriggio portavamo noi il pasto caldo al maialino, che la mamma aveva preparato. Uno di noi apriva la porticina, l’altro versava il pastone caldo e lui vi affondava il muso. Il pastone era composto da crusca e poca farina gialla e lui vi grufolava dentro facendo le bolle”.
Il maialino cresceva nutrito per tutto l’anno dalla premurosa attenzione di tutta la famiglia, nel quadro di un rapporto di simpatia per non dire di amicizia con i bambini, i quali davano anche allora voce e sentimento al loro mondo animato, molto più articolato di presenze e di realtà fantastiche rispetto a quello dei grandi.
“Ricordo il giorno che l’ hanno ucciso, un giorno nebbioso di dicembre”, scrive ancora Mario Lodi. “Vedere quel povero animale nostro amico, che avevamo allevato fin da piccolo e che era cresciuto piano piano sotto i nostri occhi fino a diventare bello e forte, rovesciato in terra dal macellaio e finire così, con una lancia piantata nel cuore. (…) Lui moriva urlando. Un urlo che si sentiva lontano un chilometro, straziante”.
Ma gli adulti della famiglia contadina non potevano permettersi il lusso di commuoversi o di essere dubbiosi e recalcitranti. Il giorno della mattanza era atteso come la manna da tutto il parentado e gli urli dell’animale agonizzante
erano l’unica parte del copione che, potendo, si sarebbe voluta cancellare.
“La casa pigliava brio fin dalla vigilia, – descrive il folklorista Giovanni Tassoni – con il lungo pestamento delle droghe nel mortaio e la preparazione degli ordigni adatti al sacrificio. La mattina presto, quando arrivava il norcino col raffio e la sporta dei coltelli, l’acqua già bolliva nel paiolo sotto la fornacella”. Lo studioso mantovano ci descrive anche le azioni successive all’abbattimento dell’animale. “La massiccia spoglia veniva adagiata nella lunga conca del bucato e lì, con acqua e raspa, lavata e disettolata. Alla fine, appiccata per le zampe posteriori e squartata a mezzo, veniva portata in cucina sopra l’asse della pasta e, dopo sagace operazione metamorfica, ridotta in lardo e salumi”.
* Un sapere popolare consolidato
Qui è dettata in sintesi tutta una serie di operazioni che la cultura popolare di mestiere ha codificato con precisione protocollare, come avviene oggidì in una organizzazione aziendale che voglia seguire al meglio una procedura di qualità.
Del resto il rapporto fra la storia dell’alimentazione umana e i prodotti del suino è datata in chiave più che bimillenaria. E quindi prove ed errori hanno sostanziato nel tempo la scientificità del metodo, le abitudini e gli approcci secolari sul che cosa e sul come realizzare la trasformazione del suino in cibo. Il norcino, el masadùur, “l’ammazzatore”, dava prova in cascina delle proprie competenze non solo attraverso l’uso dello stiletto e del coltello ma anche attraverso l’abilità propria nel dosare le spezie e nello scegliere le parti adatte per ogni prodotto che si intendeva ottenere, e nell’amalgamare i vari tipi di carne nelle quantità opportune.
Il primo atto sancito dal rantolo senza fine, avveniva all’aperto; un atto che inchiodava nei bambini il limite dell’impotenza e l’amaro risvolto del senso di colpa, così come la cifra distintiva che marcava la differenza fondamentale col mondo degli adulti. Immediatamente veniva raccolto in un recipiente il sangue che sarebbe servito, come vuole da noi la tradizione, e come ci ricorda Gian Carlo Duranti in Una civiltà di porci, per preparare la “torta di sangue di maiale”. Il secondo atto vedeva la scena cambiare: si svolgeva nell’intimità dentro casa e l’animale, el nimàal, trasmutava come altra cosa da sé, assumeva le valenze stratificate delle parti sezionate suddivise dalle coordinate analitiche del salumaio.
Sul grande tavolo della cucina si snodavano i nuovi emblemi culinari: qua i prosciutti e i lardi appena tagliati, destinati ad essere gli ultimi ad essere poi rifiniti e salati; là la carne per salami ed insaccati vari; in un angolo le parti di più immediato consumo. Intanto si disponevano dentro ad una caldaia i grassi in attesa della bollitura, in attesa di quel processo in cui acqua e fuoco s’incontrano per ottenere una vaporosa combinazione, e per forgiare, con rustica e raffinata alchimia, strutto e ciccioli e via di seguito. Il gioco del tutto e delle parti si combina nel rito familiare, finché l’intero animale, dissolvendosi totalmente dalla struttura e dalla forma della sua anatomia, viene portato a riverberare la propria fattezza ed il proprio ricordo solo nell’impasto delle carni tritate che abili mani accompagnano verso la sublimazione gastronomica definitiva.
Ed ecco che un soffio di materia prende corpo in involucri naturali, ecco le particelle di poltiglia suina, ormai manipolabili come un gioco plastico, prendere la via risoluta dell’insaccatura, ecco i budelli accogliere l’impasto in attesa di trasformarsi d’incanto in salami, salsicce, cotechini. “In attesa”, dicevamo, sì, perché per la definitiva classificazione vi è un preliminare non da poco, anzi fondamentale per il buon esito di tutto il processo: la legatura.
Qui occorre una mano risolutamente esperta, pena la beffa atroce di veder dissolvere la fatica nel suo ultimo atto. “Chi fa il salame buono è colui che lo lega”, dice un antico proverbio italico. Ma non è certo finita lì la procedura dell’antica sapienza preparatoria. Ce lo ricorda il testo modenese ’Il signor Porco’, scritto da Alberto Govi, Ugo Preti e Luigi Zanfi, con fotografie di Franco Fontana , sulle cui pagine viene sottolineata l’importanza della fase critica della stagionatura, che inizia col preliminare del penzolamento dalle lunghe pertiche fissate al soffitto della cucina. Qui, infatti, il fuoco continuo per alcuni giorni consente agli insaccati di asciugare nel modo dovuto. Ed è proprio del tempo della stagionatura anche il trasferimento di tutto il prodotto in luogo fresco e asciutto, generalmente nel “cantinetto” in terra battuta, luogo destinato ad essere rimpiazzato poi dalle stanze superiori della casa, là de sùura, dove, saliti dalla scala di legno, dopo una giornata di fatica, prìma se sgulùušia (si desidera ardentemente il cibo che si presenta alla vista), poi si prega, poi si dorme ed infine si sogna.
Certo il rapporto fra desiderio, sogno e mondo dei salami ha portato a favorire nella fantasia popolare l’insorgenza degli elementi costitutivi essenziali per costruire l’immagine del “Paese di Cuccagna”, la grande utopia folklorica, il paese da fiaba per la povera gente, nel quale era risaputo che “quello che più ci dorme più guadagna”, e dove si vedevano e si donavano “per quelli piani tanti li porcelli grassi e sfoggiati a chiunque ne voleva”.
*Il pensiero verso gli esclusi nel giorno dell’abbondanza
Ora, tornando alla sera del giorno della maialatura, va ricordata un’usanza di grande impatto comunitario e relazionale, che vedeva protagonista il proprietario dell’animale ucciso.
Questi, in obbedienza di codici non scritti ma scolpiti nei cuori dalla tradizione, soleva manifestare in chiave allargata e di condivisione il risultato raggiunto, invitando il clan dei parenti e degli amici ad una grande cena, che prevedeva, al suo epilogo, come un accorgimento di diplomazia sociale.
Infatti era previsto il perpetuarsi di una costumanza che andava a valorizzare il segno dei rapporti familiari stretti ed amicali, ma che nel contempo non precludeva l’attenzione verso gli altri, mantenendo un rapporto di non totale esclusione con la restante parte della comunità.
Tale tradizione ci viene illustrata da Giuseppe Morandi in Cremona e il suo territorio (Mondo popolare in Lombardia), con la descrizione dell’atteggiamento degli amici non invitati al convivio. Questi ultimi, infatti, gli esclusi dal banchetto, quando prevedano che la cena fosse finita andavano davanti alla casa di chi aveva ammazzato il maiale e cantavano fuori dalla porta dividendosi in due gruppi, a strofe alternate:
Aprite l’uscio oi bella
Che mi voi végner dénter
Ho qui un bel pacchettino
Te lo voglio regalà
Sebben che voi l’avete
Ma mi non vel turò
Restate pure fuori
A cantare el martinon
Seguiva nel canto per altre tre volte la richiesta dell’ ”Aprite l’uscio oi bella/ che mi voi végner dénter”, con la precisazione di portar via in dono “un fiaschettino”, “un bel mazzolino”, “un bel cappellino”, che provocava quale risposta altrettanti ed identici dinieghi. Finalmente al quinto tentativo veniva espressa la strofa contenente la formula magica dell’ ”apriti sesamo”:
Aprite l’uscio oi bella
Che mi voi végner dénter
Ho qui un bel bacino
Te lo voglio regalà
E adès che voi l’avete
Ades mi vel turò
Venite pure dénter
A cantare el martinon
La porta finalmente si apriva e i due gruppi di canterini ripetevano dentro la cucina dell’abitazione l’ultima strofa.
A quel punto, “le donne – scrive Tassoni - offrivano le eccedenze della cena e versavano da bere il vino nuovo, un po’ torpido, ma tanto cordiale. Se non c’erano altre maialature nelle vicinanze, gli ospiti si fermavano a veglia fino a tarda ora. Le madri allora portavano a letto i fanciulli assopiti; poi quello della fisarmonica intonava un ballabile. Si facevano quattro salti, alla buona.”
Il brano di chiusa della “cena della maialatura” che abbiamo riportato è una variante della “canzone del cappello” o “del Martinò”, o di “Martino e Marianna”, usata nel calendario contadino pure in altre occasioni di festa, ad esempio per “I giorni della Merla” o per il Martedì Grasso.
*Il Teatro del Ricordo di Castelverde
Anni fa ho avuto modo di osservare da vicino tutti i passaggi del rituale della maialatura della casa contadina di una volta. Protagonisti di questa proposta non usuale sono stati i figuranti del gruppo del “Teatro del Ricordo” di Castelverde, coordinati da Danio Milanesi, gruppo che si è dato con successo, il compito precipuo – “la missione” come si usa dire nelle organizzazioni sociali - di riproporre usi, abitudini, tradizioni della vita di cascina in auge prima dell’esodo e del bum economico degli anni ’50 e ’60.
Il momento cruento del rito è avvenuto “dietro quinta”, la mattina presto, lontano al pubblico. Poi tutte le altre fasi sono invece state socializzate, in chiave didattico didascalica, con valenza educativa davanti alla gente. Per i più anziani è stato come ripercorrere un copione conosciuto, una traccia presente nella memoria del “già visto”, nella quale è scritta e ricordata la fatica del lavoro e la complessità dei processi che portano alla squisitezza del prodotto.
Per i più giovani è stata invece una lezione magistrale di presa visione e di conoscenza di come la trasformazione della carne suina in insaccati, in prosciutti e in generi di corollario sia dovuta non alla magia di qualche pubblicitario, ma alla sapienza di mestiere, all’abilità professionale di veri e propri gnomi della miniera dell’alimentazione, che, in questo caso, partendo dalla tradizione contadina locale, dai suoi riferimenti basilari, hanno portato via via nei salumifici cremonesi, in quelli artigianali e in quelli industriali, un corredo di competenze di alta qualità passando, nello sviluppo della trasformazione seriale, il testimone d’un’arte millenaria tesa ad incantare ancor oggi il palato.
Di questo rimangono spesso stupiti i bambini che talvolta, incuriositi, chiedono ai loro insegnanti il nome degli alberi sui quali si sviluppano e crescono i salami, i cotechini e le salcicce. Ovviamente questi sono alberi di un paese similare a quello di Cuccagna, nel quale purtroppo la fantasia dei bimbi d’oggi ha cancellato la presenza del protagonista principale di tale ricchezza alimentare: sua maestà, lo sconosciuto ed intramontabile maiale.
Ohibò, che fare?
Agostino Melega (Cremona)
Febbraio 2021