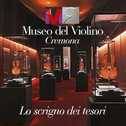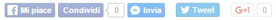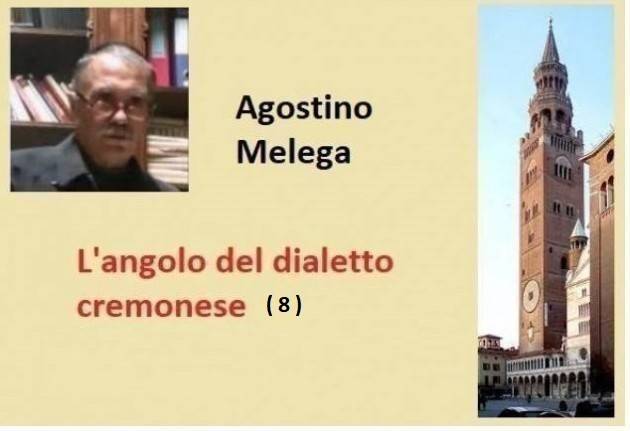ANGOLO DEL DIALETTO CREMONESE (8) | Agostino Melega
UNO SGUARDO SU GIAMPIETRO TENCA E GIGI MANFREDINI
LA RIEVOCAZIONE DI GIAMPIETRO TENCA
In occasione della rievocazione della data del 1° dicembre 1998, nell’ottavo anno dalla scomparsa di Luigi Lanzoni, il quotidiano “Cronaca” pubblicò il 29 novembre del 2006 un articolo scritto dal prof. Taglietti, il quale ricordava l’inaugurazione, nel vialetto degli Artisti nel Cimitero di Cremona, del busto in bronzo dedicato al poeta ad opera di Graziano Bertoldi, amico ed illustratore dei volumi del poeta stesso.
Ad accompagnare l’articolo rievocativo fu pubblicata la seguente poesia scritta in dialetto casalasco da parte di Giampietro Tenca (venuto meno il mese scorso), in omaggio ad “uno dei zàch più luminosi della ‘luminaria’ cremonese”.
L’Autore di Motta San Fermo, frazione di Casalmaggiore, fa parlare Lanzoni da lassù e lo invita a “scaldare” le ali e a tornare fra noi per un... giorno di ferie, sì per un permesso premio di vacanza da vivere ancora sulla Terra con gli amici di sempre.
AN ZÀCH
U vést dré de na stéla
an lümarëgn barblà...
La fiàma ‘d na candéla,
u ‘n zàch apèena impià?
Do lénti, dü barbìs
na vùs cm’an parlà bàs
cla giéva in cremunés:
“Sóm mé, sóm mé ragàs!
Si! Si! Mé che stu bén,
gh’è nìui ad puesìa
ànca al Padrón l’è bón
... ma al témp al pàsa mìa,
cóm j ùri sémpr’inguàli,
ad férii vrës an dé...”
Ma alùra, scàlda j àli
e vùla, vùla indré (2).
La stessa poesia ora la traduciamo nel vernacolo di Cremona.
EN ŠÀCH
Gh’ò vìst didrée a na stéla
en lüméen intacàa...
la fiàma de na candéela,
o ‘n šàch apèena ‘mpisàat?
Dò lèenti, dùu barbìis,
na vùus che pàarla sèensa sàm
che (la) dišìiva in cremunées:
“Sùunti mé, sùunti mé, regàs!
Sée, sée! Mé chì stòo bèen,
gh’è i nìigoi de puešia,
àan el Padròon ‘l è bòon...
ma el tèemp el pàsa màai,
cun le ùure sèemper precìiše,
vurarèsi en dé de féerie...”
Ma alùura scàalda j àale
e vùla, vùla indrée!
UN FIAMMIFERO. Ho visto dietro una stella/ un lumicino balbettare.../ la fiamma di una candela,/ o un fiammifero appena acceso?/ Due lenti, due baffi,/ una voce dal parlare basso/ che diceva in cremonese:/ “Sono io, sono io, ragazzi!/ Si! Si! Io qui sto bene,/ ci sono nuvole di poesia,/ anche il Padrone è buono/... ma il tempo non passa mai,/ con le ore sempre uguali,/ vorrei un giorno di ferie...”/ Ma allora scalda le ali/ e vola, vola indietro!
GIGI MANFREDINI, MAESTRO DEL DIALETTO CREMONESE
Mentre mi accingo a scrivere di Gianluigi Manfredini, ho la consapevolezza che lo spazio sarà tiranno, perché Gigi è stato un interprete del dialetto cremonese troppo grande per essere contenuto nello spazio che qui potrò dedicargli.
Nato a Cremona il 21 aprile 1935, in via Torriani, nella parrocchia di sant’Abbondio, Manfredini ha svolto la funzione di ‘maestro’ di nome e di fatto, coltivando nei confronti della lingua locale un amore, una passione, una competenza straordinari.
Gigi è stato ‘maestro’ non solo perché ha svolto per una vita la professione di insegnante elementare (dal 1955 al 1995), ma soprattutto per il modo ‘magistrale’ col quale ha preso per mano il dialetto, e lo ha accompagnato verso una costante crescita, tale da fare raggiungere all’idioma cremonese un livello artistico di eccezionale valenza. Non c’è ombra di dubbio che la sua cifra linguistica possa essere definita ‘illustre’.
Singolare e curiosa fu l’origine, la genesi del suo coinvolgimento emotivo con la lingua che in un primo tempo gli era stata negata. In famiglia, si doveva parlare infatti esclusivamente in italiano. Cosicché l’approccio vero col dialetto avvenne fuori di casa, in un ‘areale’ linguistico di campagna: ad Olmeneta, dove, da bambino, era sfollato in tempo di guerra.
Perché l’accesso, l’apertura, l’accoglienza al dialetto proprio lì, in campagna, e non in casa?
La spiegazione deriva dal semplice fatto che la mamma, per vivere, era stata costretta a diventare sarta (di valore!), dopo essere rimasta orfana del padre, caduto al fronte nel 1916, a 33 anni d’età. E l’accesso alla sartoria era quello prevalente da parte de le siöre, delle signore della città, e questo impediva a mamma e al piccolo Gigi, per una ragione di ‘pubbliche relazioni’, di azzardarsi a parlàa màal, ‘a parlar male’, ossia di parlare in vernacolo. Bisognava insomma parlàa de féen, ‘parlare di fino’.
Dopo la liberazione da questo tabù, nell’immersione nella rustica Olmeneta, dentro al pastone di un dialetto cremonese arcaico, incontaminato, chiuso ai vari ibridismi linguistici, protetto dall’isolamento culturale di quel borgo, uscirono poi, via via, le raffinatezze estetiche ed icastiche con le quali Gigi ha esaltato il parlare poetico attraverso l’uso dell’idioma popolare.
O meglio, egli, con quel dialetto, ha cantato in modo impareggiabile la variegata tematica degli affetti, la bellezza del nostro paesaggio, l’incanto del mutare delle stagioni; ed ha espresso, con un vernacolo reso tagliente, denunzie sul costume politico e sociale, senza dimenticare l’uso della lingua ‘grigiorossa’ in mirabili traduzioni d’autori antichi e moderni. Insomma, di fronte alle pagine di Gianluigi Manfredini, il lettore ha subito la consapevolezza di essere di fronte ad una stella di primaria grandezza.
Nei suoi scritti, infatti, si avverte - come scrive il critico Gian Luca Barbieri- una condizione letteraria scevra “dai fenomeni di osmosi lessicale con l’italiano che privano spesso il cremonese della sua vera anima”, così come si avvertono i segni di una levigatura di penna, di una ricerca di termini pregnanti carichi di senso, di lemmi resi brillanti dall’uso di un vocabolario infinito, ricco di gemme verbali, di limpide espressioni vernacolari, cariche di un’aura, di un conio, di un marchio unico, originale: ‘la cremonesità assoluta’.
Egli ha forgiato il proprio lessico poetico attraverso una sorta di distillato verbale in cui è avvenuta l’integrazione fra tutti gli aspetti tradizionali della poesia cremonese, all’interno di una visuale e di uno stile contemporanei. Di fatto, questa ricerca, tessuta in versi liberi o negli schemi metrici popolareschi e classici, è stata elevata sul piano indiscutibile dell’Arte e proiettata nella dimensione estetica del Bello, una categoria del pensiero e del sentire di cui abbiamo ed avremo sempre un estremo bisogno. Ed è qui che, il ‘cremonese’ di Manfredini, diventa una lingua universale.
Gigi Manfredini ha iniziato a comporre giovanissimo dal 1952, sul giornalino dell’Istituto magistrale, dove vennero pubblicate tre sue composizioni, apprezzate vivamente dal professor Mario Muner suo insegnante e noto critico letterario.
Nel voler riportare un esempio della sua arte, vi è solo l’imbarazzo della scelta.
Noi qui metteremo a fuoco la nostra attenzione sul nostro Autore nelle vesti del poeta e nelle vesti del traduttore di vari autori del passato, fra i quali il patavino Angelo Beolco detto il Ruzante. Di questo drammaturgo proporremo un brano attraverso le forme del vernacolo cremonese colto in tutta la sua squisita originalità da parte di uno straordinario traduttore, il Gigi Manfredini medesimo.
Ed allora iniziamo con la lettura della poesia La giòostra d’i cavài (La giostra dei cavalli), dai quali versi emergono la sensibilità e l’affetto d’un padre nell’osservare i due figlioletti divertiti sopra i cavalli di quella struttura ludica in movimento.
La giostra gira, o meglio la pìirla, accompagnata dal riverbero luminescente degli specchi e al suono dei campanelli, nel mentre tutti e due i bambini fanno cenno al papà con la manina, desiderosi di salire in groppa al cavallo bianco, quello più bello che galoppa in fiera. Ed il genitore esaudisce il desiderio dei due patanìin, ma l’emozione è così forte da far loro battere così forte el curešéen (il cuoricino) che, impauriti, si precipitano alla fine del primo giro ad abbracciare il papà coprendolo de bašéen, di bacini. E questi si avvede, sorpreso, di quel battito inatteso nel loro petto. Ed è nel contempo il preciso istante che il lettore si rende conto di essere di fronte ad un lontano ricordo del poeta. Molto tempo è passato dai giorni della giostra dei cavalli ed ora di fronte ai sunài, ai sonagli, per dire ai rumori e ai fatti della vita, il padre passa inevitabilmente in secondo piano com’è nel destino delle cose. E troppo presto, troppo in fretta, si avvicina tale incrocio della vita, dove i percorsi esistenziali si divaricano e i figli scelgono la loro strada in autonomia, mentre il padre li osserva a camminare verso il futuro.
LA GIÒOSTRA D’I CAVÀI
Gìira la giòostra
e sóta ‘l so téc,
in sìma a i cavài
i rìt i pütéi.
Pìirla la giòostra
e brìla i so spéc,
cun i campanéi.
“Àan mé sö ‘l cavàl
Biàanch che galòpa,
papà!”. M’ì fàt sègn
in dùu cu’l manìin.
In dùu, sö ‘l cavàl
biàanch che galòpa,
papà!”. M’i fàt sègn
in dùu cu’l manìin.
In dùu, sö ‘l cavàl
biàanch, sö la gròpa
lüstràada de lègn,
v’ò mìs, patanìin* *bambini ancora bisognosi d’attenzione
Ma dòpo ‘l prìm gìir,
j uciòon pràan cerìit,
a’l còl m’ì brasàat,
m’ì dàt di bašéen.
Finìit el prìm gìir,
ciucàa* pràan stremìit**, *a battere **spaventato
sö ‘l cóor, gh’ò scultàat
i vòost’ curešéen.
E féermete, tèemp,
adès che a i sunài
i me dùu pütéi
i me preferìs!
Tròp prèest vèen el tèemp,
pütéi, che i cavài
cu’ i so campanéi
gnàan pö ve stremìs (2).
LA GIOSTRA DEI CAVALLI. Gira la giostra/ e, sotto la sua tenda,/ sopra ai cavalli/ ridono i bambini.// Ruota la giostra/ e brillano i suoi specchi,/ e suonano i sonagli/ con i campanelli//. “Anch’io sul cavallo/ bianco che galoppa,/ papà!” Mi hanno fatto segno/ in due con la manina.// In due, sul cavallo/ bianco, sulla groppa/ luccicante di legno,/ vi ho messo, tesorucci miei.// Ma dopo il primo giro,/ gli occhioni molto spaventati,/ al collo mi avete abbracciato,/ mi avete dato dei bacini.// Finito il primo giro,/ a battere molto spaventato/ sul cuore ho ascoltato/ i vostri cuoricini.// E fermati, tempo,/ adesso che ai sonagli/ i miei due bambini/ mi preferiscono!// Troppo presto viene il tempo,/ bambini, che i cavalli/ con i loro campanelli/ nemmeno un po’ vi spaventano//. (Traduzione nostra)
GIGI MANFREDINI, TRADUTTORE ED UOMO DI TEATRO.
Ho accennato a Gigi Manfredini, traduttore in dialetto cremonese di opere in patavino di Angelo Beolco (1502-1542), in arte Ruzzante o Ruzante (da ruzzare= scherzare).
Manfredini, infatti, tradusse, di questo grande autore, La Moscheta, Bilora, La Fiorina, La Piovana, Il dialogo facetissimo, Il Reduce chiamato pure Parlamento de Ruzante che iera vegnù de campo, tutte opere portate in scena, a partire dall’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, dal Gruppo Studio di Teatro di Cremona.
Incancellabile nella mia memoria è il giorno della prima rappresentazione della Moscheta in dialetto cremonese, avvenuta a Cremona sabato 27 giugno 1970 presso il Chiostro di santa Chiara, in via Carnevali Piccio, per la regia di Walter Benzoni, con una interpretazione degli artisti coinvolti ed un allestimento scenografico da lasciarmi senza fiato.
Unitamente alla Moscheta del 1528, Manfredini tradusse due brevi dialoghi, il Reduce o Parlamento e Bilora, scritti da Angelo Beolco in lingua rustica tra il 1524 e il 1528, ritenuti la produzione più alta raggiunta dal drammaturgo padovano.
Gigi li riportò nelle forme suggestive di un dialetto cremonese autentico e ricercato, ed il G.S.T. li mise in scena, sempre per la regia di Walter Benzoni, presso il cortile di Santa Maria della Pietà, nel giugno del 1973.
Ne Il Parlamento de Ruzante che iera vegnu de campo, tradotto da Manfredini col titolo di Cantarumàan de Barbutòon vegnìit a cà de suldàt, recitavano lo stesso Walter Benzoni (Ruzante), Franco Loffi (Menato), Milena Fantini (Gnua), Franco Lotteri (Un bravo), con scene e costumi di Giorgio Gregori, luci di Roberto Lombardi, attrezzature di Franco Loffi e costumi di Lina Rossi.
Qui, il Ruzante, ossia Barbutòon, si presenta in scena come disertore fuggito dal campo non perché costretto dal nemico, ma perché vinto dalla paura, dal disgusto, dalla crudeltà, dall’inutilità e dalla stupidità della guerra e di chi l’ha voluta. Egli era partito illudendosi di arricchire con saccheggi e bottini, ed ora era ritornato stracciato, sfinito e ricoperto di pidocchi.
Sulla via di casa, incontra Menato, vale a dire Pipasèner, un contadino che ha abbandonato i campi per cercare un lavoro più redditizio, il quale racconta a Ruzante le proprie disavventure, nel mentre desidera rivedere al più presto la propria donna, la Gnùa, già moglie a propria volta del Ruzante stesso, rimasta fedele a questi solo prima che egli partisse per la guerra. Ma adesso la donna, stanca d’aspettare il ritorno del soldato, e stanca pure di Menato, convive con un vecchio facoltoso.
Ruzante ora però la rivuole, la pretende, disponibile a dimenticare le parentesi amorose e le fughe di comodo della donna. La pretende, ma il vecchio danaroso non gli restituisce la Gnùa ed il soldato tornato dalla guerra si vendica uccidendolo senza pietà.