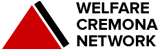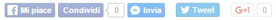L’ECO Il referendum per l’autonomia regionale: una partita (truccata) di scarabeo
Innanzitutto, per capire il senso dell’incipit, ricordiamo che cos’é. Si comincia distribuendo ad ogni giocatore otto lettere pescate a caso da un sacchetto. Bisogna fare il maggior numero di punti componendo su un tabellone parole che si incrociano con quelle degli avversari.
Senza saperlo, la politica gioca da tempo a scarabeo. Ma non nel rispetto delle regole del gioco e coll’intento di trovare parole di senso compiuto e di finalizzazione, agonistica ma condivisa, coi players. Nel guazzabuglio che è diventata, confusa e smarrita, priva di progetti ed incline alla rissosità, gioca un suo particolare scarabeo. Non incrociando, bensì rubando all’avversario, le parole. D’ordine! Ne esce inevitabilmente un tabellone in cui il prodotto “dialettico” è una babele incomprensibile, se non nella percezione dei picchi livorosi, e deviante.
Risultato certamente non edificante per una congiuntura, come l’attuale, in cui i profondi rivolgimenti planetari possono costituire per le basi fondanti del sistema liberaldemocratico una prova sostenibile.
L’espediente retorico, cui siamo ricorsi, calza, secondo chi scrive perfettamente, con la configurazione di uno degli snodi autunnali dell’agenda politica nazionale, che è la tornata referendaria del lombardo-veneto e, più in generale, con lo stato di impasse del sistema.
I cambi di passo nascono, secondo Galli della Loggia, da una molteplicità di cause quasi sempre inedite, all’apparenza slegate; ma che ad un tratto si sommano e si mettono in movimento, convergendo verso un improvviso, inatteso ma non imprevedibile risultato.
Di cui vanno stimati prodromi quelle atmosfere di declino, sfilacciamento, percepite ma neghittosamente trascurate, nelle analisi delle cause e della portata delle conseguenze. Una sorta di mescola composta da assenza di prospettive individuali e collettive, suscettibili, in congiunture ordinarie, di indirizzare la fuoruscita; dal rifiuto di vincoli e gravami non più accettati; dall’emergenza di ceti sociali privi di identità; dal venir meno, a causa di classi dirigenti manifestamente inadeguate, dell’autorevolezza dell’ufficio pubblico
Una versione apocalittica, questa, dello stimato cattedratico storico e politologo? Mah… Noi pensiamo di no.
Sistemi politico-istituzionali accreditati e consolidati (molto più del nostro) sono più o meno come noi nella palude. I parametri distintivi si intrecciano e si elidono. Reggono (con qualche affanno la Germania e con la baldanza di una scommessa la Francia) le realtà, in cui è rimasto un discreto tasso di appartenenza comunitaria, favorito inerzialmente da ordinamenti efficienti ed interdipendenti nei livelli di governo.
L’Italia? Messa decisamente male.
Un anno fa eravamo nel pieno della campagna per l’inconsiderato (da parte del suo dominus, Renzi) referendum di riforma costituzionale. Che avrebbe dovuto proiettare anche conseguenze sull’amministrazione periferica. Soccombette, non per una ponderata valutazione di merito, bensì perché dal punto di vista del rapporto con il riformismo l’Italia dimostra di essere un aggregato di NO-TAV su tutto. E’ passato quasi un anno et tamquam non esset. Dal punto di vista della consapevolezza di non restare fermi al palo del conservatorismo istituzionale, non si è progredito di un millimetro. Hanno vinto gli oppositori della riforma Renzi/Boschi. L’Italia ha dimostrato inequivocabilmente di non gradire le linee-guida del progetto di modernizzazione ed efficientamento della forma dello Stato. Per ragioni di etica politica i “vincitori” avrebbero dovuto farsi carico di attivare un progetto alternativo.
Neanche per sogno! Tutto come prima! In barba ad un sistema-paese che prima era ingessato e che ora è letteralmente imballato; fino a far temere, per la sua precarietà, qualche grippaggio in connessione con qualche non improbabile recrudescenza internazionale.
Se, come altri paesi occidentali, disponessimo di una classe dirigente “indipendente”, il sistema-paese potrebbe funzionerebbe in automatico, a dispetto di congiunture, comunque mai auspicabili, di imballo dei meccanismi democratici. Ma così non é. Il Paese è costantemente in affanno anche quando le criticità politico-istituzionali sono a bassa intensità.
La stessa riflessione, in merito a quella sorta di capacità compensativa, andrebbe applicata alla funzione suppletiva che l’ordinamento periferico ha esercitato, garantendo una certa normalità, anche in presenza di momenti di paralisi.
Ma mai come in passato siamo in presenza di una sommatoria e di una sovrapposizione di elementi di criticità e di smarrimento. Che, per il vero, non sono per l’Italia una rarità; ma che, in scenari prolungati e contraddistinti dalla soccombenza dell’idea dello Stato moderno allo strapotere del potere finanziario globalizzato, potrebbero mettere in gioco la sua tenuta. Lo sfilacciamento dello Stato, come una slavina, trascinerebbe con sé serie questioni di rappresentanza e la permanenza di tutte le forme di inclusione. di controllo democratico delle tensioni e delle contraddizioni sociali, nonché di aggregazione sociale nate con la democrazia.
Siamo costretti a farla breve e concludiamo su un punto: urgente arrestare lo sfilacciamento dello Stato, primo che non regga e cambi natura quel complesso di politiche pubbliche che favorirono ed accompagnarono lo sviluppo e settant’anni di vita democratica.
Abbiamo pensato che potesse venire in soccorso di questa consapevolezza di dover riformare per non perire l’unico organico progetto di efficientamento istituzionale che abbia traguardato l’iter legislativo. Siamo stati smentiti da un verdetto popolare, ispirato da bassi istinti e da totale assenza di condivisione civile.
Annotiamo amaramente che il conductor, cui avevamo affidato la speranza riformista, ha tolto dall’agenda della sua resurrezione la questione del rinnovamento dello Sato. Quasi non esistesse.
Esiste! Anzi, esiste in forma, aggravata perché una così pesante sconfessione non sarebbe mai a saldo zero. La crisi della vita politica ne è risultata acutizzata, in quanto all’impasse dei meccanismi istituzionali si è assommata la conseguenza di equilibri andati in frantumi.
Nel frattempo, siccome l’interdipendenza dei mercati e della politica è diventata ossessiva, se Parigi, Berlino, Vienna, Madrid hanno qualche linea di febbre, in Italia si intercettano tutte le tossine del creato. Rigetto dei flussi migratori, sovranismo, protezionismo, separatismo gettano, anche solo per l’effetto annuncio, le loro ombre anche su contesti nazionali alle prese con le medesime o con altre criticità.
Sia a causa dell’inveterata idiosincrasia a misurarsi con l’esigenza, suggerita dalle temperie mosse, di essere permeabile all’innovazione. Sia perché è inutilmente passato, un anno fa, l’ultimo treno della riforma della seconda parte della Costituzione. Che avrebbe, come abbiamo appena sottolineato, potuto dare efficienza e tempestività agli organi legislativi.
Tale efficienza non è mai entrata, specie negli ultimi trent’anni, nelle priorità del ceto politico-istituzionale; che ha casomai mostrato di sentirsi perfettamente a proprio agio con i ritmi della doppia lettura legislativa, con governi disarticolati dai sempre incerti equilibri e dal ruolo di un premier che è solo un primus inter pares, con una pletora di entità, funzionali non all’efficienza/tempestività dell’azione pubblica (pretesa, pena la soccombenza o la marginalizzazione nei contesti mondiali o d’area, dal trapasso dalla cultura ottocentesca alla mondializzazione) ma ai gesti ed ai ritmi, reclamati dal mantenimento della “partecipazione”. Una camicia di forza, con cui si vuole condizionare, fino all’annullamento, l’azione di chi è stato investito dal mandato democratico a governare e con cui si mantiene in capo alle minoranze, anche le più irrilevanti elettoralmente, una sorta di diritto di interdizione.
Che ha come risvolto, non dichiarato ma implicito nelle cose, l’assicurazione di partecipare all’infinito al patto consociativo che è stato e sarà alla base della dilapidazione delle risorse.
Ma andrebbe ricordato che la riforma Renzi-Boschi si faceva carico dell’esigenza di un’inversione che, in aggiunta ad un indirizzo di razionalizzazione, poneva la questione, da un lato, di sottrarre le decisioni strategiche alle miopie egoistiche dei territori e, dall’altro, di arrestare o almeno contenere gli sprechi, le disfunzioni e, diciamolo pure, le tendenze centralistiche dei governi regionali. Anche, ma l’avevamo forse presunto solo noi, nei confronti dei livelli amministrativi periferici.
Forse anche per questo fu impallinata dal combinato-disposto di tutti i contras, per principio e per convenienza. Ri-annotiamo, in proposito, un’amara ma veritiera constatazione del nostro parlamentare e settosegretario Luciano Pizzetti: “Qualunque cosa venga toccata in questo Paese, inevitabilmente contrasta con elementi consolidati. L e riforme non portano consensi, questo è ormai chiaro. Ma l’Italia ne ha un disperato bisogno”.
Un anno fa, di fronte all’inconsiderato proposito di sopprimere le Province, consideravamo che fosse decisamente preferibile, da un lato, confermare e riqualificare (magari revisionandone gli ambiti territoriali) questo irrinunciabile livello intermedio e, dall’altro, semmai ricondurre le Regioni Ordinarie al loro iniziale ruolo eminentemente legislativo e programmatorio. Nel contempo, riportando, gradualmente, quelle a statuto speciale ad una dimensione più conforme alla realtà.
E’ il caso, a questo punto, di porre sotto riflettore l’excursus regionale.
Previsto dalla Costituente, fu tenuto in naftalina, per calcoli certamente non nobili, non fecondi e non rispettosi degli interessi del Paese, per un quarto di secolo.
L’istituto regionale fu la grande operazione di decentramento istituzionale avviata nel 1970. con le prime elezioni regionali e i successivi trasferimenti di poteri. Diciamolo francamente, quella lungimirante intuizione, all’insegna dell’ampliamento delle autonomie territoriali come referenti della programmazione economica, è fallita.
Privata della linea-guida della partecipazione alla politica di piano, l’istituto si è trasformato in una sorta di repubblichina. Letteralmente degenerata per effetto della riforma del Titolo V che ne ha ampliato le funzioni e, soprattutto, rendendone alcune “concorrenti”, ha incardinato una filiera tossica di lunghi, interminabili negoziati tra governo e giunte. Con esiti esiziali per la tempestività degli interventi, soprattutto, nell’infrastrutturazione strategica e, come dimostra la vicenda trivelle, nell’intercettazione di opportunità di investimento di scala internazionale.
Come conseguenza, la burocrazia regionale ha immediatamente copia-incollato tutti i difetti della burocrazia centrale, costituendo in tal modo un freno nel rapporto cittadino/istituzioni.
Ma quel che più è grave, oltre al peso sulla finanza pubblica, determinato dalla sovrapposizione frequentemente indotta dal voto di scambio, la concorrenza delle funzioni in campi delicati ha finito per comportare una intollerabile rallentamento, quando non una completa frenata per le opere di natura strategica.
Ad aggravare la situazione ha indubbiamente concorso la circostanza dell’approdo nei ranghi di governo di culture non esattamente moderate e riformiste. Dell’apporto della sinistra post-comunista, miracolosamente entrata nella governativa stanza dei bottoni e probabilmente fagocitata dalla concorrenza di nuovi players della leva della seconda repubblica, abbiamo ripetutamente detto con riferimento alla sciagurata riforma Bassanini.
Sugli infecondi apporti della riforma del Titolo V ci sarebbe poco da aggiungere. Se non ulteriormente rimarcare che la riforma Renzi-Boschi si faceva carico dell’onere di un’inversione di tendenza. Che, in aggiunta ad un indirizzo di razionalizzazione, poneva la questione, da un lato, di sottrarre le decisioni strategiche alle miopie egoistiche dei territori e, dall’altro, di arrestare o almeno contenere gli sprechi, le disfunzioni e, diciamolo pure, le tendenze centralistiche dei governi regionali nel confronti dei territori provinciali (specie, di quelli periferici).
A sua volta, la Lega, planata sul sistema politico-istituzionale con sorprendenti consensi e con scoppiettanti velleità separatiste/indipendentiste, una volta assurta a ruoli di governo, avrebbe tradotto la mission indipendentista (più recentemente riconvertita in senso nazionalista) nei progetti di devolution e di federalismo fiscale (o differenziato). Tali indirizzi, privi di una apprezzabile incidenza strategica, avrebbero accentuato il già intollerabile marasma dell’ordinamento col solo risultato di appesantire la spesa corrente statale e di aggravare il debito pubblico.
Una propensione non-partisan, accettata, come si sa, dalla sinistra che vorrebbe che lo Stato spendesse sempre di più, mettendo a debito (da condividere coi partners europei) la maggiore spesa. E dalla destra che pure vorrebbe spendere di più, finanziando, però, il debito con la stampa di nuove lire.
Di passaggio annotiamo che la spesa regionale ha complessivamente valicato il limite dei 258 mld annui. Capitolo a parte costituisce la natura e la dimensione dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Speciale. Che ne assorbono una parte tanto cospicua quanto ingiustificata, quanto meno nella fondatezza delle motivazioni.
Né basta ad a convincerci del contrario l’ineffabile rassicurazione della Lilli (Gruber): “L’autonomia del mio amato Sudtirolo/Alto Adige ha le sue radici nella necessità di tutelare una minoranza etnico-linguistica. Ma è anche un esempio di come l’autogoverno può tradursi in buongoverno. Purtroppo non si può dire lo stesso per tutte le ragioni a statuto speciale”. La benevolenza della anchorwomen bolzanina omette che tale “buongoverno”, reso possibile dal traferimento da Roma di un cadeau pari a quasi 4 mld annui ed al 100% del gettito fiscali, integra lussi incongrui al buon senso ed alle fortune declinanti della spesa pubblica italiana. Ne enucleiamo alcuni: Qui tutto e' diviso tra le due province, e in modo strettamente proporzionale all'appartenenza ai vari gruppi linguistici. Il consiglio regionale, per esempio per due anni e mezzo si riunisce qui a Trento e per gli altri due anni e mezzo a Bolzano. La RAI regionale ha due sedi, una a Trento, l'altra a Bolzano, e il telegiornale ha una conduzione alternata, una da Trento l'altra da Bolzano. A Bolzano ci sono tre edizioni, una per ogni lingua.
Anche, dal punto di vista degli emolumenti all’establishment dell’autonomia, Trento e Bolzano non si fanno mancare niente: il governatore sud-tirolese incassa con 20.000 euro lordi mensili più dello stipendio di Trump.
Di sicuro, vedi nella realtà del Trentino/Alto Adige che il trasferimento statale viene speso bene in termini di servizi e di investimenti (ci mancherebbe!, anche se in Sicilia tale sensazione manca totalmente). Ma come giustificare, mentre a Trento si pensa di interrare il fascio ferroviario ed il tratto autostradale della A22 prospiciente il capoluogo, il fatto che intere province lombarde (come la nostra) sono letteralmente isolate dalla rovina dei viadotti e che l’intero manto stradale ha da tempo superato il livello del decoro e della sicurezza?
L’endorsement/certificazione della Gruber, ci puoi giurare, ricorre, erga omnes e come comunicazione comparativa, nei convincimenti di ognuno dei cinque partners del privilegiato club dei portatori di autonomia.
Tale aspetto diviene ancor più manifesto, se si pone attenzione, oltre che all’ammontare complessivo, al valore pro-capite del trasferimento; compreso in un range che va da tre/quattro per le Regioni a Statuto Speciale a uno/due per quelle ordinarie (in cui sono comprese quelle a maggior gettito).
A beneficio della memoria ricordiamo a noi stessi e ai lettori che le Regioni a statuto speciale sono cinque: – Sicilia, prima a nascere con legge costituzionale n.2 del 1948; Sardegna,mediante legge costituzionale n.3 del 1948; Valle d’Aosta, mediante legge costituzionale n. 4 del 1948; Trentino Alto Adige, legge costituzionale n.5 del 1948; Friuli-Venezia Giulia, legge cost. n.1 del 1963. Come si ricorderà la Regione Autonoma Trentino Alto Adige è un involucro fittizio che comprende due Province che di fatto esercitano il ruolo legislativo delle Regioni.
Nel momento in cui prende slancio l’azzardo di Lombardia e Veneto di voler fare come le cinque realtà privilegiate da circostanze storiche eccezionali ed irripetibili (anche se qualche saccente si è avventurato nel consiglio rivolto a Spagna e a Catalogna di fare come fecero Degasperi e Gruber). Basterebbe perdere due guerre consecutive; passare attraverso “l’opzione”; esercitarsi con un po’ di tritolo sui tralicci e usare la destrezza degasperiana del band-wagoning.
E’ vero che le altre quattro “autonomie” presentano minori credenziali dal punto di vista della certificazioni della straordinarietà. Ma, vivaiddio, nell’ordine si sono verificati questi eventi in 70 anni: tutti i paesi confinanti con l’Italia sono entrati nell’U.E. e nell’area di Schengen e nel Trattato di Maastricht; é caduta la “cortina di ferro”; Tito è stamorto; nessun savoiardo sognerebbe di inglobare la Vallée come nessun tirolese del Nord di prendersi la gatta di quello del Sud; USA ed Inghilterra sono alle prese con altri problemi e non con l’ansia di fare della Sicilia una base separata del basso Mediterraneo.
Non esistono più alibi! Sicuramente permane un’opportunità di tutela delle minoranze poste ai confini nord-orientali. Ma non con i lussi che, al confronto del resto del Paese, insultano l’etica, la decenza e, soprattutto, la sostenibilità.
Già, perché se il profilo referendario lombardo-veneto non si è rivelato, come avrebbe potuto temersi, troppo mal mostoso, ha contribuito a pescare nel profondo e sedimentato torbido di questioni mai acclarate, mai regolate, ma definite.
Anche noi non amiamo il torbido, men che meno l’accarezzamento dei non detti, degli ammiccamenti, degli abbozzi. Specialmente su materie su cui sta o dovrebbe essere scritto “handle with care”.
I governatori Maroni e Zaia, se non altro per il loro ruolo istituzionale che escluderebbe quo ante la candidatura di portatori di profili lombrosiani, non indossano elmi cornuti, non agitano scudi patacca. Sono rassicuranti come consiglia la divisione dei compiti con il capo della Lega, che, invece, deve alzare il tono della difformità per catalizzare militanza e consensi border line.
Se si nota di tale distribuzione dei profili e dei ruoli si avvalgono tutti i nuovi movimenti interpreti della discontinuità rispetto alla tradizione.
E’ così in Italia, come nel resto del martoriato vecchio Continente, che per un’intera (nostra) vita abbiamo ritenuto, almeno idealmente, sterilizzato dalle lezioni della storia.
Il Corriere della Sera ha, alcuni giorni fa, pubblicato una mappa continentale in cui risultavano evidenti le criticità indipendentistiche. Da non credere: si salvano la S.C.V. (Sì, la sedicente Santa Citta del Vaticano) e la Repubblica di San Marino.
Tira un brutto vento se, almeno per quanto riguarda la Penisola, un giornalista bravo ed equilibrato (tranne quando si impiccia con inconsiderati endorsements elettorali) Beppe Severgnini, in un contesto in cui i peggior istinti sembrano aggregarsi e cavalcare tutti insieme l’onda sfascista, si chiede, con l’occhio rivolto alle faccende domestiche, “Perché un lombardo o un veneto non dovrebbero sentirsi italiani?”.
Già perché? Se Silvius Magnago, storico presidente dell’Autonomia sud-tirolese, fu molto accreditato con la sua uscita (la mia patria è il Tirolo, ma sono cittadino della Repubblica Italiana); perché altrettanto non potrebbero affermare (come in realtà affermano e soprattutto sono convinti di pensare) gli appartenenti a quello stranissimo patchwork che è l’Italia.
Non siamo in presenza di alcuna deriva catalana. Che, pur avendo ascendenze ben più marcate delle nostrane caratterizzazioni localistiche, è diventata tale per conseguenza della bilaterale trascuratezza dei segnali e della sottovalutazione dell’imbarbarimento della politica.
Ma, per quanto indotti a considerare il referendum lombardo-veneto una genialata che neanche la DC avrebbe potuto escogitare e, quindi, a derubricarlo dai bollini rossi, non saremmo portati a fare spallucce. Specie nella percezione di quel senso di disappartenenza (e non solo nel senso autonomistico) che il dibattito referendario ha confermato, più che percepito.
La Regione Puglia, egemonizzata dal governatore-competitor Emiliano della leadership renziana, sta istituendo la giornata della memoria sudista (13 febbraio, giorno della caduta della fortezza di Gaeta). Non certamente allo scopo di ridurre le distanze geo-culturali di un Paese dal basso tasso con divisivo ed identificativo nella comunità nazionale. Oltre ad accarezzare le corde del populismo territoriale con evidenti mire elettorali, l’iniziativa produrrà senza ombra di dubbio il risultato di incrementare il bagaglio recriminatorio del Sud, certo che la decadenza sia conseguenza della sottomissione al Nord.
Queste pulsioni sarebbero degne di ispirare la sceneggiatura operettistica se non si assommassero al profondo e consolidato sub-strato di un più vasto senso di disappartenenza civile. Ben più grave delle ampolle della sorgente del Po e delle nostalgie degli illuminati reami borbonici.
Il referendum consultivo, poco più, dal punto di vista delle conseguenze pratiche, di un sondaggio d’opinione, potenzialmente, ove si limitasse alla sbrigativa postulazione di un’omologazione di Lombardia e Veneto al novero delle autonomie (regionali e provinciali) di rango speciale, riproietterebbe le ombre e le contraddizioni di una mai definita e, soprattutto, chiara ripartizione delle competenze tra Stato e livelli legislativi ed amministrativi inferiori.
Ma anche in una lettura di rango inferiore limitata ad un riequilibrio dei trasferimenti, non v’è chi non veda l’automatismo tra le conseguenze finanziarie: maggiori fondi al Nord, minori al Sud (che da sempre, in barba alle finezze ideologiche, è stato abituato a vivere alle spalle).
Sia come sia, quel che è certo è che, con o senza referendum più o meno farlocchi, difficilmente gli scenari lunedì saranno tel quel quelli antecedenti.
Anche se non riusciamo ad intravedere le forze deputate all’impresa, la questione di un cambio dei registri nella destinazione delle risorse ai territori in un senso di maggior equità ma anche di finalizzazione all’impiego per ulteriore crescita (dei territori e dell’intero Paese) si porrà. Con un’intensità rapportata alla preveggenza della politica.
Se si opererà virtuosamente e d’anticipo (per quanto siamo in ritardo di oltre mezzo secolo) si pareranno pericolose derive e si porranno le premesse per modernizzare l’ordinamento amministrativo progettando nuovi sistemi istituzionali e di pianificazione di area vasta, in grado di riequilibrare la destinazione delle risorse e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Che per le aree emarginate significa anche interrompere il fenomeno dello spopolamento.
Certo che il referendum di domenica prossima serve a preparare le elezioni generali, realizzando una mobilitazione del popolo leghista e una sensazione di consenso popolare che altro consenso popolare dovrebbe portare alle politiche.
Ma se si è pirla come la sinistra, cui apparteniamo, deve anche stabilire che la recriminazione polemica non è né una giustificazione né un’esimente.
Il quesito che la sinistra riformista ed il campo moderato nel suo insieme devono porsi è se l’attuale ordinamento istituzionale italiano sia confacente ad una realtà caratterizzata da una così accentuata diversità storica, economica e culturale e se il discendente impianto dell’impiego delle risorse sia sostenibile.
Una risposta è stata data il 4 dicembre di un anno fa. Ma non implica che, se il fronte riformista è risultato soccombente nel primo game, il tema, che permane identitario nel bagaglio teorico-pratico, non debba continuare ad essere prioritario nei progetti del centro-sinistra.
Diciamolo con franchezza: questa sinistra nel suo complesso è evanescente. Il leader dem ne ha parlato ma con aristocratico distacco.
La sinistra sempre divisa si è, come il solito, Infilata in labirinti intellettualistici.
Vado? Non ci vado? O se vado, mi tengo in disparte? Come avrebbe detto Moretti!
La cifra più elevata di surrealismo è stata presentata dal Sindaco di Cremona (persona umanamente stimabilissima) con quella sua dichiarazione tranchante: “Referendum inutile, ma c’è. Il mio sì per l’autonomia, quella vera!”.
Mah… Con tutto il rispetto, ci sembra un avviso dettato da poco costrutto. Che non sia un inconsiderato automatismo di adesione alla testimonianza del circolo degli “utili idioti” di leniniana memoria, come sono stati definiti i sindaci del Pd esposti per il SI’.
Ci dovranno dire qualche cosa di più, a partire da lunedì.
Parafrasando il celebre ed apprezzato scrittore russo, scusate se sono stato troppo lungo. Diversamente da lui, non perché ho avuto il tempo per essere più breve. Ma perché l’argomento, per essere affrontato adeguatamente e soprattutto lontano dagli stereotipi politici dei tempi attuali, non poteva non avvalersi di alcuni approfondimenti.
Si dice che se il referendum fallisse dal punto di vista della partecipazione la strategia autonomistica lo trasformerebbe in un boomerang.
Chi vivrà vedrà come diceva la mia nonna! Indubitabilmente sarebbe un boomerang, in termini di autorevolezza, un test, per quanto ab origine dagli scarsi accreditamenti di legittimità, che facesse cilecca col livello di partecipazione.
A prescindere dal rating istituzionale, un risultato numericamente significativo non solo gonfierebbe le vele delle furbate elettoralistiche dei promotori, ma inficerebbe il prosieguo di un confronto virtuoso.
Per queste ragioni non andremo a votare. Per intima convinzione e perché apprezziamo, sul punto, le conclusioni del recente convegno dei Regionali PSI di Lombardia e Veneto e l’indirizzo del segretario Provinciale Carletti e del Coordinatore della Comunità Socialista, Virginio Venturelli.
Ma, dato che ci siamo, anticipiamo anche una riflessione di merito, che svilupperemo nel confronto post-referendario e che già oggi ci induce a non votare.
Si è qui parlato di una regione urbanizzata e sviluppata in un continuum territoriale. In realtà, se si vuole restare aderenti ad un’analisi veritiera, la struttura degli insediamenti produttivi e sociali è fortemente imperniata nell’area metropolitana e nella fascia pedemontana. Il resto del territorio è contraddistinto da una condizione di marginalità e di funzionalità complementare.
Quando non di neanche mascherata marginalizzazione, come nel caso della fascia sud-orientale.
L’establishment politico lombardo, che postula maggiori competenze e maggiori risorse in funzione di un riequilibrio della destinazione e di una gestione pubblica più efficiente e vicina ai cittadini, si è mostrato pervicacemente ancorato ad un centralismo non molto dissimile da quello statale.
Roma “ladrona” privilegia le Regioni del Sud a danno della “locomotiva”? Che si può dire del Pirellone nel rapporto coi territori periferici? Destinazione squilibrata di risorse, marginalizzazione nei progetti strategici, spoliazione dei presidi gestionali giustificata dall’ottimizzazione della spesa.
Soprattutto, mai un progetto che fosse indirizzato ad un riequilibrio territoriale.
Del tutto espunti i pochi progetti di valorizzazione delle peculiarità dell’asta del grande fiume. Anzi, si dovrebbe dire, del tutto asfaltati (nel senso della totale avocazione quando non soppressione) degli strumenti finalizzati al trasporto fluviale, alla portualità interna, allo sviluppo dell’intermodalità.
Dal punto di vista dell’infrastrutturazione, Cremona (e, volendo, anche Mantova) negli ultimi trent’anni sono vistosamente regredite: nessun nuovo serio proposito di riequilibrio derivante da nuovi collegamenti viabilistici e dal potenziamento degli esistenti.
La mobilità ferroviaria è risultata ancor più periferizzata dalla strategia dell’alta velocità, che ha cannibalizzato letteralmente la rete regionale e locale, sui cui binari si sa più o meno quando e se si parte, ma non se e quando si arriva. Più che un handicap una sentenza capitale per territori in cui il lavoro pendolare costituisce una componente determinante per l’arresto della tendenza allo spopolamento. L’isolamento è accentuato dalla circostanza rappresentata dall’obsolescenza fisica dell’infrastrutturazione viaria restata sempre la stessa da mezzo secolo e mai modernizzata o semplicemente mantenuta, come dimostra l’impraticabilità dei ponti, che, per un territorio significativamente interessato dalla presenza di corsi d’acqua, sono condizione essenziale di collegamento per le persone e le merci.
Ci sarebbe, poi, una questione su cui una Regione, che volesse ben amministrare anche essere percepita come paradigma del focus che ispira senso di appartenenza, dovrebbe non tacere. Si tratta della testimonianza di una nuova cultura dello sviluppo economico e del lavoro.
Di una riqualificazione etica e culturale delle categorie del lavoro. Che tenga conto del fatto che campare di assistenzialismo per fasce crescenti di popolazione, escluse dal mercato del lavoro sempre più fagocitato dagli automatismi e dalla robotica, sarà impossibile oltre che insostenibile. Occorrerà “reinventare”ambiti occupazionali dismessi dalla seconda e dalla terza rivoluzione mondiale. Ci riferiamo al ritorno alla produzione agroalimentare di ultima generazione, implementata dalla ricerca, e allo sbocco rappresentato dalle attività sinergiche tra questa e tutela ambientale e paesaggistica e valorizzazione turistica. A meno che non si vogliano far campare milioni di italiani e, nel nostro caso, di lombardi, veneti ed emiliani di reddito di cittadinanza. La ricerca ed il perseguimento di sbocchi lavorativi non risponde solo ad una generica necessità di tipo sociale. Invertire il senso di dignità civile e sociale che aveva indirizzato l’inurbamento industriale e terziario e del boom e della terza rivoluzione industriale risponde, infatti, ad una delle domande che il cambio di passo dalla economia finanziarizzata e globalizzata al futuro porrà in termini sempre più stringenti. Vuole la nostra Lombardia appropriarsi di nuove e più ampie materie per attrezzare meglio la “locomotiva” che ha trainato il convoglio del boom d e dello sviluppo durato oltre mezzo secolo, nell’interesse dei suoi residenti e di tutti i cittadini della Repubblica? Sì? Allora si sforzi di uscire dagli stereotipi che hanno sin qui guidato il suo modello, vincente ma non equo per tutte le fasce sociali e territoriali, e cominci ad immaginare cambi di passo in senso innovativo. In direzione di un modello di sviluppo, in chiave espansiva, in quanto finalizzata alla metabolizzazione delle conseguenze dei cambiamenti in corso che riverberano il tendenziale esubero occupazionale, ma anche in chiave di riqualificazione della capacità inclusiva della Lombardia. Fin qui “il Pirellone” ha fatto poco o nulla, in quanto si è limitato, nonostante abbia acquisito rispetto al resto del Paese performances significative, a replicare le linee-guida di un sistema ispirato da un senso di neutralità rispetto al darwinismo sociale e territoriale.
Si è qui parlato di una regione urbanizzata e sviluppata in un continuum territoriale. In realtà, se si vuole restare aderenti ad un’analisi veritiera, la struttura degli insediamenti produttivi e sociali è fortemente imperniata nell’area metropolitana e nella fascia pedemontana. Il resto del territorio è contraddistinto da una condizione di marginalità e di funzionalità complementare.
Quando non di neanche mascherata marginalizzazione, come nel caso della fascia sud-orientale.
Siamo convinti che un principio giusto (quello della riparametrazione dei trasferimenti e delle funzioni) non diventa sbagliato in base alle contingenze ed ai tentativi di strumentalizzazioni. Non abboccheremo all’amo di Maroni. Ma accettiamo la sfida del confronto. A partire da una domanda: il governo regionale lombardo (a partire dai vent’anni di Formigoni in poi) ha le carte in regola per colpevolizzare il centralismo?
_________________________________
Comunicato della Comunità Socialista
Premesso che:
il prossimo 22 ottobre si terranno due referendum identici in Lombardia e Veneto,
entrambi le iniziative hanno degli obiettivi meramente politici, funzionali elettoralmente ai Governatori in carica, ma del tutto inadeguati, all’ottenimento di una maggiore autonomia regionale.
l’articolo 116 della Costituzione, vigente dopo la riforma del 2001, a cui i promotori fanno riferimento, non prevede infatti, alcun referendum locale, anzi sottolinea espressamente che eventuali nuove attribuzioni alle Regioni possono essere affidate solo previa decisione favorevole da parte Parlamento nazionale.
il quesito della consultazione, non specifica né le forme né le condizioni particolari dell’autonomia richiesta; in sostanza ai cittadini viene sollecitato di sostenere l’incremento della gestione regionale delle attività, senza chiarire quali dovrebbero essere,
diversi sindaci PD della Lombardia hanno già annunciato che voteranno compattamente “si” al referendum, proprio come gli amministratori della Lega, delle forze del centro destra e del Movimento 5 stelle,
Tutto ciò premesso, la Comunità Socialista cremasco – cremonese,
interviene per esprime le proprie perplessità sulla operazione in corso, fortemente strumentalizzata e povera di contenuti,
ritiene profondamente sbagliato accentuare un neocentralismo statale progressivamente volto a trasformare le Regioni da organi di legislazione, programmazione e indirizzo, come originariamente pensati, ad Enti sempre piu’ gestori dei servizi territoriali,
segnala, con disappunto, nella proposta referendaria, la mancanza di ogni razionale e generale idea di federalismo, per anni motivo di tante ed articolate discussioni,
sostiene la necessità di rimettere al centro degli assetti locali locali, l’Ente Provincia, ovvero nuove aree vaste, aggregazione di Comuni, certamente più rispondenti e vicine ai bisogni dei cittadini,
considera urgente una vera e propria inversione di rotta, che prioritariamente riduca il numero ed il ruolo delle Regioni, anziché quello delle comunità locali,
invita i cittadini a manifestare un motivato e marcato distacco dalle posizioni assunte dai Partiti promotori e aderenti ad una iniziativa, smaccatamente propagandistica e di palese tatticismo perché tutti possano dichiararsi dei vincitori,
sceglie, per le considerazioni sopra esposte, di non partecipare alla votazione referendaria, peraltro assai dispendiosa e solamente di valore consultivo, in quanto del tutto inappropriata a produrre dei risultati efficaci nello scardinato assetto delle Autonomie Locali, conseguente alla situazione comatosa in chi si trovano oggi le Province.
stigmatizza l’abuso dello strumento referendario su questioni del tutto ordinarie per non svilirne la sua validità e importanza istituzionale.
____________________________________
Referendum, il Partito socialista è per l’astensione
Avanti! 16-10-2017

Si è svolta a Peschiera del Garda, presente l’on. Pastorelli, l’assemblea congiunta dei dirigenti PSI del Veneto e della Lombardia e dei comitati socialisti per l’astensione.
Nell’incontro si è fatto il punto della situazione sulle iniziative di promozione dell’astensione al referendum leghista di ottobre, sulle iniziative da portare avanti nell’ultima settimana di campagna referendaria e su cosa fare il giorno successivo al referendum.
I socialisti hanno convenuto sull’opportunità della scelta astensionista. Una scelta coraggiosa poiché destinata a scontrarsi contro la potente campagna referendaria scatenata dalla Lega (fatta in parte con i soldi dei cittadini del Veneto), una scelta difficile ma intellettualmente onesta e non piegata dalla codardia di chi ha preferito “mettersi nella scia” del malcontento sobillato dalle forze del centrodestra.
I socialisti promossero e sostennero la creazione delle Regioni. Regioni che avrebbero dovuto essere strumento di coordinamento delle autonomie locali e non, come purtroppo è accaduto, Enti accentratori di potere a danno degli Enti Locali. Non è un caso che il referendum lanciato dalla Lega ignori gli Enti Locali.
In Parlamento il PSI sta portando avanti una politica di revisione delle autonomie speciali ed è pronto a sostenere le richieste di maggior autonomia che provenissero dalle altre Regioni secondo percorsi costituzionalmente previsti.
Richieste di maggior autonomia che la Lega a parole ha sempre fatto ma che poi, come nel caso del referendum di ottobre, si rivelano per ciò che realmente sono: slogan elettorali!
A Peschiera del Garda invece i socialisti hanno deciso di agire e dal giorno successivo al referendum, in tutti i Consigli comunali di Veneto e Lombardia in cui il PSI è presente, porteranno delle delibere da far votare e da inviare alle Regioni affinchè avviino realmente il processo costituzionale in grado di consentire ai cittadini delle due regioni di amministrare in maniera più efficace le risorse prodotte dai propri territori.