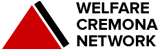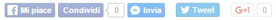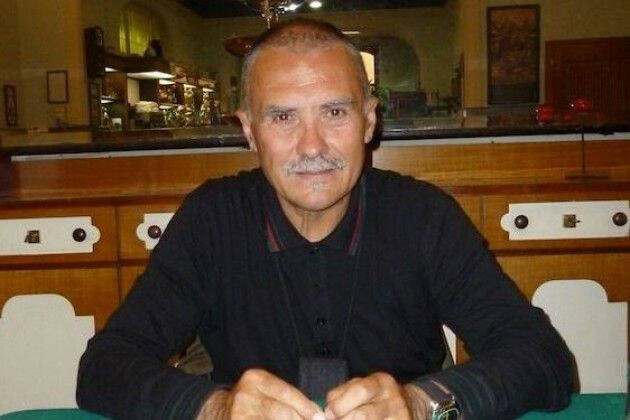MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA (CASCINA DEL CAMBONINO VECCHIO) CREMONA - 5 APRILE 1922 - ORE 17.00 “EL FUGÒON DE LA VÉCIA”
Durante i giorni della Merla, per anni, insieme ad un bel gruppo di amiche ed amici, ci si trovava a casa di Luciano Dacquati, alla cascina Boccansolo, nei pressi di Bosco ex Parmigiano, e lì si intonavano i canti della tradizione, nel mentre veniva acceso il falò della Vecchia, riproponendo così tutti insieme un millenario rituale.
Fra i canterini era sempre presente la poetessa Franca Piazzi Zellioli ,che ha ricordato quei bei momenti di allegria attraverso due composizioni, la prima dal titolo “Falò de Genàar” e la seconda “Se brüüša la Vécia”. Vediamo allora la prima.
FALÒ DE GENÀAR
Éeeh... Vvvùm!
Cùma ‘n bìs che, spaurìs,
el se inturciùla a i bròch
sèch e pelàat de na piàanta,
el fóoch
‘l intòorcia i masóoi
de’l falò
e dèent in de l’èera
‘l è töt en lüšùur!...
S’ciòpule e stéle
le se mes’cia in de ‘l céel
frèt e pulìit de genàar
intàant che le fiàme
le se svàalsa, le bàla,
le càanta le véce cansòon
de la mèerla:
antìighe paròole
per en ciòp de amìich.
Dèent a’l fugòon
Se ghe sbàt dulùur... paüüre...
delüšiòon... cativéeria...
Là in àalt, la Vécia,
infilsàada in sö ‘l bròch püsèe drìt,
la bambàna,
bulseghèent la s’ciupéga,
e la brüüša!!!
- Brüüša o bröta veciàsa!
Brüüša o bröta pajàsa!
E dèent in de ‘l fóoch
pòorta cun té
le ròbe bröte
de töti i nos’ dé!
Brüüša!
Brüüša!!
Brüüša!!!
Àan el vèent
el se mes’cia udulèent
a le lìingue de fóoch
che piàan piàan le se sbàsa,
le se scüürta,
le móor...
Adès, intùurnu a ‘l brašèer
J óc i se incàanta;
a ‘l calùur se slóonga le màan...
Pàarla nisöön.
Se pèert ne la nòt mìia penséer.
- Saràal püsèe bèl el dumàan?
O saràal cùma jéer?
Ed ora leggiamo la seconda:
SE BRÜÜŠA LA VÉCIA
Àla là, la Vécia de pésa, infilsàada
sö ‘l bròch püsèe vàalt de’l falò!
La vàardi: la pàar rasegnàada
a ‘l so mìšer destéen!
Pàar che la dìga:
“Vegnìi gèent! Vegnìi chì vešéen!
Catèe sö töt el bröt
de’l móont de incóo
e fèene el masóol!
Cun mé ‘l purtaròo a perdìise
cu’l fóoch vešéen a le stéle,
cumpagnàat da chéle paròole
che sèenti ògni àn,
cun ‘l udùur de’l ‘brülé’
in de’l frèt de genàar!
Intùurno a ‘l falò che ‘l fà ciàara la nòt,
inturciàade in tabàr e sialpòon,
se svàalsa le vùus che càanta
le véce cansòon de la Mèerla, nasìide...
chisà da quàant tèemp!?... e perchè?
De sücüür per ciamàa la bùna ventüüra,
perchè la vìta la siès méen düüra...
Àanca mé, cùma sèen’, gh’ò sbatìit,
en pòo de scundiòon,
el me bruchelìin dèent’ a’l fugòon,
‘dùa la Vécia s’ciupeghèent la brüšàava!
“... che siès bùna töta l’anàada!”
Adès,
de töt el gràn fóoch, nùma le bràaše
in de’l càamp gh’è restàat:
ma cun na nóoa speràansa in de ‘l cóor
òm, dóne e regàs a cà j è turnàat!
Da parte sua, lo stesso Luciano Dacquati ha scritto, in “Ròbe de na vòolta”, che tanti anni fa la gente cantava e ballava attorno al falò della Vecchia, facendo il girotondo.
A Torre Picenardi invece, come un giorno mi raccontò il professor Renzo Bodana, i ragazzi vociavano:
El fìila el füüs
El stùpa el büüs
el fìila la làsa
el pòorta in piàsa
el và el falòch
Fila il fuso/ chiude il buco/ fila la cordicella/ porta in piazza/ va il falò.
A Cremona invece, negli anni Venti del secolo scorso, presso il rione popolare di Porta Mosa, la gente portava il fantoccio della Vecchia in corteo, prima di metterlo al rogo. In quell’occasione, testimoniata fino al 1925, veniva cantato questo ritornello:
Gh’éera na vécia incréespa
la gh’ìiva utàanta àn,
la gh’ìiva i prìm afàn
e i šgrišulìin d’amóor.
E se la càanta tìpete tùpete,
e se la pìirla tìpete tàpete,
e se la Vécia la vóol balàa,
tìpete, tùpete, tìpete tà.
C’era una vecchia rugosa/ aveva ottant’ anni, / aveva i primi affanni / e frigoline d’amore. / E se canta tìpete tùpete,/ e se si gira tìpete tàpete, / e se la vecchia suol ballare, / tìpete tùpete tìpete tà.//
Partendo da questa breve introduzione, andrò a stilare un racconto che riguarderà nello specifico la dimensione folklorica del falò della Vecchia, portandomi a scandagliare nel passato anche remoto della storia d’Italia, ponendo così al centro dell’attenzione un rituale popolare nato con tutta probabilità nella notte dei tempi.
Tale rituale è ad ogni buon conto comune alle genti di tutta Europa. Infatti, come scrive il grande folklorista Vladimir Propp: “Ci sono forme nazionali: tedesche, inglesi, francesi, italiane, romene, ceche, ucraine, bielorusse ecc. Queste differenze si spiegano con la storia dei popoli, con le condizioni di vita quotidiana, con il tipo di vita, con il clima, con il carattere nazionale”.
Di fatto, la terra cremonese rinnova ancor oggi, con l’accensione di fuochi rituali, una tradizione antica, straordinariamente vecchia quanto la nostra pianura, quanto i nostri campi conquistati alla palude e al groviglio della boscaglia.
Nel corso dei millenni, sul confine fra il campo coltivato ed il buio della macchia forestale, si è andato a sovrapporre l’incerto ed ambiguo limine fra un qui, organico alla civiltà e alla cultura, ed un altrove, disegnato dal fascino del mito e dell’immaginario.
Su quel limine, su quel confine, si è pure andato a porre l’ambivalente segno del fuoco; un segno concepito nello stesso tempo sia come forza benefica e sia come forza pericolosa e negativa, interpretato come un tratto luminescente intermedio fra il qui e l’al di là, e soprattutto concepito, sin dall’inizio del cammino dell’umanità, come un ‘essere vivente’.
Questa concezione ci viene argomentata con dovizie di riferimenti da Giacomo Devoto, nel suo Origini Indeuropee. Studi e materiali, a cura dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze.
Il grande glottologo e linguista italiano, parlandoci del fuoco, e del culto pirico praticato fra gli Indoeuropei, scrive: “Esso è il simbolo dell’istantaneità come dell’eternità, è un fattore di unione fra il cielo e la terra”. Ed è proprio in tale funzione di ‘porta d’ingresso’ fra il mondo dei vivi e il mondo ‘altro’, fra contemporanei ed antenati, che il fuoco diventa pure strumento di comunicazione fra la realtà materiale e quella spirituale, e mezzo di difesa apotropaica, ossia strumento di allontanamento delle negatività, oltre che di propiziazione, di vaticinio, svolgendo pure una funzione di sostegno magico nei confronti della forza dell’astro solare.
Il governo umano del fuoco, la sua padronanza, sono avvenuti gradualmente, una volta superati il terrore immane provocato dalla caduta dei fulmini e l’eco terrificante prodotto dalle stesse scariche uraniche. Ancora in epoca storica, il fuoco e il fulmine erano personificati da terribili divinità: l’indo Agni, il nordico Thor, il celtico Taranis, i greci Giove ed Efesto, il latino Vulcano.
Dall’alba arcaica della capacità umana di governare il fuoco fino ai nostri giorni, si sono sovrapposte credenze e visioni del mondo diverse e contrastanti, i cui strascichi si sono depositati nelle credenze e nei valori che la tradizione popolare ancor oggi gli assegna. Valori sui quali primeggia il ‘significato di purificazione e di energia vitale’, come ha scritto Paolo Toschi su Il Folklore, tradizioni, vita e arti popolari.
Dalla storia ancestrale accennata, dall’alba lontana della civiltà, è pervenuto ed è presente anche in terra cremonese un residuo, una reliquia degli arcaici rapporti fra l’uomo e il fuoco, nella sua dimensione rituale pubblica. Ed è un fenomeno folklorico che si va a perpetuare ogni anno, attraverso l’accensione di falò interpretati come appuntamenti ineludibili, riattualizzati nel desiderio di rinsaldare la precarietà dei legami con le proprie radici, e per tentare di far riaffiorare il rigo emotivo del ricordo di un’anima contadina e popolare che si è persa, frantumata e dissolta nei salti generazionali, sociali ed economici successivi.
Quest’anima ha vissuto, nei secoli passati, accanto al ciclo agrario della terra coltivata; un ciclo finalizzato al parto dei prodotti custoditi dalla placenta della terra, in un tratto di tempo che dalla semina al raccolto è stato come illuminato e favorito dalla veglia dei fuochi protettori, posti sulla dorsale dell’anno contadino.
Chi ha avuto modo di osservare i falò dispersi per la campagna in determinati giorni dell’anno, o meglio durante certe veglie dell’anno, avrà visto come i fuochi prendano le sembianze mimetiche di tanti piccoli soli notturni. E come la terra, artificialmente riscaldata dai fuochi rituali anziché dal sole, emani un misterioso richiamo. Da essa esce come una voce suasiva atta a richiamare la gente a stare sveglia, a presenziare al rito di sempre, a perdere la propria corporeità per trasformare le sembianze umane in ombra, nei riverberi indistinti che le fiamme creano sugli argini, sui campi, sulle piazze e sui sagrati.
In tale gioco di luci e di ombre, in tale danza del fuoco che dialoga con i contorni del buio, si vanno a tessere brandelli di storia minuta di un popolo che conserva i tratteggi luminescenti collegati alla propria memoria etnica, al proprio passato comunitario. Anche il popolo insediato in terra cremonese, in alcuni suoi clan provinciali, si comporta ancora oggi in eguale maniera, o meglio fino ai tempi ante pandemici del Covid 19.
Nel ravvivare tale evento ciclico e costante della tradizione popolare cremonese, lo si viene inevitabilmente a collegare idealmente ai mille falò che la gente, in ogni parte d’Europa e del mondo, innalzava fino ad un paio di anni fa al cielo, come per unire il proprio gesto rituale, la propria voce, al coro delle stelle, a quei minuscoli falò intermittenti presenti nel mistero dell’infinito notturno.
- LA SUGGESTIONE ARCAICA DEI FALÒ RITUALI
La prima volta in cui ho potuto assistere ad un fuoco rituale in territorio cremonese, fu moltissimi anni fa, a Torricella del Pizzo, su uno degli argini che difendono quel paese dal Po. Non mi ricordo più in quale occasione del calendario venisse acceso quel falò. Sono sicuro però che fosse l’anno 1955. Il falò mi fece una grande impressione. Allora, probabilmente, non pensai a nulla, se non di rimanere incantato di fronte a quella pira.
Da adulto, invece, assistendo a questo rituale, mi è sorto il pensiero di trovarmi di fronte alla reliquia di una cerimonia arcaica, legata al culto della terra, della vegetazione, della fertilità. E credo che rituale agrario o agricolo lo si possa ancora definire oggi, essendo particolarmente diffuso in ambiente rurale. Collegati con l’origine primordiale sono poi i motivi esorcizzanti, scaramantici, ancora presenti e vivi nelle comunità che presenziano alla sua effettuazione.
Quello che mi ha maggiormente interessato nel corso degli anni è stato il ‘dispositivo di convocazione’ del rituale; dispositivo che mi ha portato a collocare lo studio di questo momento di festa all’interno della scienza del teatro e all’interno di quella vasta area estetica racchiusa dall’arco che unisce due poli: quello ludico e quello sacro.
Significativo al riguardo è lo studio de’ l falòch di Pescarolo (CR), ossia del falò della quercia per il Martedì Grasso e dei relativi momenti di preparazione, che rimandano ad un’epoca lontanissima, quando nel mese di maggio, mese dedicato ai defunti, avveniva il trasporto solenne di un albero in paese ed il suo bruciamento.
S’ipotizza che tale rito primaverile si sia spostato, nel corso delle epoche storiche, verso tempi calendariali diversi, ed inserito nell’ultimo giorno che si contrappone alla Quaresima.
Mircea Eliade, riportando una tesi del finlandese Walter Liungman, scrive che “in una certa zona (Balcani, ecc.), l’usanza si è spostata verso le feste di Natale e di Capodanno; nell’altra zona (Occidente), l’uso si è fissato sul Martedì Grasso (Carnevale), poi sul 1° Maggio, la Pentecoste e il giorno di San Giovanni”.
Cosicché tale celebrazione primitiva potrebbe trovare rimandi nella contemporaneità sia nei rituali folklorici silvani del mese di maggio e sia nei rituali del bruciamento di alberi e fantocci per Carnevale.
- GLI SLITTAMENTI DELLE DATE SULLO SCIVOLO STORICO DEL FOLKLORE
Paolo Toschi scrive che bisogna infatti tenere in considerazione, che “lo spostarsi delle feste da una data all’altra anche per necessità di adattamento al clima e di altre condizioni sociali, hanno provocato il frequente trasferirsi da una data all’altra, o il confondersi delle forme rituali”.
Si è avuto, inoltre, nel corso dei millenni, il passaggio della credenza dello “spirito della vegetazione” dal mondo degli alberi e della selva a quello dei cereali e dei coltivi. Da feste celebrative di tipo silvano è quindi arguibile pensare che si sia passati a feste agrarie e della fertilità. Le quali ultime feste vengono poi col tempo a coincidere con le feste commemorative dei morti. Infatti, bisogna considerare che presso i popoli agricoltori sono gli antenati a donare la fertilità: essi si trovano all’interno della terra e da là sotto essi mandano su i frutti ai viventi. La benevolenza dei defunti, quindi, deve essere conciliata. Una volta riconciliati, nutriti e sollevati, i defunti proteggono e moltiplicano i raccolti.
Abbiamo così che le personificazioni delle ‘potenze’ e della fertilità del campo, concepite dai contadini come ‘il Vecchio’ o ‘la Vecchia’, le quali potenze iniziano col tempo ad accentuare il loro profilo mitico, e sotto l’influenza delle credenze funerarie, esse vanno ad appropriarsi della ‘struttura’ e degli ‘attributi’ degli antenati, degli spiriti dei defunti.
Con tale passaggio, scrive ancora Eliade, “i morti tornano per prendere parte ai riti di fertilità dei vivi”. Ma anche i vivi “hanno bisogno dei morti per difendere i seminati e proteggere i raccolti”.
In tale processo, va sottolineato l’aspetto significativo delle forme con le quali si manifesta la potenza della vegetazione, perché “sono le stesse che rappresentano le anime dei defunti”. Ed è una potenza che viene concentrata negli ultimi covoni del campo coltivato; covoni chiamati dai Tedeschi ‘la Vecchia’ ed ‘il Vecchio’.
Ernesto De Martino scrive da parte sua che tali denominazioni accennano “ora al languore o addirittura all’estinguersi di una energia numinosa decrepita a cui sta per essere procurata la morte (‘il vecchio’, ‘la vecchia’, ‘la morte’), ora alla epifania di una forza giovanile immacolata (‘la vergine’), pronta a nozze feconde (‘la sposa’)”.
In questa varietà di riferimenti va pure collocato il falò della Vecchia in area padana e cremonese, che ha assunto vari significati d’ordine satirico, sociale e politico lungo la propria storia secolare.
La dimostrazione di questa polivalenza ci è data dal “falò della Vecchia” col viso caricaturale di De Gasperi, in piazza Marconi, nel 1953, a cura della redazione del giornale della destra studentesca Il Mappamondo. Oppure il falò della Vecchia di qualche anno fa, sul cremasco, a cura di Sinistra e Libertà, dove il pupazzo da bruciare voleva rappresentare l’intero governo Berlusconi.
Così come, altrettanto, anni or sono da Gambara, nella Bassa bresciana, ricevetti una foto della Vecchia da bruciare, che rappresentava invece le malefatte del governo del mite democristiano Goria. Era quello un rogo curato dalla locale sezione dell’ARCI, contrapposto, nello stesso paese, ad un altro falò acceso, lo stesso giorno, il 17 di gennaio, dall’Azione Cattolica del paese, in una rivisitazione pirica della saga di Peppone e Don Camillo.
In questo contesto, mi piace ricordare il poeta Gigi Manfredini, il quale, nel 1982, scrisse la Cantàada per el fugòon de la vécia Pešèera, ‘Cantata per il grande fuoco della vecchia Pešèera, che riassume la vana utopia del desiderio di una uscita risolutiva da tutti i mali, prendendosela con la Pešèera di turno.
Cantàada per el fugòon de la Vécia Pešèera
(Cantata per il grande fuoco della Vecchia Pešèera)
Vàarda bèen, vécia Pešèera:
chì gh’è próont la masulèera
pareciàada da Cremùna,
bröta vécia bešuntùna,
per brüzàate in sö la légna,
bröta Vécia cun la tégna.
Guarda bene, vecchia Pešèera:/ qui è pronta la catasta di fascine/ approntata da Cremona,/ brutta vecchia sporca d’unto,/ per bruciarti sulla legna,/ brutta vecchia con la tigna.//
Scùulta bèen per che rešòon
te fùm móorer sö ‘l fugòon,
té cun töt chèl che de dàn
te gh’èet fàt a tàanti istàn,
té cun töt chél che de gràm
gh’è a ste móont cùma la fàm!
Ascolta bene per quale ragione/ ti facciamo morire sul grande fuoco,/ te con tutto quel che di dannoso/ hai fatto a tanti quest’anno,/ te con tutto quel che di sgradevole/ c’è a questo mondo come la fame!//
In sö ‘l fóoch la to cundàna
tàanta gèent che la sgangàna;
in de ‘l föm e in sö la bràaša,
tàanta gèent che vóol na càaša;
sot la sèner stufegàada,
tàanta gèent in sö la stràada!
Sul fuoco la tua condanna/ per tanta gente che tribola;/ nel fumo e sulle braci/ per tanta gente che vuol la casa/ sotto la cenere soffocata/ per tanta gente senza tetto.//
Brüüša, brüüša, Vécia Gòoša,
e con te chi töt ‘l ingòoša!
Brüüša, brüüša, Vécia infàma,
e cun té chi ‘l móont ‘l afàma!
Brüüša, brüüša Vécia sghèra,
e cun té chi vóol la guèra!
Brucia, brucia, Vecchia con i gozzi,/ e con te chi tutto ingozza!/ Brucia, brucia, Vecchia infame,/ e con te chi il mondo affama!/ Brucia, brucia, Vecchia severa,/
e con te chi vuol la guerra.//
Brüüša, brüüša, Vécia Gòoga,
e cun té chi ‘l vèent la dròoga!
Brüüša, brüüša, Vécia Stréa,
e cun tè chi a ‘l móont la bréa
el vóol méter cun la fòorsa
per saràal in de na mòorsa!
Brucia, brucia, Vecchia Goga,/ e con te chi vende la droga!/ Brucia, brucia, Vecchia Strega,/
e con te chi al mondo la briglia/ vuole mettere con la forza/ per chiuderlo in una morsa! //
Brüüza, dòonca, bröta Vécia,
cun el màal ch’in tè ‘l se spécia,
che, cun chéesta cerimònia,
brüüšum àan la marsimònia
de sté móont che, per dumàan,
el póol esèr püsèe sàan!
Brucia, dunque, brutta Vecchia,/ con il male che in te si specchia,/ che, con questa cerimonia,/
bruciamo anche il marciume/ di questo mondo che, per domani,/ possa essere più sano.//
Nel testo la Pešèera è qualificata anche come “Vécia Gòoša”, o “Vécia Gòoga”. Ed infatti, in una logica comparativa, non possiamo nemmeno dimenticare che la vecchia Pešèera, per rapire i bambini, fuoriesce pure dal pozzo al pari di altre consorelle, quali ad esempio la vecchia Gòoša o Gòša e la Peterlèenga. La Gòoša o Gòša è conosciuta a Torre de’ Picenardi, a Torricella del Pizzo e a Scandolara Ravara, mentre la Peterlèenga rientra nella tradizione popolare di Robecco d’Oglio ed Olmeneta.
Nel 1984, nel mentre la Vecchia viene condotta al rogo nel campo davanti al Cascinetto, dalle parti di via Postumia, vennero intonate salmodie carnascialesche dai “Cantilenanti bianchi”, ossia da giovani incappucciati in bianco costume. Nel 1987 altre litanie furono registrate su nastro e diffuse da un altoparlante fissato su un’automobile che precedeva il corteo, i cui membri rispondevano alle stesse contumelie. La voce su nastro diceva:
“Bröta Vécia sabelùna...”
(Brutta Vecchia dalle gambe sbilenche)
Ed il corteo rispondeva:
“La te brüüša incóo Cremùna!”
Quindi ancora la voce registrata:
“Bröta Vécia sacagnèenta...”
(Brutta Vecchia malmenata...)
Ed il coro dietro:
“De brüšàate l’è cuntèenta!”
(Di bruciarti è contenta)
E poi ancora dall’altoparlante:
“Bröta Vécia saculùna...”
(Brutta Vecchia che ha poca cura dei propri abiti...)
E la gente ripeteva il ritornello:
“La te brüüša incóo Cremùna!”
Quindi l’altro annuncio in rima baciata:
“Bröta Vécia saculèenta...”
(Brutta Vecchia sporca di fango...)
Al quale annuncio si rispondeva ovviamente:
“De brüšàate l’è cuntèenta!”
E così via per altre ottantatré aggettivazioni offensive predisposte dal poeta Gigi Manfredini.
Sicuramente il falò della Vecchia è uno dei rituali folklorici più diffusi nella Valle Padana, una manifestazione popolare che adombra e non svela il mistero di questo personaggio ancestrale.
Va pur detto però che tale figura mitologica ha lasciato un segno di sé anche nel dialetto soprattutto in funzione pedagogica, nel senso che è stato utilizzato nei rapporti educativi intercorsi fra gli adulti, genitori e nonni, e i bambini, al fine di divertire questi ultimi e di prepararli alla vita.
I materiali all’attenzione degli studiosi, nei quali è inserita la figura della Vecchia, sono costituiti da depositi verbali propri della cosiddetta “civiltà contadina”, che ricercatori attenti e sensibili hanno salvato dall’estinzione e dal buio della memoria.
Un giorno, il compianto amico Renzo Bodana mi parlò di una filastrocca udita da bambino in quel di Torre Picenardi, suo paese d’origine:
La Vécia Stréa
la gh’àa li gàambi stòorti,
la pìista li tòopi,
e la fà:
“Chirichichì!”
La Vecchia Strega/ ha le gambe storte,/ calpesta le talpe,/ e strombazza:/ “Chirichichì!”//.
Se è vero quel che asseriscono i più qualificati studiosi del folklore, ossia che la tradizione popolare conserva nelle fiabe, nelle filastrocche, nelle ‘conte’, nei giochi infantili da cortile e da strada, le tracce, le reliquie, i fossili di antichi saperi, e di antichi modi di concepire la vita ed il creato, allora si può comprendere perché io sia rimasto così affascinato da quella formuletta, da quel reperto linguistico, che generazioni e generazioni di bambini di Torre Picenardi si sono passati di bocca in bocca a partire non si sa bene da quando.
La filastrocca, disegnata dalla semplicità scolpita e levigata dagli anni, ci propone le movenze e i comportamenti di una delle figure ricorrenti nelle ‘fiabe di magia’, la Vecchia, la Vécia, o vecchia strega o maga, posta a presidio, in quelle favole, della casetta nella quale i bambini, superate le prove di paura, della fame, del dolore e dell’inganno, diventano più grandi, misurando la loro crescita e dando inizio ad una nuova vita, ad una vera e propria rinascita.
Nella fiaba russa la casetta, detta pure ‘capannuccia’, sorge talvolta su zampe di gallina. Essa è posta dalla tradizione popolare nel bosco o nella foresta primeva, e rappresenta a livello etnologico l’animale totemico nel quale la tribù o tutto il clan familiare s’identificano. Infatti, nella fase storica precedente alla trasformazione di alcuni animali da selvatici in domestici, gli studiosi dicono che ogni clan venerasse un animale ritenuto un parente, un lontano progenitore. È la fase questa che è poi precipitata nella fiabistica, nella quale anche la gallina è considerata ‘fiera’ ed è oggetto di culto totemico.
Tracce e rimandi a questo segno di un tempo lontano si vogliono leggere anche nella figura della Befana austriaca, la Perchta, munita di becco e zampe di gallina, così come nei mascheramenti presenti nei carnevali arcaici moderni dove si propongono ancora travestimenti per mezzo di piume. Si hanno pure testimonianze in Francia di uomini che si mascheravano spalmandosi di marmellata o di miele, per poi rotolarsi nelle piume di gallina. Stesso travestimento è usato anche dalla donna protagonista della fiaba padana che s’intitola La dóna la na sà vöna püsèe de’l diàavol (‘La donna ne sa una più del diavolo’). Difatti la donna, sotto le spoglie di penne e piumini di gallina, riesce persino ad ingannare il demonio.
Tracce di questa forma di mascheramento si hanno pure nella tradizione orale cremonese e mantovana a proposito della famosa Nòt de binél (‘Notte del vino fresco’), fra il 16 e il 17 di gennaio, vigilia di Sant’Antonio Abate, spazio nel quale il mondo si rovescia e le bestie parlano e le donne tacciono e véen fóora töti i màt (vengono fuori tutti i matti).
Ebbene, in quella notte, un altrettanto mitico contadino, per spaventare le donne che avevano infranto la consegna ed il tabù del silenzio, si fece passare per un essere dell’aldilà spaventando le malcapitate riunite nella stalla, con la messa in mostra, da una botola del soffitto, della propria gamba tutta ricoperta di piume di gallina.
Un altro rimando nel folklore cremonese alla ‘gallina totemica’, che s’identifica ed è un tutt’uno con la Vecchia, quasi come a voler certificare le parole del grande folklorista russo Vladimir Propp quando questi asserisce che la maga del mito è ‘a un tempo una vecchia e un animale’, si può cogliere in una seconda filastrocca, quella della galìna pirulìna, la ‘gallina pirulìna’
La galìna pirulìna
la fa ‘l óof in de la tìna,
la fa l’óof in de ‘l tinàs,
ciàpa la Vécia per el nàas,
ciàpela per la cùa
mèenela a càaša sùa.
La gallina pirulìna/ fa l’uovo nel tino, / fa l’uovo nel tinaccio, / prendi la Vecchia per il naso, / prendila per la coda, / portala a casa sua.
È molto utile sottolineare che il termine pirulìna, in questo caso, riguarda il naso: è il diminutivo di piróola, che significa ‘naso voluminoso’. Da subito, con galìna pirulìna, si presenta il sembiante di una gallina che cela una delle caratteristiche prime della Vécia, onde riconoscerla e cacciarla via dalla cantina, luogo dove essa viene collocata dall’immaginario collettivo popolare a guisa di spauracchio, al fine d’impaurire i bambini che non devono assolutamente entrare là dove magicamente l’uva sta fermentando, e dove pure i pütéi possono, sbadatamente o volutamente, entrare nella tìna o nel tinàs e trovarvi la morte.
Detto ciò, è giunto il momento d’identificare bene il personaggio della ‘Vécia Stréa’ della prima filastrocca con l’ausilio di un percorso filologico e di diverse stratificazioni concettuali.
Infatti, il termine dialettale stréa vede già compiuta una precisa metamorfosi linguistica, a partire dal latino classico strix (uccello notturno, gufo), al latino volgare striga (strega).
Questo passaggio d’immagine parte dalla positività del gufo, fantasticato dagli antichi addirittura provvisto di mammelle ed offerente il latte ai bambini, per precipitare verso una dimensione denigratoria nella quale striga viene concepita come uno stridulo uccello notturno assetato del sangue dei lattanti, una sorta di arpia o vampiro.
Ma il termine strix viene riferito dai classici latini anche alle donne che, al pari delle maghe degli Sciti descritte da Ovidio, sono in grado di trasformarsi in uccelli.
Ora, dopo averla percepita con tutta la repulsione che si è trascinata nei secoli, ci viene precisato, dalla prima filastrocca cremonese, che la Vecchia Strega la gh’àa li gàambi stòorti. Ed è veramente sorprendente che simile descrizione venga indicata pure in leggende caucasiche a proposito di un personaggio mitico degli Osseti, Soslan, una specie di sciamano capace di andare vivo nell’aldilà e di tornarne, il quale viene schernito brutalmente con il riferimento dispregiativo di ‘mago dalle gambe storte’.
Georges Dumézil, in Storie degli Sciti, riferisce che pure il corrispettivo di Soslan , fra i Circassi, viene deriso con il medesimo riferimento alle gambe sghembe, dal movimento deambulatorio asimmetrico, proprio di personificazioni che si muovono fra i due mondi, quello dei vivi e quello dei morti. Altrettanto dicasi per lo sciamano dalle gambe storte di un mito georgiano, così come del greco Efesto, il dio fabbro dai piedi storti.
Gli studiosi parlano di prestiti e di influenze fra il mondo greco ed il mondo caucasico attraverso il Mar Nero. Né possiamo dimenticare i rapporti millenari fra queste aree e la Valle del Po testimoniate dalla storia, dalla letteratura e dall’archeologia.
Ne sono una consistente testimonianza gli Argonauti greci di Apollonio Rodio che entrano dall’Adriatico nel grande fiume, immerso fra fitti boschi di pioppi; e poi il mito di Fetonte precipitato nell’Eridano-Po; così come i reperti attici del museo archeologico di Adria, antica porta del Po sul mare, fra il Mar Nero e le terre padane con rapporti che si sono ulteriormente vivificati con i Romani, con i Goti e soprattutto con i Bizantini. Certo l’areale mediterraneo ha pure avuto altri contatti col mondo slavo ed uralico, e questo incontro è andato ad incidere i propri segni, con scambi e trasmigrazioni di correnti culturali, negli intrecci delle fiabe e dei miti.
Un comune sottofondo di queste linee porta comunque a prendere in considerazione l’ancestrale figura della ‘Signora degli animali’, presente nel mondo dei cacciatori paleolitici e nelle religioni dei popoli artici e nord-asiatici sotto la forma di ‘madre degli animali’.
Simili a questa sono le dee madri delle civiltà agricole euro-asiatiche, come quella della grande dea antropomorfa di Catal Huyuk, in Anatolia, città di mattoni, che i recenti studi datano a circa novemila anni da noi e che si può dire abbia costituito il nucleo primario della nostra stessa civiltà. Il predominio di queste figure sul mondo animale ci porta a leggere allo stesso modo le indicazioni che ci forniscono i ‘fossili del dialetto’, ossia quelli della donna attempata della filastrocca, la Vécia, custode delle antiche arti magiche e della capacità di comunicare con il regno sotterraneo degli antenati, definita in seguito Stréa, la quale porta ancora il segno sfumato e deriso di quel potere.
La filastrocca ci dice che essa la pìista li tòopi, calpesta le talpe, ma contemporaneamente lascia pure trasparire un residuo del suo antico dominio su questi animaletti che portano in sé il simbolo della cecità; di una cecità mitica che è propria anche della Vecchia del mito, così come è propria di tutti coloro che avvertono la dimensione della profezia, della sapienza, del canto e della poesia.
La Vécia ha dominato questi animaletti-guida, le talpe, che sono i corrieri consueti e più conosciuti col regno che è presente sotto le zolle del campo, là dove riposano gli avi, là dove alberga il mondo precluso ai vivi.
Presso i nativi americani, quali gli Zuni ad esempio, la talpa è ritenuto ancora un animale guardiano, signore degli inferi, ‘robusto di cuore e forte di volontà’.
Nel ribaltamento dei valori avvenuto lungo i secoli, riassunto dalla trasformazione della Vecchia colma di saggezza in strega, anche la talpa, la tòopa, è stata declassata. Tant’è che il termine ‘talpa’, nel mondo moderno, viene applicato ai traditori, alle spie o alle persone che forniscono informazioni segrete dall’interno.
Ma nel vecchio dialetto del Cremonese, la tòopa, al pari della mèerla, conserva un contorno fascinoso, venendo a rappresentare per antonomasia il genere femminile, la donna, ed il suo sesso.
In questa analisi non possiamo nemmeno dimenticarci dei processi d’identificazione della Vecchia con un animale presenti nella mitologia.
Ad esempio, nelle leggende dell’America settentrionale si parla di una ‘vecchia donna’ che è un sorcio, en sorèch, o ‘n sùrech direbbero i Soresinesi che si ritrovano, pure loro, il topo o la topina, la sureghìna, in un antico stemma, allorquando la città veniva chiamata, appunto, ancora in ‘modo totemico’ Sorexina.
Si ha pure il caso che la Vécia sia un’anatra, na nàadra. Oppure si ha il caso che l’alter ego della Vécia sia una grande aquila rossa.
Questo rimando ci riporta alle tesi secondo la quale la tradizione popolare conserva nel proprio seno le reliquie, i fossili di antichi saperi, i segni dei modi di concepire la vita ed il creato in stagioni lontanissime dal nostro attuale tempo. E questi segni, queste reliquie, questi fossili linguistici sono presenti nelle fiabe, nelle filastrocche, nelle ‘conte’, nei giochi infantili.
Per questo motivo si può comprendere perché chi vi sta parlando sia rimasto affascinato da un reperto linguistico che generazioni di bambini di Torre Picenardi si sono passati di bocca in bocca, a partire non si sa bene da quando.
La filastrocca, disegnata dalla semplicità levigata dagli anni, propone infatti le movenze e i comportamenti di una delle figure ricorrenti nelle ‘fiabe di magia’, la Vecchia, la Vécia, o Vecchia Strega o Maga, posta a presidio, in quelle favole, della casetta nella quale i bambini, superate le prove di paura, della fame, del dolore e dell’inganno, diventano più grandi e misurano la loro crescita, dando così inizio ad una nuova vita, ad una vera e propria rinascita.
Nella fiaba russa, analizzata in modo straordinario dal folklorista Vladimir Jacovlevic Propp (1895-1971) la casetta, detta pure ‘capannuccia’, sorge talvolta su zampe di gallina. Essa è posta dalla tradizione popolare nel bosco o nella foresta primeva, e rappresenta a livello etnologico l’animale totemico nel quale la tribù o tutto il clan familiare si erano identificati.
Infatti, nella fase storica precedente alla trasformazione di alcuni animali selvatici in domestici, gli studiosi dicono che ogni clan venerasse un animale ritenuto un lontano progenitore. È la fase, questa, precipitata poi nella fiabistica; fase nella quale anche la gallina veniva considerata una ‘fiera’, oggetto di culto totemico.
Tracce e rimandi a questo tempo lontano si sogliono leggere pure nella figura della Befana austriaca, la Perchta, munita di becco e zampe di gallina, così come nei mascheramenti presenti nei carnevali arcaici moderni, dove si propongono ancora travestimenti per mezzo di piume.
Si hanno pure testimonianze in Francia di uomini che si mascheravano spalmandosi di marmellata o di miele, per poi rotolarsi nelle piume di gallina. Stesso travestimento è usato anche dalla donna protagonista della fiaba padana intitolata “La dóna la na sà vöna pÏÂÂÂsèe de’l diàavol” (“La donna ne sa una più del diavolo”). Questa donna, sotto le spoglie di penne e piumini di gallina, riesce persino ad ingannare il demonio.
Un diverso riferimento alla ‘gallina totemica’, che s’identifica ed è un tutt’uno con la Vecchia, si può cogliere altresì in una seconda filastrocca, quella della galìna pirulìna, la ‘gallina pirulìna’, dove sembra si materializzino le parole del folklorista russo Vladimir Propp, quando questi asserisce che la Maga del mito è “a un tempo una vecchia e un animale”.
- I PROCESSI DI CADUTA NEL FOLKLORE
Detto ciò, è giunto il momento d’identificare il personaggio della Vécia Stréa della prima filastrocca con l’ausilio di un percorso filologico e di diverse stratificazioni concettuali. Infatti, il termine dialettale stréa vede già compiuto il processo linguistico derivante dal latino classico strix (uccello notturno, gufo), al latino volgare di striga (strega). Questo passaggio d’immagine semantica parte dalla positività del gufo, fantasticato dagli antichi addirittura provvisto di mammelle ed offerente il latte ai bambini, per precipitare verso una dimensione denigratoria nella quale striga viene concepita come uno stridulo uccello notturno assetato del sangue dei lattanti, a guisa di arpia o vampiro.
Ma il termine strix viene riferito dai classici latini anche alle donne, le quali, al pari delle maghe sciite descritte da Ovidio, sono in grado di trasformarsi in uccelli.
Ora, dopo averla percepita con tutta la repulsione possibile che si è trascinata nel corso dei secoli, ci viene precisato, dalla prima filastrocca cremonese, che la Vecchia Strega la gh’àa li gàambi stòorti (ha le gambe storte). Ed è veramente sorprendente che simile descrizione venga indicata pure in leggende caucasiche a proposito di un personaggio mitico degli Osseti, Soslan, una specie di sciamano capace di andare vivo nell’aldilà e tornarne, che viene schernito brutalmente con il riferimento dispregiativo di ‘mago dalle gambe storte’.
Georges Dumézil, in Storie degli Sciti, riferisce che pure il corrispettivo di Soslan , fra i Circassi, viene deriso con il medesimo riferimento alle gambe ed al movimento deambulatorio asimmetrico, proprio di personificazioni che si muovono fra i due mondi, quello dei vivi e quello dei morti. Altrettanto dicasi per lo sciamano dalle gambe storte di un mito georgiano, così come del greco Efesto, il dio fabbro dai piedi storti.
Gli studiosi parlano di prestiti e di influenze fra il mondo greco ed il mondo caucasico attraverso il Mar Nero. Né possiamo dimenticare i rapporti millenari fra queste aree e la Valle del Po testimoniate dalla storia, dalla letteratura e dall’archeologia.
Ne sono una consistente testimonianza gli Argonauti greci di Apollonio Rodio che entrano nel grande fiume fra fitti boschi di pioppi; il mito di Fetonte precipitato nell’Eridano-Po; i reperti attici del museo archeologico di Adria, antica porta del Po sul mare.
Fra il Mar Nero e le terre padane i rapporti si sono pure arricchiti con i Romani, con i Goti e con i Bizantini.
In merito a questi flussi culturali inaspettati, è indicativo lo studio sui ‘gotismi’ presenti nel dialetto della Valle del Serio, analizzati da Walter Venchiarutti e pubblicati, nel 2001, su Insula Fulcheria, antologia della Biblioteca di Crema.
Certo l’areale mediterraneo ha pure avuto altri contatti col mondo slavo ed uralico, e questo incontro è andato ad incidere i propri segni, con scambi e trasmigrazioni di correnti culturali, negli intrecci delle fiabe e dei miti.
Un comune sottofondo di queste linee porta comunque a prendere in considerazione l’ancestrale figura della ‘Signora degli animali’, presente nel mondo dei cacciatori paleolitici e nelle religioni dei popoli artici e nord-asiatici sotto la forma di ‘Madre degli animali’.
Simili a questa figura sono le dee Madri delle civiltà agricole euro-asiatiche, come quella della grande dea antropomorfa di Catal Huyuk, in Anatolia, la città di mattoni, che i recenti studi datano a circa novemila anni da noi, e che si può dire abbia costituito il nucleo primario della nostra stessa civiltà.
Il predominio di queste figure sul mondo animale ci porta a leggere allo stesso modo le indicazioni che ci forniscono i ‘fossili del dialetto’, ossia quelli della donna attempata della filastrocca, la Vécia, custode delle antiche arti magiche e della capacità di comunicare con il regno sotterraneo degli antenati, definita in seguito Stréa, che porta ancora il segno sfumato e deriso di quel potere.
Infatti essa la pìista li tòopi, calpesta le talpe, ma nel contempo lascia trasparire un residuo del suo antico dominio su questi animaletti portanti il segno della cecità; di una cecità che è propria anche della ‘Vecchia del mito’, così come è propria di tutti coloro che avvertono la dimensione della profezia, della sapienza, del canto e della poesia.
La Vécia ha dominato questi animaletti-guida, le talpe, che sono i corrieri consueti e più conosciuti col regno presente sotto le zolle del campo, là dove riposano gli avi, proprio là dove alberga il mondo precluso alle persone viventi.
Presso i nativi americani, quali gli Zuni ad esempio, la talpa è ritenuta ancora un animale guardiano, signore degli inferi, “robusto di cuore e forte di volontà”.
Nel ribaltamento dei valori avvenuto lungo i secoli, riassunto dalla trasformazione della Vecchia in Strega, anche la talpa, la tòopa, è stata declassata. Tant’è che il termine ‘talpa’, nel mondo moderno, viene applicato ai traditori, alle spie o alle persone che forniscono informazioni segrete dall’interno.
Ma la tòopa, nel vecchio dialetto del Cremonese, conserva un contorno fascinoso, venendo a rappresentare per antonomasia pure il genere femminile, la donna, ed il suo sesso.
In questa analisi non possiamo nemmeno dimenticarci dei processi d’identificazione della Vecchia con un animale presenti nella mitologia.
Ad esempio, nelle leggende dell’America settentrionale si parla di una ‘vecchia donna’ che è un topo, en sorèch, o ‘n sùrech direbbero chèi de Surešìna, ‘quelli di Soresina’, che conservano pure essi, in un antico stemma, il topo o la topina, la sureghìna, segno del tempo in cui la città veniva ancora chiamata, in ‘modo totemico’, Sorexina.
- LA VÉCIA CUCÙNA
A Cremona, invece, abbiamo la conferma, in una variante della prima filastrocca, che la Vécia appartenente ad una ipotetica primordiale tribù padana, abbia avuto a che fare, in qualche significativo rituale, con le sembianze di una grande gallina:
La Vécia Cucùna
la gh’àa le gàambe stòorte,
la pìca a le pòorte,
e la fà:
“Curucucù!”
La Vecchia Gallinona/ ha le gambe storte,/ bussa alle porte,/ e strombazza:/ ‘Curucucù!’
La Vécia Stréa, che qui viene definita Vécia Cucùna, mantiene le gambe storte, ma anziché pistàa li tòopi (pestare le talpe) bussa alle porte, proponendo il suo avvicinarsi oscuro al pari di quello del Lupo verso le casette della fiaba dei tre porcellini, e nel modo analogo a quello della Vécia Pešèera, la Befana cremonese arcaica che s’avvicinava alle porte per la vigilia di Natale.
Tant’è che all’interno delle case, al suo avvicinarsi, si diceva con trepidazione:
Sàara so ‘l ös
che rìiva la Pešèera
che la fà:
“O l’àsa o la fiulàsa
o ‘l fióol o ‘l masóol…”.
Chiudi l’uscio/ che arriva la Pešèera/ che dice:/ ”O l’asse* o la figlia da marito/
o il figliolo o la fascina di legna”//
(L’àsa è l’asse pieno di vivande posto nella cosiddetta ‘cantinetta’ in terra battuta).
Il personaggio mitologico, al pari di tutte le creature del mondo ‘altro’, ha fame e ha freddo, e chiama i fanciulli per un finto rapimento rituale.
Questa dimensione scenica rimanda a quella riportata sul libro Cenalora dai resoconti di Oskar Eberle a proposito del teatro dei popoli primitivi.
Ma la cosa più sorprendente è che, fino a pochissimi anni fa, la signora Gina Mazzolari, di San Martino in Beliseto, nella sua cascina verso Casalbuttano, recitava la parte della Pešèera, fuori dall’uscio di casa, la sera della Vigilia di Natale. Era quella una ‘parte teatrale’, dettata da parte sua, dal voler divertire i nipotini, i quali ricevevano per l’occasione frutta e dolciumi.
In modo inconsapevole quella messa in scena era simile a quella della Vecchia della filastrocca, o pari, in una sorta di globalizzazione folklorica, a quella ben più impegnativa recitata dalle vecchie sagge dei popoli fermi all’età del legno, nei loro riti e giochi teatrali tribali.
- I SEGNI DELLA GALLINA CHE CANTA DA GALLO
Ed ora veniamo al verso finale della prima e della terza filastrocca, a quel chichirichì e a quel curucucù che abbiamo letto, ossia alle due parole onomatopeiche che rappresentano il suono del canto del gallo.
Qui ci soccorrono le ampie testimonianze della cultura contadina padana, raccolte anche nel mantovano e nel bolognese, dove si dice che la gallina che canta da gallo, o meglio ‘in gallesco’, predichi la morte del padrone di casa.
Evidentemente nel gioco dell’inversione del rito, ossia del capovolgimento in negativo di quanto un tempo lontanissimo aveva un significato altamente positivo, il canto primordiale del gallo è stato cristallizzato poi nel falso verso della gallina. Tale canto finto e mascherato è stato infine trasformato come un presagio di morte, la faccia rovesciata dell’annuncio di vita.
La trasposizione di senso, che rimanda agli stessi effetti che la superstizione attribuisce al richiamo notturno del gufo e della civetta, ha voluto ribaltare il significato allegorico della vita che si rinnova al risveglio del giorno annunciato dal gallo, al suono di quel chicchirichì che nel sentire comune riapre il sipario di ogni giorno e di ogni speranza nel cuore. Mentre il cupo curucucù richiama solo la notte e la disperazione.
I segni della speranza emergono pure dalle parole di una tiritéera raccolta a Casalmaggiore:
Vècia, mé ad dò an dént vèc
tè dàman vón nóf.
Dàmal tànt fòrt
ch’al dÏÂÂÂra fìna a la mòrt.
Vecchia, io ti do un dente vecchio/ tu dammene uno nuovo. /Dammelo/ tanto forte/ che mi duri fino alla morte.//
Certo pure chi scrive ricorda da bambino la ‘Vecchina del mito’, che mediante la complicità di papà William mise un soldino al posto del primo dente da latte caduto, nascosto sotto una pietra appoggiata ad un pilastro del portico della magica cascina dei conti Donati, ad Annicco (CR).
Il soldino lo ritrovai la mattina dopo con mia grande meraviglia, al posto del dentino misteriosamente sparito.
Allora non ero consapevole, come lo sono invece oggi, di aver vissuto da bambino in una sorta di paradiso terrestre dove l’incantesimo era quotidiano, e dove era naturale pensare che gli uccellini parlassero e che la Vecchina fosse vera.
Ogni mattina, in quel cortile, la più intrigante fra le sorprese veniva annunciata da una sveglia infallibile: il canto vigoroso e sempre risorgente del chicchirichì. La sorpresa? La luce!
Grazie dell’attenzione. Buona continuazione della giornata!
-------------
intervento, proposto in chiave folklorica al Museo della Civiltà Contadina.
Agostino Melega
5 aprile 2017