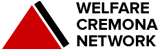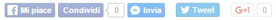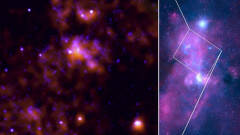Lontana è ormai da tempo l’”idilliaca fase” della prima metà degli anni ’90, quando Bill Clinton e Anthony Lake, suo Consigliere per la Sicurezza Nazionale, avevano optato per un appoggio incondizionato al riformismo di El’cin, considerato l’unico leader capace di mantenere il paese sulla via della democrazia. L’Occidente nel suo complesso aveva garantito un flusso costante di aiuti economici ottenendo in cambio la gratitudine del Cremlino, evidente soprattutto nella volontà di cooperazione nel settore del nucleare e nella disponibilità ad aprire il mercato russo agli investitori stranieri. Neanche l’attacco russo alla Cecenia, il 1° dicembre del 1994, era sembrato capace di rompere l’intesa. Nel quinquennio successivo però qualche tensione aveva cominciato a erodere la reciproca fiducia: l’allargamento della Nato alla Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, nel 1999, scontentò Mosca; la crisi finanziaria asiatica del 1998 ebbe forti ripercussioni sull’economia della Federazione, provocando anche una forte reazione antiamericana nell’opinione pubblica russa, proprio, tra l’altro, nel momento in cui, forte dei progressi sino ad allora mostrati, Clinton aveva deciso l’ingresso della Federazione nel G8 e l’avvio del suo processo di adesione nel wto; la crisi del Kosovo, con il conseguente bombardamento della nato sulla Serbia in assenza dell’autorizzazione dell’onu, tra il marzo e il giugno del 1999, provocò la dura reazione del Cremlino.
L’avvento di Putin e l’attentato alle Torri Gemelle
A dispetto di tutto ciò, complicità e identità di vedute riapparvero quando, ormai Presidente Putin già dal marzo del 2000, l’attentato alle Torri Gemelle, l’11 settembre del 2001, sembrò porre le basi per una nuova fase di collaborazione. La conferma di una minaccia ormai globale del terrorismo islamico fece dimenticare a Putin l’amarezza per le dure critiche subite per il nuovo attacco alla Cecenia dell’ottobre 1999 (nella sua veste di Primo Ministro) inducendolo a concreti gesti di amicizia verso Washington: gli aerei nato diretti in Afghanistan ottennero l’autorizzazione a sorvolare il territorio russo, la presenza di basi americane in Uzbekistan e in Kirghistan, paesi politicamente vicini a Mosca, venne accolta con favore, nel 2002 a Pratica di Mare fu istituito il Consiglio NATO-Russia, nel maggio dello stesso anno i due Presidenti firmarono il Trattato sort che prevedeva una riduzione delle testate nucleari dei due paesi. Gli obiettivi in quel momento di Mosca erano essenzialmente due: uno, più specifico, era quello di ottenere la benevolenza americana per la gestione della questione cecena, l’altro, di più ampio respiro, consolidare la crescita dell’economia russa convincendo gli Stati Uniti a cancellare una parte consistente dell’immenso debito russo nei loro confronti.
La nuova luna di miele ebbe però vita assai breve: l’attacco americano nel 2003 all’Iraq, paese con cui Mosca aveva solidi rapporti così come con Iran e Corea del Nord, tutti ormai apertamente definiti da Washington l’Asse del Male; le rivoluzioni colorate in Georgia (2003), Ucraina (2004) e Kirghistan (2005), dietro alle quali, secondo il Cremlino, vi era una chiara influenza americana; l’allargamento della nato e dell’Unione europea a est nel 2004 e le guerre del gas tra Mosca e Kiev da un lato e Mosca e Minsk dall’altro, tra il 2004 e il 2006, con le loro conseguenze negative sulle economie dei paesi europei, strettamente dipendenti dalle importazioni del gas russo; il Summit nato di Bucarest, nell’aprile del 2008, in cui Bush confermò la volontà americana di schierare il sistema missilistico di difesa in Polonia e Repubblica ceca annunciando con formula vaga che Ucraina e Georgia sarebbero potuti diventare membri dell’Alleanza; e, infine, la guerra intrapresa dalla Georgia per riprendere il controllo dell’Ossezia del Sud e la conseguente reazione militare russa, portarono a un crescendo di tensione che cancellò completamente il riavvicinamento che vi era stato dopo il 2001.
L’uscita di scena di Bush e di Putin − definitiva la prima, dopo due mandati, temporanea la seconda − e l’arrivo rispettivamente di Barack Obama e Dmitrij Medvedev garantirono invece ancora una volta un evidente, seppur altrettanto breve, rasserenamento. La politica di “Reset” promossa dal nuovo Presidente, ovvero il riposizionamento strategico americano verso il Pacifico e l’Estremo Oriente, già allora motivata dalle preoccupazioni suscitate dall’enorme crescita economica cinese, implicava una crescente marginalità di Europa e Medio Oriente, teatro quest’ultimo dal quale Obama annunciò l’intenzione di un rapido disimpegno in vista di un totale ritiro delle truppe da Afghanistan e Iraq. In questa cornice, la Russia appariva meno minacciosa e, anzi, per alcuni dossier un partner importante come, per esempio, quello della non proliferazione del nucleare. Non pochi furono i risultati del dialogo instauratosi tra Obama e Medvedev: il posticipo e poi la definitiva cancellazione dello schieramento dei missili in Polonia e Repubblica ceca, l’abbandono di qualsiasi piano di allargamento nato, la firma del “New Start” per la riduzione degli armamenti nucleari, nel 2011, la collaborazione per l’accordo sul nucleare iraniano, poi firmato effettivamente nel 2015, l’ingresso della Russia nel wto (2012) e, infine, sempre nello stesso anno, il ritiro da parte del Congresso dell’emendamento Jackson-Vanik, una norma degli anni Settanta che agiva da limite e ostacolo alla normalizzazione dei rapporti commerciali tra i due paesi, confermano l’assunto iniziale. Altrettanto vero è però che anche questo nuovo felice orientamento delle relazioni russo-americane non ebbe vita lunga.
L’inizio del terzo mandato di Putin, rieletto nel marzo del 2012, coincise in effetti con un quadro internazionale di grande tensione rispetto al quale la politica estera di Mosca assunse una postura completamente diversa dal passato. Lo scoppio delle cosiddette “Primavere arabe” in Tunisia, Egitto, Libia e Siria, tra il 2010 e il 2011, apertamente appoggiate dall’Occidente, suscitarono invece una iniziale diffidenza nel Cremlino pronto ad assumere una posizione sempre più assertiva via via che questi paesi cominciarono ad inclinare verso formule di governo dalla chiara impronta islamica. In Egitto Mosca riempì il vuoto lasciato dagli americani che, dopo le rivolte popolari contro Mubarak, avevano apertamente simpatizzato con il governo dei Fratelli Musulmani a loro volta poi rovesciati dall’esercito appoggiato dalla folla. Obama reagì tagliando gran parte delle forniture militari e degli aiuti economici al Cairo, ma il nuovo governo del Generale al-Sisi non tardò a trovare un valido sostituto nel Cremlino disposto a concludere un’ampia intesa sia in campo industriale che militare; in Siria la difesa a oltranza di Assad contro le forze di opposizione, tra cui anche gruppi islamici, fu netta sin dall’inizio della crisi e di fronte al perpetuarsi delle incertezze occidentali avrebbe portato la Russia a intervenire militarmente a difesa del governo di Damasco nel settembre del 2015 provocando una fortissima tensione con Washington; in Libia infine, a dieci anni di distanza dall’intervento militare internazionale che vide protagoniste soprattutto la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e, in più piccola parte l’Italia, oggi sono la Russia e la Turchia a controllare effettivamente il paese ancora diviso.
Considerata illiberale la staffetta Medvedev-Putin e ricca di ombre la terza elezione di quest’ultimo, i repubblicani cominciarono a criticare la politica di “Reset” di Obama definendola un vero e proprio “appeasement” nei confronti della Russia. Nonostante le perplessità del Presidente, nel 2012 il Congresso approvò il “Magnitsky Act” con cui si limitava l’ingresso nel territorio americano ai cittadini russi responsabili di violazione dei diritti umani congelando i loro beni negli usa. La Duma rispose vietando l’adozione di bambini russi da parte di coppie residenti negli stati che, come gli USA, riconoscono tale diritto per le coppie omosessuali. Da quel momento l’opinione pubblica americana avrebbe seguito con sempre maggiore attenzione la “questione russa” in tutte le sue sfaccettature anche interne: dal giro di vite contro i giornalisti, gli attivisti per i diritti umani, gli esponenti delle organizzazioni non governative, al caso delle Pussy Riots, alle leggi omofobe del 2013 (che indussero per protesta Obama a non partecipare all’apertura dei Giochi Olimpici invernali a SoÄÂi nel febbraio del 2014) all’asilo politico concesso a Snowden, contractor della “National Secutity Agency”, che aveva rivelato l’esistenza del programma di spionaggio “Prism”.
L’annessione della Crimea e il nuovo volto della Russia
Se le relazioni erano già ampiamente peggiorate tra il 2012 e il 2014 fu però sicuramente la crisi Ucraina, l’annessione della Crimea alla Federazione e la questione del Donbass a renderle tese come mai prima. Washington condannò come illegale il referendum, dure sanzioni vennero emanate sia dagli Stati Uniti che dall’Unione europea, il numero delle esercitazioni NATO nei paesi prossimi alla Russia si infittì da quel momento con l’impegno di creare nuove basi in Polonia e nei paesi Baltici, la Federazione venne sospesa dal G8. Tutte misure però che non sono riuscite a incidere sul governo russo che, grazie in quell’occasione a un forte consenso popolare, ha giocato la carta del patriottismo e della sindrome di accerchiamento da parte di un mondo ostile, di lontana memoria sovietica, per distogliere l’attenzione della popolazione dalla difficile situazione economica e da altre fragilità interne che già allora affliggevano il paese.
Da quel 2014 la Russia è cambiata. A prezzo di notevoli sacrifici nel campo del rispetto dei diritti umani, Putin ha ritrovato, ancor di più che durante le sue precedenti presidenze, le ragioni di un forte senso di identità nazionale ispirato alla natura euroasiatica del paese oltre che al patriottismo e al conservatorismo politico, religioso e culturale. Memoria storica condivisa intorno al mito ancora molto sentito nello spazio postosovietico della Grande Guerra Patriottica, richiamo costante al ruolo unificante della ortodossia ma soprattutto valorizzazione della lingua russa che, nonostante un ovvio progressivo ridimensionamento nel suo uso dopo il crollo dell’urss, rimane ancora un fondamentale strumento di comunicazione in tutto lo spazio postsovietico, sono i tre pilastri su cui poggia il progetto politico dell’attuale élite russa che fonda la sua ragion d’essere sul concetto di “Russkij Mir”, ovvero il riconoscimento di una vocazione quasi messianica di una civiltà russa che va ben oltre i confini nazionali e che, oltre a comprendere tutti i russi che dopo il 1991 si trovano a vivere al di là dei confini della Federazione, mira al recupero di un’eredità sovietica non concepita solo in termini geopolitici ma intesa anche come “alterità” rispetto al cammino seguito durante il ‘900 dal resto d’Europa. Un progetto politico certo non nato in quel 2014 ma che da quell’anno è diventato imprescindibile bussola per un’élite sempre più convinta che solo grazie a tale messaggio unificante si potranno rafforzare i legami con quei paesi ex sovietici che Mosca considera, sia a occidente che a oriente, il suo “Estero vicino” o, forse sarebbe meglio dire, il suo “Interno lontano”. Paesi con cui il Cremlino già da tempo ha avviato forme di integrazione sia sul piano della difesa e sicurezza comuni, come l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza collettiva, che su quello economico, come l’Unione Economica Eurasiatica.
Scopo ultimo di tutto ciò è il recupero dello status di grande potenza della Federazione. La dura reazione dell’Unione Europea e di Washington, con l’applicazione delle sanzioni economiche, ha in effetti spinto Putin a rafforzare ulteriormente il dialogo con altri interlocutori internazionali e in primo luogo con la Cina. Proprio nel maggio 2014 il Presidente firmò con Pechino un ampio accordo per una fornitura trentennale di metano e la costruzione di un imponente gasdotto, dal nome “Forza della Siberia”, che è stato poi inaugurato il 2 dicembre del 2019 ed è a oggi la principale infrastruttura nel trasporto di gas naturale di tutto l’Oriente russo con i suoi circa 3000 km di lunghezza. Sempre dopo la crisi della Crimea, nel giugno del 2014, Putin compì un lungo viaggio in America Latina tra Cuba, Nicaragua, Brasile e Argentina. Eccezione fatta per l’Avana, tutte tappe inedite per un leader del Cremlino e che testimoniano un allargamento di prospettive propriamente globale.
Nel 2016 Trump ereditò dunque da Obama una situazione estremamente complessa né la fiducia tra i due paesi era mai stata, dopo il 1991, così scarsa. I primi tentativi del nuovo Presidente di riavviare con Mosca un dialogo più ad ampio raggio sulle tante questioni delicate aperte nell’agenda internazionale sarebbero però rimasti nel limbo delle buone intenzioni, ostaggio delle indagini a lungo condotte sulle interferenze russe nella campagna presidenziale americana e della continua tensione alimentata soprattutto dalla crisi siriana. Così, alla fine, la vera scelta di Trump è stata quella dell’immobilismo: del resto qualsiasi strategia egli abbozzasse all’indirizzo del Cremlino è stata sempre aprioristicamente denunciata o come cinico baratto di favori con Mosca, con il sacrificio degli interessi e dei diritti degli alleati degli Stati Uniti in Europa, o come mano libera per l’influenza russa in altre aree del mondo.
Né niente è mutato dopo l’elezione di Biden nel novembre del 2020 e il suo breve incontro con Putin a Ginevra il 16 giugno del 2021. Dopo la delusione avuta con Donald Trump, sul quale inizialmente il Cremlino aveva riposto non poca fiducia, Mosca non nutre alcuna speranza in una distensione né è questo ciò che Biden ricerca.
Già in campagna elettorale quest’ultimo aveva sottolineato la sua volontà di riportare al centro dell’attenzione internazionale i valori della democrazia e come lotta alla corruzione, difesa dall’autoritarismo, promozione dei diritti umani nel mondo sarebbero state alcune delle principali priorità dell’agenda di politica estera della sua amministrazione in caso di vittoria.
In effetti, gli unici risultati reali del rapidissimo vertice sono stati il rientro dei rispettivi ambasciatori nelle proprie sedi – richiamati poco tempo prima in conseguenza delle sanzioni imposte dalla nuova Presidenza americana in risposta agli attacchi di hacker russi e alle presunte interferenze in campagna elettorale – e una dichiarazione con cui i due Presidenti riconoscono la responsabilità comune delle due potenze nucleari per la stabilità strategica. Risultato ben scarno a conferma di quanto i due paesi siano oggi profondamente distanti: non hanno interessi economici comuni, gli scambi culturali sono praticamente congelati, nei conflitti internazionali si trovano spesso sulle linee del fronte opposte.
Conclusioni
Siamo dunque alla soglia o già immersi in una nuova guerra fredda? Quale è il rischio che nell’uno o nell’altro caso si possa giungere a un conflitto armato? Se al secondo quesito è abbastanza facile rispondere in senso negativo, più difficile è trovare una risposta convincente al primo di essi. Certo è che, per quanto i rapporti siano molto tesi e contraddittori, a differenza di un tempo Stati Uniti e Russia non sono rivali ideologici assoluti in uno scontro pressoché totale, il potere è oggi più diffuso di quanto non fosse nel sistema bipolare e la Russia è per gli Stati Uniti molto meno rilevante di quanto lo fosse un tempo l’Unione Sovietica. Il posto di quest’ultima è infatti oggi occupato dalla Cina che rappresenta il vero astro emergente del sistema internazionale contemporaneo e alla quale, dopo la crisi della Crimea, anche Mosca ha guardato con crescente attenzione e interesse.
(Elena Dundovich, Geopolitica.info cc by)