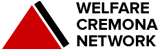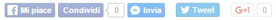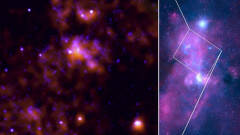Il termine dumping in economia designa la pratica da parte delle imprese di vendere merci all’estero a prezzi inferiori rispetto al mercato interno per ottenere vantaggi competitivi sulle altre aziende. Con il termine social dumping si intende invece la pratica per cui le aziende ricercano forza lavoro al di fuori dei confini nazionali con il fine di ottenere un vantaggio competitivo sul prezzo di questa oppure sulle condizioni a cui questa viene venduta. Con la progressiva globalizzazione ed internazionalizzazione dei mercati, infatti, si è reso sempre più facile per le imprese, soprattutto quelle di dimensioni considerevoli, ottimizzare i costi di produzione cercando mano d’opera dove i livelli salariali o di tutela dei lavoratori sono più bassi, talvolta delocalizzando parte della produzione o, nella minoranza dei casi, utilizzando forza lavoro transfrontaliera. La creazione di spazi in cui sono stati aboliti gli ostacoli doganali a favore del libero commercio e libero scambio ha ulteriormente facilitato la pratica della delocalizzazione per quelle imprese che intendono ottimizzare il costo dei fattori produttivi. L’UE è senza dubbio un esempio calzante di spazio commerciale in cui è garantito il libero commercio e, pertanto in questa sede ci si concentrerà su di essa e sulle pratiche di social dumping al suo interno. Si sottolinea tuttavia che le dinamiche di dumping sono presenti in molte aree del globo ed in nessuna maniera sono limitate all’UE.
L’UE: un’area dove il social dumping può proliferare
Il lungo processo di integrazione europea, fin dal suo inizio con la firma del trattato di Roma nel 1957 che istituiva la CEE (Comunità Economica Europea), si è fondato sulla creazione di un mercato unico in cui promuovere il libero scambio di merci. Si può affermare senza timore di cadere in errore che durante il processo di integrazione europea sono state privilegiate le quattro fondamentali libertà di movimento (di merci, capitali, servizi e persone) fra i paesi membri rispetto alla tutela delle condizioni lavorative ed i livelli salariali. Quest’ultimo assunto ha portato alcuni studiosi a definire l’integrazione europea come integrazione “negativa”, in quanto questa ha abolito la legislazione doganale degli stati membri senza però far seguire una fase di legislazione attiva a favore del mantenimento di standard comuni per ciò che riguarda la retribuzione dei lavoratori o i loro diritti. Il primato dell’integrazione economica sui diritti sociali è stato ribadito in alcune sentenze dalla CGE (Corte di Giustizia Europea), in particolare nel caso Viking e nel caso Laval. In entrambe le situazioni l’organo giudiziario dell’UE si è espresso in favore della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell’Unione contrapposti alla libertà sindacale. È importante inoltre sottolineare che dal 2004 in poi sono stati ammessi nell’UE alcuni paesi facenti parte del cosiddetto gruppo PECO (Paesi dell’Europa Centro Orientale) come Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Romania e Bulgaria, in cui i livelli salariali e di tutela dei lavoratori erano (e tuttora sono) sensibilmente al di sotto della media UE. Un altro elemento su cui è il caso di soffermarsi è la difficoltà che i sindacati incontrano nell’organizzarsi a livello europeo. Le organizzazioni sindacali, infatti, non riescono ad avere la stessa forza che hanno all’interno dei confini nazionali sul piano sovranazionale sia poiché l’UE stessa non costituisce una piattaforma adatta perché i sindacati possano esprimere la loro influenza in modo efficiente sia perché talvolta le organizzazioni nazionali hanno atteggiamenti conflittuali fra di loro a causa di interessi confliggenti. Per tutto quanto espresso fin ora – Processo di integrazione europea che privilegia la libertà di movimento, mancanza di una legislazione europea che garantisca standard sociali, forti differenziali salariali e debolezza dei sindacati a livello comunitario- si può affermare che l’UE costituisce un ambiente in cui le dinamiche di social dumping hanno la possibilità di proliferare. Questo quadro pare essere suffragato dalla raccolta di dati statistici; secondo uno studio dell’EUROSTAT focalizzato sul periodo dal 2001 al 2006 su 11 paesi europei e la Norvegia, ben il 16% delle aziende in questi paesi hanno delocalizzato almeno parte dei processi produttivi, in buona parte – con percentuali oscillanti fra il 40% e il 70%- verso altri paesi europei. L’Italia nel periodo di riferimento si colloca perfettamente nella media degli altri paesi con circa il 16% delle aziende che hanno deciso di delocalizzare alcuni processi produttivi. La percentuale di aziende che delocalizzano sembra scendere in tutta l’UE dal 2008 in poi, ma le statistiche non sono comparabili per stessa ammissione dell’EUROSTAT poiché le aziende prese in considerazione nel periodo 2001-2008 erano di almeno 100 dipendenti mentre nei sondaggi posteriori questa soglia è stata abbassata a 50 dipendenti e la probabilità di delocalizzazione è direttamente proporzionale alla dimensione dell’azienda. In ogni caso il numero di imprese che procedono all’outsourcing di comparti produttivi è rilevante in molti paesi europei.
Il dumping salariale in Italia
In Italia, come si affermava in precedenza, il social dumping è spesso argomento di dibattito e talvolta di scontro politico. I casi della Whirpool di Napoli e della Bekaert in provincia di Firenze sono solo due dei casi più recenti che balzano spesso agli onori della cronaca. Gli attori che si vedono contrapposti in questi casi di delocalizzazione sono i lavoratori che attraverso le loro organizzazioni di categoria lottano per mantenere il loro posto di lavoro, le aziende – in questi due casi entrambe aziende multinazionali- che come attori economici il cui interesse è massimizzare il profitto agiscono razionalmente cercando manodopera laddove è conveniente e lo Stato. L’Italia ha tentato tramite il decreto dignità del 2018 di porre un limite alle delocalizzazioni; tuttavia le norme hanno effetto solo per quelle aziende che hanno avuto accesso a finanziamenti pubblici ed inoltre si concentra sulle delocalizzazioni extra-UE. Lo strumento in questione quindi appare troppo debole per avere efficacia su larga scala.
Il ruolo degli stati
Vale la pena soffermarsi a questo punto sul ruolo degli Stati nelle dinamiche di social dumping. Nei due casi cui si è fatto cenno l’Italia non ha potuto impedire in nessun modo alle aziende di delocalizzare e quindi di licenziare i lavoratori degli stabilimenti che sarebbero stati chiusi. La struttura dell’UE difatti garantisce la piena libertà di movimento alle aziende e gli stati non possono che giocare un ruolo passivo in questo contesto in quanto non possono contrastare la volontà delle aziende in maniera attiva, se non additandole come fautrici di comportamenti opportunistici. La possibilità di delocalizzare con relativa facilità ha inoltre innescato una sorta di competizione al ribasso fra quegli stati che per varie ragioni di opportunità politica o di necessità economica, si trovano a voler attrarre nel loro territorio nazionale aziende estere. Gli Stati quindi si trovano a dover adeguare le proprie politiche lavorative e salariali a standard più bassi così da attirare o mantenere gli investimenti esteri. Nel migliore dei casi, qualora gli Stati non si ingaggiassero in una corsa al ribasso, sarebbe difficile non ammettere che la minaccia di delocalizzazione costituisce perlomeno un ostacolo all’attuazione di politiche di espansione salariale o di espansione dei diritti lavorativi. Le suddette politiche salariali ed in generale la legislazione del mondo del lavoro assumono così un significato ulteriore a quello prettamente legato alla politica interna poiché vanno a costituire uno strumento di competizione fra Stati attraverso il quale questi assumono posizioni più o meno vantaggiose. In un contesto in cui le delocalizzazioni sono relativamente agevoli per le imprese, attrarre queste ultime entro i propri confini diventa un importante obiettivo per gli stati che ne hanno necessità e perciò attuare politiche salariali vantaggiose costituisce uno strumento che questi possono utilizzare per ottenere vantaggi verso gli altri attori statali.
Conclusioni
Come si è visto lo scenario è complesso e comprende diversi attori ognuno dei quali agisce secondo la sua convenienza. Molte considerazioni sono state fatte sul fenomeno di social dumping e specialmente sulle delocalizzazioni e l’arco delle opinioni verso questo fenomeno varia da una completa opposizione ad una sommessa accettazione. Al di là di queste considerazioni si può però affermare che il social dumping nell’UE e le dinamiche che gli sottendono a livello comunitario ostacolano senza dubbio l’idea- che qualcuno durante il processo di integrazione ha sostenuto ad esempio con la proposta di creazione di una costituzione europea abbandonata definitivamente nel 2007- di un’Unione Europea che si faccia promotrice attiva di crescenti livelli salariali e diritti sociali. La conflittualità che questo fenomeno genera fra lavoratori e capitale è inevitabile allo stato di cose attuale ed i primi sembrano avere in partenza strumenti piuttosto deboli per contrastare i naturali movimenti dei fattori produttivi in un contesto in cui questi sono permessi ed in cui i sindacati stentano a trovare dei canali di influenza efficienti a livello comunitario per contrastare questi spostamenti. In tutto ciò gli Stati faticano a trovare un ruolo attivo a causa della mancanza di strumenti volti a contrastare le delocalizzazioni a livello nazionale e sembrano talvolta preferire agire sulle politiche del lavoro a ribasso così da attrarre investimenti esteri
(Andrea Taborri, Geopolitica.info cc by)