La terra cremonese rinnova ancor oggi, con l’accensione di fuochi rituali, una tradizione antica, straordinariamente vecchia quanto la nostra pianura, quanto i nostri campi conquistati alla palude e al groviglio del bosco.
Nel corso dei millenni, sul confine fra il campo coltivato ed il buio della macchia forestale, si è andato a sovrapporre l’incerto ed ambiguo limine fra un qui, organico alla civiltà e alla cultura, ed un altrove, disegnato dal fascino del mito e dallo stupore dell’immaginario.
Su quel limine, su quel confine, si è pure andato a porre l’ambivalente segno del fuoco; un segno concepito nel contempo sia come forza benefica e sia come forza pericolosa e negativa, interpretato come un tratto luminescente intermedio fra l’aldiqua e l’aldilà, e soprattutto concepito, sin dall’inizio del cammino dell’umanità, come un ‘essere vivente’.
Questa concezione ci viene argomentata con dovizie di riferimenti da parte di Giacomo Devoto, nel suo Origini Indeuropee. Studi e materiali, testo pubblicato nel 1962, a cura dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze.
Il grande glottologo e linguista italiano, parlandoci del fuoco, e del culto pirico praticato fra gli Indoeuropei, scrive:<<Esso è il simbolo dell’istantaneità come dell’eternità, è un fattore di unione fra il cielo e la terra>>. Ed è proprio in tale funzione di ‘porta d’ingresso’ fra il mondo dei vivi e il mondo ‘altro’, fra contemporanei ed antenati, che il fuoco diventa pure strumento di comunicazione fra la realtà materiale e quella spirituale, e mezzo di difesa apotropaica, ossia di strumento di allontanamento delle negatività, oltre che di propiziazione, di vaticinio, svolgendo pure una funzione di sostegno magico nei confronti della forza del sole.
Il governo umano del fuoco, la sua padronanza, sono avvenuti gradualmente, uno volta superati il terrore immane provocato dalla caduta dei fulmini e l’eco terrificante prodotto dalle stesse scariche uraniche. Ancora in epoca storica, il fuoco e il fulmine erano personificati in divinità terribili: Thor, Giove, Vulcano ed altri.
Dall’alba arcaica del governo umano del fuoco fino ai nostri giorni, sul fuoco stesso si sono quindi sovrapposte credenze e visioni del mondo diverse e contrastanti, i cui strascichi si sono depositati nelle credenze e nei valori che la tradizione popolare ancor oggi gli assegna. Valori sui quali primeggia il ‘significato di purificazione e di energia vitale’, come ha scritto Paolo Toschi su Il Folklore, tradizioni, vita e arti popolari, un testo del 1967.
Dalla storia ancestrale accennata, dall’alba lontana della civiltà, è pervenuto ed è presente anche in terra cremonese un residuo, una reliquia degli arcaici rapporti fra l’uomo e il fuoco, nella sua dimensione rituale e pubblica.
E’ un fenomeno folklorico che si va a perpetuare ogni anno, attraverso l’accensione di falò pubblici interpretati come appuntamenti ineludibili.
I fuochi di gioia, che definiamo così prendendo in prestito una definizione di sir James Frazer, vengono riattualizzati anche in diversi luoghi della nostra provincia, nel desiderio di rinsaldare la precarietà dei legami con le proprie radici, e per tentare di far riaffiorare il rigo emotivo del ricordo di un’anima contadina e popolare che si è persa, frantumata e dissolta nei salti generazionali, sociali ed economici precedenti.
E’ un’anima quella che ha vissuto, nei secoli del passato, accanto al ciclo agrario della terra coltivata; un ciclo finalizzato al parto dei prodotti della terra; un tratto di tempo che, dalla semina al raccolto, è stato come illuminato e favorito dalla veglia dei fuochi protettori, posti sulla dorsale dello stesso anno contadino.
Chi ha avuto modo di osservare i falò dispersi per la campagna o per la collina, in determinati giorni dell’anno, o meglio durante certe veglie dell’anno, avrà visto come i fuochi prendano le sembianze mimetiche di tanti piccoli soli notturni.
E come la terra, artificialmente riscaldata dai fuochi rituali anziché dal sole, emani un misterioso richiamo. Da essa esce come una voce suasiva atta a richiamare la gente a stare sveglia, a presenziare al rito di sempre, a perdere la propria corporeità per trasformare le sembianze umane in ombra, nei riverberi indistinti che le fiamme creano sugli argini, sui campi, sulle piazze e sui sagrati.
In tale gioco di luci ed di ombre, in tale danza del fuoco che dialoga con i contorni del buio, si vanno a tessere brandelli di storia minuta di un popolo che conserva i tratteggi luminescenti collegati alla propria memoria etnica, al proprio passato comunitario. Anche il popolo insediato in terra cremonese, in alcuni suoi clan provinciali, si comporta così.
E nel ravvivare tale evento ciclico e costante della tradizione popolare, ci si va a collegare idealmente ai mille ‘fuochi di gioia’ che la gente, in ogni parte d’Europa e del mondo, innalza al cielo come per unire il proprio gesto rituale, la propria voce, al coro di quei minuscoli falò intermittenti, le stelle, presenti nel mistero dell’infinito della notte.
Nel loro plurimo e variegato modo di manifestarsi, anche la cultura popolare cremonese presenta, dunque, le proprie <<feste del fuoco>>, contrappuntate da paglia, legna, fascine, un fiammifero acceso, il progressivo agitarsi delle fiamme, nel mentre si dà l’avvio al banchetto collettivo a base di vino aromatizzato, ceci, castagne, e dolcetti locali.
Per noi, che abbiamo camminato per anni su questo luminescente viottolo notturno, è giunto il momento di una sosta, per trasformarci in narratori di quanto abbiamo visto, osservato, studiato.
Ovviamente, non vogliamo accreditare alla comunicazione di oggi la presunzione della completezza, ma solo la funzione di uno sguardo su di un fenomeno che, oltre tutto, in terra cremonese, è in piena espansione.
Gli ultimi falò che ho osservato da vicino quest’anno sono stati quelli di Volongo, domenica 16 di gennaio alla vigilia della festa di sant’Antonio, con un classico falò della Vecchia, ed il fuoco scenografico acceso a lato del coro che cantava gli stornelli del rituale della Merla, a Trigolo.
Il più grande fuoco che si accende nel territorio è comunque quello del Martedì Grasso, a Pescarolo, alla chiusura del Carnevale, quando viene consegnata la cenere della colossale pira combusta al penitenziale Mercoledì delle Ceneri, del giorno dopo.
A propria volta, a far da cerniera fra l’inverno e la primavera, il 19 di marzo, si accenderà, a Castelleone, il gran falò di san Giuseppe, alla cui sommità verrà posto il fantoccio dell’Inverno. A metà quaresima, si ‘sacrificheranno’, invece, il Vecchio e la Vecchia, a Persichello.
Abbiamo indicato con questi cinque falò, con quello di Volongo, quello di Trigolo, di Pescarolo, di Castelleone, Persichello, cinque varianti significative dello spettacolo pirico presente anche in molti altri luoghi della provincia.
Uno dei prototipi,chiamiamolo così, è segnato dalla presenza del personaggio folklorico della Vecchia, la Vécia, che un tempo veniva bruciata in varie ricorrenze, che ci vengono ricordate da Luciano Dacquati nel suo Ròbe de na vòolta:
il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno; il 6 di gennaio, per l’Epifania, il 17 di gennaio, per Sant’Antonio Abate; il 31 gennaio o il 1° febbraio, ultimo giorno della Merla; il giovedì grasso; il martedì grasso, ultimo giorno di carnevale; e a metà quaresima.
In alcuni rioni popolari di Cremona la ‘vecchia’ si bruciava il martedì grasso: testimoni diretti ricordano questo rito fino al 1951 a Porta Romana e a Porta Mosa. In quest’ultima zona il fantoccio, prima di essere messo al rogo, veniva portato in corteo per le strade; la gente, dietro, cantava:
Gh’éera na vécia incréespa,
la gh’ìiva nuàant’àn
la gh’ìiva i prìm afàn
e i zgrizulìin d’amóor.
E se la càanta tìpete tùpete,
e se la pìirla tìpete tàpete,
e se la vécia la vóol balàa
tìpete, tùpete, tìpete, tà.
La prima volta in cui ho assistito al falò della Vecchia in territorio cremonese, fu tanti anni fa, a Torricella del Pizzo, su uno degli argini che difendono il paese dal Po. Non mi ricordo più in quale occasione del calendario. Sono sicuro, però che fosse, il 1955. Mi fece una grande impressione. Allora, probabilmente, non pensai a nulla, se non rimanere incantato di fronte a quel fuoco.
Da adulto, invece, assistendo a questo rituale, influenzato di certo dai testi di Mircea Eliade, mi è sorto il pensiero di trovarmi di fronte alla reliquia di una cerimonia arcaica, legata al culto della Terra, della Vegetazione, della Fertilità, propiziatoria della abbondanza delle messi.
E rituale, se non agrario, nel senso datogli dallo studioso rumeno, certamente ‘agricolo’ lo si può definire ancora oggi, essendo particolarmente diffuso in ambiente rurale. Collegati con l’origine lontana sono poi i motivi esorcizzanti, scaramantici, ancora presenti e vivi nelle comunità che presenziano alla sua effettuazione.
Al di là del vezzo di abbozzare ipotesi sulle origini del falò della Vecchia, quello che mi ha maggiormente interessato negli ultimi anni è stato il ‘dispositivo di convocazione’ del rituale; dispositivo che mi ha portato a collocare lo studio di questo momento di festa all’interno della scienza del teatro e all’interno di quella vasta area estetica racchiusa dall’arco che unisce due poli: quello ludico e quello sacro.
Certo, già nell’aggettivo ludico si sprigiona una varianza di significati che possono da soli abbracciare il rituale che ho osservato moltissime volte.
Ludico deriva dal latino ludus. E ludus è il termine che Paolo Toschi ricorda avere <<il significato di festa e quello specifico di rappresentazione>>.
L’etimo, dell’altro aggettivo ‘sacro’, riflette il significato di <<deditato, consacrato a Dio e agli dei; che riguarda la religione e il culto>>. In modo figurato significa pure <<inviolabile; degno del massimo rispetto>>.
Anticamente si pronunciava ‘sagro’, e questo ci richiama la ‘sagra paesana’, la festa, tutto il paese che si risveglia, la <<festa popolare con fiera e mercato>>.
Il falò della Vecchia raccoglie requisiti sia nel ‘ludico’, sia nel ‘sacro’. Esso è gioco, spettacolo, e ricorda, nella vivacità della gente che vi partecipa, la ‘sagra’, e, come questa, esso risente di un nesso lontano, originario, quello del ‘sacro’.
Ma sta di fatto, come ha scritto Piero Camporesi, che <<il sacro è sempre reversibile nell’attributo contrario, quello del sacrilego, segno ambivalente cui è connaturata la nozione ‘positiva’ di ciò che è carico di presenza divina e quella ‘negativa’ di ciò che (…) è proibito al contatto con gli uomini>>.
Inoltre, va ricordato che ai primordi il sacro per eccellenza era <<la vita inesauribile>> che si rispecchiava negli alberi e nella vegetazione, e che corrispondeva, per usare termini cari a Eliade, <<nell’ontologia arcaica alla Realtà assoluta>>.
Da qui diventa comprensibile come l’albero, o l’arbusto, possano essere considerati da alcune popolazioni ‘primitive’ come antenati mitici della tribù.
Così come, quasi a dimostrare la dicotomia della sacralità primordiale della vegetazione, è comprensibile, quale significativo dato folklorico attestato in Europa, che la cosa più comunemente usata come ricettacolo per le malattie e per i malanni di tutte le sorta sia un albero o un cespuglio.
Ora, è proprio nell’ambivalente richiamo verso la cosmogonia primitiva della vegetazione; è verso quel mondo arcaico di sacralità che diventa trasparente il riflesso dicotomico del rituale del falò della Vecchia coglibile ancor oggi in ambiente rurale.
In esso, la simbologia del rinnovo della vita s’innesta nei bagliori di una immagine di morte, dove la comicità come effetto s’intreccia con la causa di una rappresentazione fondamentalmente tragica, e dove l’identità funeraria della Vecchia, quale strega, si sdoppia nella Vecchia stessa derisa quale buffona.
Il falò della Vecchia si trova nel mezzo del contrasto, dell’attrito fra l’Inverno e la Primavera. Da una parte, abbiamo i riferimenti ancestrali del terrore dell’inverno senza fine, vissuto dall’agricoltore primitivo, presente pure nei miti indoeuropei; dall’altra parte, invece, abbiamo il desiderio di primavera, il cui arrivo non era dato per scontato e certo, dallo stesso agricoltore primitivo, che infatti cercava, di far tornare la primavera <<con dei riti>>, come scrive Vladimir Propp in Feste agrarie russe.
Di fronte ai due elementi ciclici giustapposti, l’Inverno e la Primavera, possiamo trovare la ragione per inserire il momento critico del falò della Vecchia appunto nella linea di mezzeria, sul crinale, sulla ‘piega tellurica’ del divenire complessivo d’un tempo che si spezza, per così dire, in due.
‘Piega’ che possiamo pure chiamare ‘passaggio’ fra la stagione sfavorevole e quella favorevole e gradita.
‘Piega’ fra l’altro così ben rappresentata dalla concezione di alcuni popoli celtici che dividevano l’anno in due parti: il <<caldo>> e il <<freddo>>.
Per questo, similmente ad altre usanze analoghe, il falò della Vecchia può essere inserito nelle contese rituali fra Inverno e Primavera (o Inverno e Estate) che <<si rappresentavano, e ancora si rappresentano, in alcune zone dell’Europa centro-settentrionale>>, e delle quali si ha pure un rimando in costumanze diffuse fra gli Eschimesi, fra i quali il trapasso da una stagione all’altra si esprime mediante riti di passaggio ben caratterizzati.
Nondimeno, in tale collocazione rituale, va tenuto conto dello slittamento avvenuto nei riferimenti mentali e nei calendari che si sono impiegati nel corso degli sviluppi storici, civili e religiosi dall’epoca primitiva ad oggi; va tenuto conto del mese e del giorno considerati via via come i più adatti per celebrare la Primavera e l’Anno Nuovo.
Questa celebrazione s’ipotizza essere avvenuta in epoca arcaica nel mese di Maggio, il 1° di Maggio, con il trasporto solenne di un albero e del suo bruciamento.
Tale rito primaverile, s’ipotizza si sia spostato, nel corso delle epoche storiche, verso tempi calendariali diversi. Eliade, riportando questa tesi che è di Walter Liungman, scrive che <<in una certa zona (Balcani, ecc.), l’usanza si è spostata verso le feste di Natale e di Capodanno; nell’altra zona (Occidente), l’uso si è fissato sul Martedì Grasso (Carnevale), poi sul 1° Maggio, la Pentecoste e il giorno di San Giovanni>>.
Cosicché tale celebrazione primitiva potrebbe e può trovare rimandi nella contemporaneità sia nei rituali folklorici silvani del Maggio, sia nei rituali del bruciamento di alberi e fantocci per Carnevale.
Bisogna infatti tenere in considerazione, scrive Paolo Toschi, che <<lo spostarsi delle feste da una data all’altra anche per necessità di adattamento al clima e di altre condizioni sociali, han provocato il frequente trasferirsi da una data all’altra, o il confondersi delle forme rituali>>.
Attorno quindi alle contese fra Inverno e Primavera e al bruciamento dell’albero che rappresenta il rinnovo dell’anno, possiamo comprendere come possano essersi delineate le personificazioni del Carnevale stesso, o della Morte, o dell’Estate, dietro la cui morfologia Frazer vede <<l’idea più vasta di uno spirito della vegetazione>>.
E questa idea trova pure un riferimento semantico nei nomi dati allo <<spirito del grano maturo>>, spirito che viene pure chiamato <<il Vecchio>> o <<la Vecchia>> o <<il Morto>>.
Si ha così il passaggio dello spirito della vegetazione dal mondo degli alberi e della selva a quello dei cereali e dei coltivi.
Da feste celebrative di ‘tipo silvano’ è arguibile pensare che si sia passati a feste agrarie e della fertilità.
Le quali ultime, agrarie e della fertilità, vengono poi col tempo a coincidere con le feste commemorative dei morti. Bisogna considerare che <<presso i popoli agricoltori gli antenati donano la fertilità: essi sono all’interno della terra e di là mandano su i frutti della terra>>. La benevolenza dei defunti, quindi, deve essere conciliata>>.
Una volta <<riconciliati, nutriti e sollevati>>, i defunti <<proteggono e moltiplicano i raccolti>>.
Abbiamo così che le personificazioni delle ‘potenze’ e della fertilità del campo, concepite dai contadini come ‘il vecchio’ o ‘la vecchia’, <<comincino col tempo ad accentuare il loro profilo mitico>>, e sotto <<l’influenza delle credenze funerarie>>, esse vanno ad appropriarsi della ‘struttura’ e degli ‘attributi’ degli antenati, degli spiriti dei defunti.
Quindi tale processo corre parallelo al legame, sempre più stretto, che si viene a creare fra antenati, raccolti e vita erotica, legame che ha come riflesso l’estendersi di culti funebri, agrari e genitali, che si compenetrano sino a completa fusione.
Sul piano formale, tale legame, si sviluppa in feste caratterizzate da banchetti collettivi, matrimoni e dalla cura particolare alle tombe.
In questi giorni di festa, scrive ancora Eliade, <<i morti tornano per prendere parte ai riti di fertilità dei vivi>>. Ma anche i vivi <<hanno bisogno dei morti per difendere i seminati e proteggere i raccolti>>.
Ed è in questa direzione che si evolve la concezione religiosa complessiva. Infatti:
<<la terra madre, o la Grande Dea della fertilità, domina allo stesso modo il destino dei semi e quello dei morti. Ma questi ultimi, qualche volta, sono vicini all’uomo, e l’agricoltore si rivolge a loro perché benedicano, sostengano il suo lavoro (il nero è il colore della terra e dei morti)>>.
La compenetrazione fra riti funebri e riti agrari è per esempio evidente fra i popoli del Nord Europa, quando <<in occasione del Jul, la festa propriamente funeraria dei Germani, che cade nel solstizio d’inverno, l’ultimo covone del raccolto dell’annata è tirato fuori per farne un’effige d’uomo, di donna, di gallo, o capro o altro animale (corsivo nostro)>>.
Della qual cosa, va sottolineato l’aspetto significativo che le forme animali sotto cui si manifesta la ‘potenza’ della vegetazione <<sono le stesse che rappresentano le anime dei defunti>>.
Ed è estremamente importante ai fini della nostra ricerca che tali ultimi covoni fossero chiamati fra i Tedeschi con le denominazioni già accennate di ‘la Vecchia’ e ‘il Vecchio’.
Così pure è interessante il rimando semantico che si ritrova in ben altro ambiente geografico. Infatti, anche in Arabia, l’ultimo covone è chiamato ‘il Vecchio’.
Esso <<è mietuto dal padrone del campo in persona, messo in una tomba e sepolto con preghiere invocanti che ‘il grano rinasca dalla morte alla vita’>>
Per indicare l’ultimo covone, si hanno anche altre denominazioni che stanno però tutte a rappresentare simbolicamente l’intreccio fra vita e morte, fra fecondità e ritualità funeraria.
Infatti, tali denominazioni, scrive Ernesto De Martino, accennano <<ora al languore o addirittura all’estinguersi di una energia numinosa decrepita a cui sta per essere procurata la morte (‘il vecchio’, ‘la vecchia’, ‘la morte’), ora alla epifania di una forza giovanile immacolata (‘la vergine’), pronta a nozze feconde (‘la sposa’).
Nella varietà delle denominazioni date all’ultimo covone si specchia la parallela polivalenza di significati collegati alle feste della fertilità e dei morti.
Ed in tale polivalenza di significati va pure collocato il falò della Vecchia in area padana e cremonese. Ovverossia, significati d’ordine satirico, sociale e politico che, di volta in volta, la storia delle comunità ha posto in essere parallelamente al falò della Vecchia.
In questo senso va collocato il falò della Vecchia col viso caricaturale di De Gasperi, in piazza Marconi, nel 1953 a cura della redazione del giornale della destra studentesca ‘Il Mappamondo’, oppure il falò della Vecchia di quest’anno, sul cremasco, a cura di Sinistra e Libertà, dove il pupazzo da bruciare voleva rappresentare l’intero governo Berlusconi. Anni fa, da Gambara, nella Bassa Bresciana, ricevetti una foto della Vecchia da bruciare, che rappresentava invece le malefatte del governo del mite democristiano Goria. Era quello un rogo curato dalla locale sezione dell’ARCI, contrapposto, nello stesso paese, ad un altro falò acceso, lo stesso giorno, il 17 di gennaio, dall’Azione Cattolica del paese, in una rivisitazione pirica della saga di Peppone e Don Camillo.
Questo fenomeno parodico, finalizzato alla satira politica e alla protesta, è proprio anche del primo documento scritto che ho rintracciato sul falò della Vecchia in Italia. E’ del 1578. Lo cita Peter Burke, docente all’Università di Cambridge, ed autore del libro Cultura popolare nell’Europa Moderna. Lo studioso attesta che a Bologna, in quel 1578, fosse stato acceso il rogo della Vecchia – come raffigurazione della Quaresima – per beffare l’allora arcivescovo Gabriele Paleotti che in quell’anno <<aveva denunciato gli spettacoli teatrali>>.
Altrettanto, in segno di burla, è stato intitolato il rituale di Maggi, frazione di Sant’Agata Bolognese, nel 1986, del quale fui testimone oculare, con la denominazione ‘Vecchia ecologica’, per deridere l’amministrazione comunale del paese che aveva vietata – con giusta ragione aggiungo ora – l’accensione di vecchi copertoni d’automobile.
Abbiamo, così, una manifestazione di funzioni cultuali e rituali varie, una molteplicità di significati attribuibili al falò della Vecchia.
E questa molteplicità ci permette di poter dire della Vecchia quanto Burke ha detto del Carnevale, ossia che anche la Vecchia è ‘polisemica’, <<significando cose diverse a persone diverse>> e significando cose diverse in tempi e luoghi diversi.
Per rimanere a Cremona, alla Vecchia fu dato pure un nome specifico, quello di Vécia Pezèera. Avvenne, nel 1982, nella festa d’inverno denominata I dé de la fümàana, ‘I giorni della nebbia’ al rione Giuseppina, dove la Vecchia è stata bruciata in piazza De Lera. La cosa si è ripetuto dal 1982 al 1988. Prima della condanna al rogo, avveniva un processo senza difesa. Un irregolare processo, dunque, con finale scontato. L’accusa veniva esercitata leggendo tutte le malefatte succedute l’anno precedente, la cui colpa veniva addossata esclusivamente a lei, alla Vecchia. Nel 1982 il poeta Gigi Manfredini scrisse il seguente testo d’accusa, dal titolo Cantàada per el fugòon de la vécia Pezèera, ‘Cantata per il grande fuoco della vecchia Pezèera’:
Vàarda bèen, vécia Pezèera:
chì gh’è próont la masulèera
pareciàada da Cremùna,
bröta vécia bezuntùna,
per brüzàate in sö la légna,
bröta vécia cun la tégna.
Guarda bene, vecchia Pezèera:
qui è pronta la catasta di fascine
approntata da Cremona,
brutta vecchia sporca d’unto,
per bruciarti sulla legna,
brutta vecchia con la tigna.
Scùulta bèen per che rezòon
te fùm móorer sö ‘l fugòon,
té cun töt chèl che de dàn
te gh’èet fàt a tàanti istàn,
té cun töt chél che de gràm
gh’è a ste móont cùma la fàm!
Ascolta bene per quale ragione
ti facciamo morire sul fuocone,
te con tutto quel che di dannoso
hai fatto a tanti quest’anno,
te con tutto quel che di sgradevole
c’è a questo mondo come la fame!
In sö ‘l fóoch la to cundàna
tàanta gèent che la sgangàna;
in de ‘l föm e in sö la bràaza,
tàanta gèent che vóol na càaza;
sot la sèner stufegàada,
tàanta gèent in sö la stràada!
Sul fuoco la tua condanna
per tanta gente che tribola;
nel fumo e su le braci
per tanta gente che vuol la casa
sotto la cenere soffocata
per tanta gente senza tetto.
Brüüza, brüüza, vécia gòoza,
e con te chi töt ‘l ingòoza!
Brüüza, brüüza, vécia infàma,
e cun tè chi ‘l móont ‘l afàma!
Brüüza, brüüza vécia sghèra,
e cun tè chi vóol la guèra!
Brucia, brucia, vecchia con i gozzi,
e con te chi tutto ingozza!
Brucia, brucia, vecchia infame
e con te chi il mondo affama.
Brucia, brucia, vecchia sgherra
e con te chi vuol la guerra.
Brüüza, brüüza, vécia gòoga,
e cun tè chi ‘l vèent la dròoga!
Brüüza, brüüza, vécia stréa,
e cun tè chi a ‘l móont la bréa
el vóol méter cun la fòorsa
per saràal in de na mòorsa!
Brucia, brucia, vecchia goga,
e con te chi vende la droga!
Brucia, brucia, vecchia strega,
e con te chi al mondo la briglia
vuole mettere con la forza
per chiuderlo in una morsa!
Brüüza, dòonca, bröta vécia,
cun el màal ch’in tè ‘l se spécia,
che, cun chéesta cerimònia,
brüüzum àan la marsimònia
de sté móont che, per dumàan,
el póol esèr püsèe sàan!
Brucia, dunque, brutta vecchia,
con il male che in te si specchia,
che, con questa cerimonia,
bruciamo anche il marciume
di questo mondo che, per domani,
possa essere più sano.
Al termine delle accuse con tanto di verdetto scontato veniva lasciata la possibilità alla Pezèera, interpretata da un attore in maschera, di leggere il proprio testamento. Ecco cosa disse, in uno di quei processi, la maschera della Pezèera, leggendo el testamèent predisposto dalla sua consulente notarile, la poetessa Uliana Signorini Romanenghi. Da questa sua pagina di folklore vissuto sulla scena, ci raggiungono i segni di un tempo da noi lontano poco meno di trent’anni.
TESTAMÈENT
Me ghe làsi gnàan en ghèl
né a Cumöön, né a préet né a neóot
ma a töti i càan de’l riòon
che j udùli töta nòt
de s’ciancàave cràpa e scartòs!
Io non lascio nemmeno un quattrino
né al Comune, né al prete né ai nipoti
ma a tutti i cani del rione
che ululino tutta notte
da schiantarvi la testa e le orecchie!
Paricèe püür la fugàja
per brüzàa la me carcàsa
che ve s’ciòpi la piucèera
la v’ingüüra la Pezèera!
Apparecchiate pure il fuoco vivo
per bruciare la mia carcassa
che vi scoppi la zazzera
vi augura la Pezèera!
E töti chèi che cu’l ‘Còntrol’
i vóol mìia fàa de fióoi
ghe ‘n regàli ‘n benasóol
na gnalàada bèen s’intèend,
de ciapàan na scupasàada
àn per àn e chèi vegnèent!
A tutti quelli che col ‘Còntrol’
non vogliono avere dei figli
gliene regalo una tinozza
una nidiata ben s’intende,
di riceverne una buona quantità
anno per anno e quelli a venire!
Straminèent per la vìa Casteleòon
me ghe làsi i cupertòon
a le càare cunsuréle,
che tèen sö la tradisiòon!
Sparpagliati per la Castelleonese
io lascio i copertoni
alle care consorelle,
che tengono alta la tradizione!
Paricèe…
Apparecchiate…
I me debìt me ghe làsi
a j ufìsi de le tàse
ghe se crépi le ganàse
a sté slàander…pujanàse!
I miei debiti li lascio
agli uffici delle tasse
che gli si crepino le ganasce
a questi sciattoni…uccellacci da preda!
Làsi apartamèent e cà
a i gàt néegher menagràm
cuzé a chèi superstisiùus
ghe fòo vigne el simùr!
Lascio appartamenti e case
ai gatti neri menagramo
così a quelli superstiziosi
gli faccio venire il cimurro!
Per ööltim làsi…
i me bòodi e regipèt
a le regàse ‘Coccodè.’
Cuzé a fòorsa de ‘cacao meravigliao’
le ve fà diventàa töti ‘imbecilao’!
Per ultimo lascio…
i miei bodi e il reggiseno
alle ragazze ‘Coccodè’.
Così a forza di ‘cacao meravigliao’
vi faranno diventare tutti ‘imbecilao’!
E adès a rìtm de ròch
ve càanti cuzé:
Brüzèe pür töti i me òs
Gèghegeghegeghegè
Me ne fréeghi de la mòort
Geghegheghegeghegè
tàant indrée ghe végni amò
geghegeghegeghegiò!!!
Ma la giuria ed il popolo rimasero anche quella volta indifferenti ai rimescoli della Pezèera e dissero in coro, leggendo il copione sempre predisposto da Uliana:
Bröta slàandra, rustìs bèen
e in sèner àan i to dèent
casarùm per jà cu’l vèent:
che de té pö gnàan na brìiza
rèesti chì a fàa sensìiga.
Brutta donna di malaffare, arrostisci bene
e in cenere anche i tuoi denti,
cacceremo via col vento:
che di te più nemmeno una briciola
resti qui a farci prurito.
Te farùm en monümèent
cun el giàs inchiculèent,
scrivarùm in sö ‘n cartél:
<<Vécia e màarsa de servél>>.
Ti faremo un monumento
con il ghiaccio impiastricciato,
scriveremo su un cartello:
<<Vecchia e marcia di cervello>>.
Alla fine del processo, la pronuncia della sentenza di morte, veniva scandita anche dal pubblico, costituito in prevalenza da ragazzi divertiti:
A’l fugòon! A’l fugòon!, ossia ‘Al grande fuoco!’, ‘Al grande fuoco!’.
La Vecchia veniva allora condotta al rogo, in corteo, al canto di salmodie carnascialesche.
Nel 1984, queste salmodie vennero intonate dai ‘Cantilenanti bianchi’, maschere incappucciate appunto con bianchi lenzuoli.
Nel 1987, altre litanie furono registrate su nastro e diffuse da un altoparlante fissato su un’automobile che procedeva davanti al corteo, che rispondeva come da copione.
La voce su nastro diceva:
Bröta vécia sabelùna…
(Brutta vecchia dalle gambe sbilenche)
E il corteo rispondeva in coro:
La te brüüza incóo Cremùna!
(ti brucia oggi Cremona)
Quindi ancora la voce registrata:
Bröta vécia sacagnèenta…
(Brutta vecchia ‘malmenata’…)
Ed il coro dietro:
De brüzàate l’è cuntèenta!
(Di bruciarti è contenta)
E poi ancora dall’altoparlante:
Bröta vécia saculùna…
(Brutta vecchia ‘che ha poca cura dei propri abiti’…)
E la gente ripeteva il ritornello:
La te brüüza incóo Cremùna!
Quindi un’altra provocazione in attesa della rima baciata:
Bröta vécia saculèenta…
(Brutta vecchia sporca di fango…)
Al quale si rispondeva ovviamente:
De brüzàate l’è cuntèenta!
E così via, per altre ottantatre aggettivazioni offensive predisposte, come la precedente ‘cantata’ che abbiamo ascoltato in precedenza, dal poeta Gigi Manfredini.
Per quanto riguarda gli appuntamenti calendariali dei falò, i primi fuochi dell’anno, oggi in territorio cremonese, che presentano pure la Vecchia da immolare, sono quelli di Volongo ed Ostiano, il 17 di gennaio.
Anni fa, mi ricordo di aver visto piccoli fuochi accesi, in tale data, dietro alle cascine, anche vicino a Pessina. Durante i miei studi sulle tradizioni popolari ho ritrovato citato il falò di Volongo pure da Vladimir Propp, il grande folklorista russo. Però lo collocava in provincia di Verona. Un piccolo errore geografico che gli ho sempre perdonato.
Il falò di Volongo, che ho osservato per anni, grazie anche alle puntuali segnalazioni di merito di Ezio Tira, è una piramide a quattro lati, fatta con fascine di tralci e sarmenti residui di potature, alta sempre non meno di venti metri e sormontata dal fantoccio di stracci e paglia della Vecchia.
Nei tempi passati è sempre stata la devozione nei confronti di Sant’Antonio Abate il ‘motore’ che spingeva a lavorare tanto, pensando al particolare legame che la tradizione popolare ha assegnato all’anacoreta egiziano nei confronti degli animali da soma e da cortile, vero patrimonio per l’economia rurale.
Altro significato che la gente dava al falò era quello di volersi sbarazzare dell’inverno accendendo il fuoco più imponente possibile, in modo tale da farlo avvicinare al cielo, per far capire alla cupola uranica deificata che i contadini erano ormai stanchi della stagione invernale.
Inoltre al falò era data la funzione di traguardare il futuro, anticipandone la visione attraverso la dinamica ed il movimento progressivo delle fiamme.
Infine, vi era la Vecchia considerata come il deposito, l’insieme di tutte le cose brutte accadute durante l’annata da poco conclusasi, cose ovviamente da annientare col fuoco purificatore. Nella zona attorno a Volongo ed Ostiano, si bruciano falò per il 17 di gennaio, anche a Gambara e Fiesse, in provincia di Brescia, e a Fontanella Grazioli e Sorbara di Asola, in provincia di Mantova.
Ad accompagnare il falò a Volongo, in modo degno, ci pensa la gastronomia locale. Si usa infatti consumare il brazaróol (salciccia alla griglia con polenta abbrustolita), i tortelli di zucca e la celebre ‘torta dura’, la sbrizulùuza.
Un tempo si facevano a Volongo cinque o sei falò, uno per ogni rione. Ed erano in concorrenza fra di loro. Spesso la festa finiva in osteria, dove ci si scaldava anche col vino buono e con canzoni dalle strofette non proprio castigate, come quelle raccolte direttamente da Nanni Svampa e Amedeo Vergani sul libro illustrato Giobbian, dove la dimensione d’inizio del Carnevale rurale prende il sopravvento su qualsiasi altra dimensione, e dove la cosiddetta licenza prende la mano al linguaggio con forti citazioni stercorarie, oltre che goderecce in riferimento all’eterno femminino.
Dopo i fuochi di Sant’Antonio vengono sul nostro territorio i fuochi della Merla, gli ultimi tre giorni di Gennaio o gli ultimi due giorni di questo mese ed il 1° di febbraio. Qui non sempre i fuochi sono collegati al bruciamento della Vecchia.
Nei paesi di Crotta d’Adda e di Cornaleto, si bruciano infatti, l’ultima sera del rituale caratterizzato dai canti responsoriali, i fantocci carnevaleschi di Martino e Marianna. A Trigolo, invece, si accende un grande falò per tutte le tre sere senza alcun fantoccio. Durante queste serate viene distribuito al pubblico vino rosso bollito e aromatizzato con mele cotte, prugne secche e chiodini di garofano.
A Crotta e Meleti vengono distribuiti, nei relativi oratori, dove tutti i canterini si riuniscono, o al di qua o al di là dell’Adda, a sere alterne, pure torte e panini con grandi fette di salame bollente, ovviamente annaffiati dal vino.
L’antropologo Giancorrado Barozzi su un articolo intitolato ‘I riti del fuoco e del fumo nella Lombardia orientale’, pubblicato su Fuochi Rituali, testo curato da Fabrizio Merisi, a compendio di un convegno di studi tenutosi a Pescarolo il 21 e 22 ottobre 2005, ha descritto così la sua osservazione sui falò della Merla.
<<La notte del 31 gennaio dell’anno 2000, l’ultimo dei tre giorni cosiddetti della Merla, mi ero recato, in compagnia dei miei collaboratori Antonia Bertocchi e Mario Varini, nel paese di Crotta sulle rive dell’Adda, per documentare il rito della Merla. Sulle sponda del fiume che lambisce quel borgo rurale del Cremonese, ai piedi di una piazzetta dominata dalla statua di San Cristoforo, protettore dei traghettatori, gli organizzatori del rito avevano acceso dopo il tramonto un maestoso falò al quale, di lì a poco, sull’argine della sponda opposta (dalla parte di Meleti, nel Lodigiano) rispose un secondo fuoco. Tra i due falò scorrevano le acque notturne del fiume ravvivate dalle fiammelle galleggianti di centinaia di piccoli moccoli portati dalla corrente e dalla sagoma luminosa di una Merla di enormi proporzioni, ‘icona pop’ simile a un’insegna da tirassegno, disegnata con decine di lampade a incandescenza, alimentate da una batteria e fissate sopra una zattera ancorata al centro dell’Adda. La presenza dei due falò che rischiaravano le rive del fiume e di queste tremule luci a pelo d’acqua contribuiva a creare una notevole suggestione estetica che connotava in modo assai efficace la festa>>.
Questo scenario, caratterizzante il folklore cremonese, è stato descritto, come abbiamo sentito, con grande efficacia. Confermo il fascino di questa ambientazione per avervi partecipato anch’io per più di vent’anni. Lì, sulle rive dell’Adda viene sempre creata una dimensione di grande suggestione.
In alcuni anni mi è capitato di vivere questo momento in mezzo ad un nebbione incredibile. I due fuochi sembravano avvolti da una soffice bambagia. Persino le voci da una parte all’altra del fiume sembravano giungere a fatica.
Non so se il rituale dei falò della Merla venga riprodotto, oltre che in manifestazioni pubbliche, organizzate da parrocchie, Comuni e Pro Loco, anche da parte di privati, da singole persone davanti alle proprie case.
Una esperienza di questo tipo io l’ho fatta presso l’abitazione di Luciano Dacquati, la cascina Boccansolo, al confine fra il Comune di Cremona e Bosco ex Parmigiano, dove per diversi anni sono stato ospite, in uno dei giorni della Merla, e dove fu acceso, per l’appunto, il falò con relativa Vecchia da immolare, avendo quale sfondo l’inceneritore di Cremona, il tempio massimo del calore distruttore.
Fra i partecipanti di questo rituale folklorico domestico, ristretto ad un gruppo di amici, vi era pure la poetessa Franca Piazzi Zelioli. Conservo una nota che mi dice che quello fosse il 31 gennaio 1999. Per la circostanza la poetessa scrisse una lirica dal titolo Stanòt amò cantarùm, ‘Questa notte canteremo ancora’. E si cantò infatti di fronte al falò nel mentre in cima la Vecchia scontava i suoi torti.
La poesia dice:
Se impìsa stanòt sö i segràat
de le céeze de i nòoster paées
i falò de la Mèerla.
Se svàalsa i fugòon
da i bròch sèch sechèent
che ingrügnàat in de’l cóor
i gh’àa i guài de la gèent.
Si accendono stanotte sui sagrati
delle chiese dei nostri paesi
i falò della Merla.
S’alzan le fiamme
Dai rami secchi
che tengono chiusi nel cuore
i guai della gente.
In de ‘l lööster céel de genàar
bambàana la vécia
In d’i so stràs inturcèenta,
intàant che se svàalsa
da töta la gèent – e l’è tàanta –
el cantàa de na vòolta, sèemper ‘l istès:
stòorie de nièent, ma pièene d’i guài
de chèla pòoera gèent
cun le màan düüre de cài,
che inturciàada in d’i sialpòon,
cun capél e tabàr (e ‘l cóor gréef)
in de’l fóoch de la vécia
la slümàava vergóta de nóof.
Nel limpido cielo di gennaio
dondola la vecchia
avvolta nei suoi miseri stracci
mentre s’alzano
dai presenti – e sono tanti –
immutabili, i canti di una volta:
storie di tempi passati e lontani
che narravano la vita dei contadini:
storie da nioente, ma piene di guai
di quella povera gente
con le mani dure di calli,
che avvolta in ampie sciarpone,
con cappello e tabarro (e il cuore pesante)
nel rogo della vecchia
cercava qualcosa di nuovo.
Stanòt amò cantarùm
de la Mèerla le véce cansòon,
inturciàat in càalde pelìce
giübòt e sialpòon perché sèen
in de’l móont catìif e balòs,
gh’è tàanta mizéeria!
(en sgrìizol me cùr in d’i òs).
Stanotte ancor canteremo
della Merla le vecchie canzoni
avvolti in calde pellicce,
giubbotti e mantelli, perché sempre
nel mondo cattivo e crudele,
c’è tanto dolore!
(un brivido dentro mi corre).
e àanca se ‘l cóor
el pàar pièen de alegrìa
gh’ùm töti vergót
de scartàa, de sbàteghe vìa,
dèent in de’l fóoch de la vécia
che la brüüza piàan piàan
e àanca nuàalter sperùm
che siès püsèe bèl el dumàan!
e anche se il cuore
sembra pien d’allegria
abbiamo tutti qualcosa
da eliminare, da gettar via,
dentro, nel fuoco della vecchia
che brucia pian piano
e anche speriamo
che sia migliore il domani!
Nel panorama della ritualità del falò dell’intera Italia settentrionale vi è un caso del tutto particolare, che ne fa un caso unico nell’area folklorica della pianura padana: è il rogo del martedì grasso che viene acceso in piazza a Pescarolo; un rogo, en falòch per usare un termine caro alle persone più anziane, formato da una montagna di legna e ramaglia appoggiata ad una quercia, ad una rovere.
Mentre la gente effettua tre giri scaramantici attorno al fuoco, tutto brucia, tutto diventa cenere, tranne la quercia in mezzo, che perde i rami e gli ombrelli appesi in alto, ma non il fusto, che esce vincente dal duello con le fiamme, in una impressionante contesa che vede, come scrive Fabrizio Merisi, <<questo grande animale vegetale che non cede al fuoco>>, nel finale di una sceneggiatura popolare che vede lo sradicamento della pianta, l’attraversamento del paese, e l’erezione della quercia.
Significativa è la testimonianza che ne dà il folklorista Italo Sordi, quando dice dell’albero vincente sul fuoco:<< Eccezionale è anche il fatto che l’albero sopravviva e che non sia ‘rubato’, e che venga anzi restituito cerimonialmente al suo proprietario. Per converso, mentre normalmente i rituali dell’albero (relativi al carnevale o al calendimaggio, in particolare) vengano gestiti in toto da gruppi ristretti di persone – tipicamente i coscritti dell’anno – qui tutta la popolazione, compresi donne e bambini – contribuisce simbolicamente a trascinare la pianta in paese, fingendo di tirare insieme la lunga corda che è stata legata al trattore che in realtà la trasporta: rappresentazione evidente del fatto che la partecipazione al rito è un evento che riguarda e coinvolge l’intera comunità e non suoi particolari componenti a esclusione di altri>>.
Interessanti, sul piano dell’analisi, sono pure gli ulteriori atti cerimoniali che avvengono durante il trasporto dell’albero lungo la via principale del paese.
Il corteo, infatti, sosta presso alcuni cortili, dove è stato preparato un generoso rinfresco, a cui tutti possono prendere parte. Dalle finestre di qualche casa vengono lanciati in quantità dolci e caramelle, che i bambini si disputano.
Sordi si chiede, a questo punto, chi possa essere il vero destinatario di quelle offerte. E risponde a questa intrigante domanda, così:<<Credo che si possa sostenere che è l’albero stesso, che rappresenta il carnevale che viene introdotto in paese>>. Anche i banchetti attorno alla Vecchia avevano la stessa funzione. Infatti la Vecchia è considerata un alter ego del Carnevale.
L’albero della quercia, della vecchia quercia, al pari del pupazzo della Vecchia, è il segno e la materializzazione del carnevale in collegamento col fuoco. Si hanno, infatti, forme di personificazione o di umanizzazione vera e propria dell’albero, come ad esempio esso viene vestito, come una persona, o se ne celebra il funerale. In tutti i casi l’albero-carnevale viene distrutto dal fuoco: uno dei tanti modi per dichiarare che il carnevale è finito.
La vulgata popolare vuole che la tradizione del falò sia nata in relazione alla peste manzoniana, quella del 1630-31, e quindi all’esigenza allora di esorcizzare e purificare. Sono però talmente pregnanti i segni di collegamento di questo rito con altre manifestazioni europee, che è possibile congetturare un’origine molto più lontana nel tempo. Quella quercia annuale sradicata di Pescarolo, portata in paese in corteo, rimanda in modo notevole ai riti del Maggio, e all’arcaica religione silvana di cui parla il padre della scienza moderna del folklore, sir James George Frazer.
Il nostro racconto, che si sta per concludere, s’inserisce nel bisogno che abbiamo tutti di conoscere da dove siamo venuti, s’inserisce nel bisogno di storia che ha la vita stessa nel procedere verso il futuro.
O per concludere veramente diciamo, prendendo a prestito quanto scrisse Friedrich Nietzsche in Sull’utilità e il danno della storia per la vita, che <<di storia ha bisogno colui che guarda indietro, con fedeltà ed amore, verso il luogo onde proviene, dove è divenuto; con questa pietà egli per così dire paga il debito di riconoscenza per la sua esistenza. Coltivando con mano attenta ciò che dura fin dall’antichità, egli vuole preservare le condizioni nelle quali è nato per coloro che verranno dopo di lui – e così serve la vita>>.
Agostino Melega
(appunti scritti per una conferenza a Cremonabook - Sabato 12 MARZ0 2011, ore 18.00)
2013-10-24


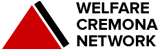
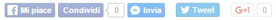












![L’ENÈEIDE IN DIALÈT CREMUNÉES . Traduzione di A.Melega (Cr) [1°parte]](https://www.welfarenetwork.it/media/2022/05/91592/f1_2_l-eneeide-in-dialet-cremunees-traduzione-di-agostino-melega-cr-prima-parte.jpg)










