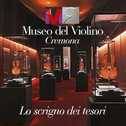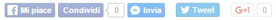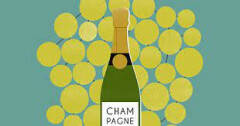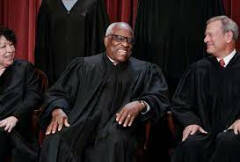Ivetic lo afferma molto chiaramente “nel Mediterraneo c’è un ulteriore mare che lo riassume. L’Adriatico è il Mediterraneo del Mediterraneo, è il corridoio marittimo che ha unito l’Oriente con l’Occidente per oltre un millennio”: mille anni di Venezia (ducato, comune e repubblica), 850 anni del Sacro romano impero, 816 anni di regno d’Ungheria e di Croazia, 542 anni di Asburgo, 443 anni di Impero Ottomano, 400 anni di repubblica di Ragusa, 150 anni di Italia unita, 73 anni di Jugoslavia.
Un Adriatico delle diversità, un mare confine, una “pianura liquida”, un “mare boreale, superiore” e, in definitiva, “un’area di diversità”. In ogni parola che Ivetic utilizza per descriverlo, troviamo una sorta di magnetismo verso il potenziale poetico del mare, verso la sua innata forza narrativa.
Grandissima importanza riveste il tema delle identità, affrontato con grande coraggio. Scopriamo ad esempio che durante la Serenissima la questione dell’identità aveva un significato secondario rispetto alle necessità della vita economica e che lungo la costa era diffuso il bilinguismo. Quindi fu proprio “lungo l’antemurale dalmata che si era sviluppato un mondo latino, italiano e croato, mentre nell’interno della provincia si erano situate popolazioni di fede ortodossa serba”. Siamo di fronte a secoli di convivenza linguistica e culturale, al giorno d’oggi un miraggio nel deserto.
Come si evince, buona parte del libro è dedicata, giustamente, a Venezia, la Dominante, che trasformò l’Adriatico nel suo Golfo, ne fece il suo “mare vettore”, un sistema di scambi e di commerci trasversali alla regione balcanica, tra Oriente e Occidente; un “mare integrato” incentrato sulla grandezza economica, politica e marittima di Venezia.
Il tracollo della Serenissima fu rapido e fu il primo di quelli che Ivetic chiama “sfaceli adriatici”: l’Austria-Ungheria nel novembre 1918, la prima Jugoslavia nell’aprile 1941, l’Italia fascista nel settembre 1943 e infine la seconda Jugoslavia nell’estate 1991.
Ed è proprio dalla caduta di Venezia nel 1797 che secondo il nostro inizia quello che definisce un “lungo Ottocento” che termina nel novembre 1918 con il tramonto dell’Austria-Ungheria. Questo periodo ha visto trasformarsi l’Adriatico “da luogo in geografia: l’azione dell’uomo puntava a ridefinire il territorio litoraneo […] Non più comunità sparse lungo la costa, ma il litorale inteso come una frontiera che andava difesa dallo stato, studiata dagli scienziati, interpretata dai viaggiatori come un tema narrativo”. Ed è in questo momento che si apre una frattura nella convivenza tra i popoli adriatici, è proprio in questo periodo che “tra geografi civili e militari, matura la mitologia del confine naturale dello stato nazionale: l’estrema Italia era un arcipelago che si snodava da Trieste a Zara, con i suoi dialetti veneti, la sua storia e cultura, le navi, le industrie, la cucina, le tradizioni. Questa estrema Italia era anche l’estrema Slavia, lì attaccata”.
Il “confine orientale” italiano divenne quindi “un vero e proprio mito, il coronamento del risorgimento nazionale, la prova della forza e della maturità della nazione. In più c’era la mistica del confine geografico, dello spartiacque, del monte Nevoso”.
È in questo contesto che si affaccia un nuovo mare, la modernità marittima divenne di dominio mittelleuropeo, Trieste e Fiume ne rappresentarono la potenza economica e culturale. Trieste toccò i 240mila abitanti nel 1913 (quarta città dell’Austria Ungheria dopo Vienna, Budapest e Praga), la comunità slovena ne contava 50mila, più della stessa Lubiana. Se fosse stata attribuita alla Jugoslava sarebbe stata la seconda città, dopo Belgrado. Ivetic la definisce, in modo sognante, una “Marsiglia Jugoslava”, mai definizione fu più azzeccata.. Fiume invece è stata una “sezione metropolitana di Budapest”, qui “l’Europa danubiana si avvicinò al Mediterraneo”. Nel 1910 la popolazione che si professava di lingua italiana era il 48%, di lingua croata il 26%, la componente ungherese il 13%, seguivano le comunità tedesche, slovene, serbe, slovacche, ceche rumene, rutene, polacche e inglesi. La presa della città da parte di D’Annunzio nel settembre 1919 “fu la compensazione, cercata ancora una volta nel Quarnero, per le frustrazioni subite durante il primo conflitto mondiale. Fiume fu, come Zara, l’Italia estrema.”
Ivetic, grazie anche a una grande capacità di scrittura e alla precisione dei dati numerici che fornisce, ci fa sognare epoche che avremmo voluto vivere, ci fa entrare nella storia calandoci perfettamente nel fermento culturale delle città costiere, nelle geografie del territorio, respirando le ariose parlate cosmopolite o facendoci soffocare di rabbia per le nefaste vicende nazionaliste che si sono susseguite.
L’occupazione italiana delle coste adriatiche fu vissuta in Italia come la “prova della vittoria”, ma per la controparte “fu una prevaricazione rispetto alla situazione civile e politica prima del 1918, anche perché a parte Zara, negli altri centri della Dalmazia governavano da tempo i croati”. Quello italiano “fu un atteggiamento padronale, come se in virtù della vittoria fosse tutto dovuto. E a ciò va aggiunto un sentimento di superiorità dell’italianità, come cultura, lingua, civiltà”.
Adriatico, quindi, anche come mare della sofferenza e del dolore (quale mare, del resto, non lo è?), è il mare del campo di concentramento di Arbe, della risiera di San Saba e dell’esodo degli italiani. Ivetic afferma che, “a seconda delle interpretazioni si parla di 250.000 a 350.000 persone”, istriane, fiumane e dalmate che abbandonarono la loro terra natia.
A voler parlare di storia culturale dell’Adriatico, dice il nostro, “si potrebbe ragionare in termini postcoloniali, riconoscendo nel passato una cultura dominante e una cultura dei sottomessi o marginali”. Il rapporto tra l’Italia e l’Adriatico orientale “non sarebbe diverso da quello che c’era tra le metropoli e le loro colonie, come tra la Francia e il Maghreb”. Affermazione, quest’ultima, che rende bene l’idea del dominio coloniale italiano.
La Jugoslavia socialista divenne poi un (o il) paese novecentesco, più adriatico di quello che si pensi, in cui era contemplato un Adriatico jugoslavo e una mediterraneità jugoslava: “Si era slavi ma affratellati con i popoli latini nella condivisione del Mediterraneo”.
Infine, ragionare sull’Adriatico significa per Ivetic, “fare i conti con il suo essere un confine. Ogni pensiero adriatico, ogni ricerca sulle sue identità, diventa un pensiero di confine. E la posizione di confine comporta rischi grandi, di non essere né l’uno né l’altro, di essere periferia di entrambi i mondi che vogliono congiungere”.
(Matteo Pioppi, OBC Transeuropa cc by nc nd)